| ||||||||
 Quello del giornalista non è mai stato un mestiere facile nella regione post-sovietica, ma in Ucraina si segnala un netto peggioramento negli ultimi mesi. La fuga di notizie del sitoMyrotvorets e l’omicidio, a luglio, del giornalista Pavel Sheremet sono solo la punta dell’iceberg del nuovo clima instaurato ai danni dei reporter, di ogni nazionalità, che coprano argomenti ritenuti sensibili dai dirigenti del Paese. Quello del giornalista non è mai stato un mestiere facile nella regione post-sovietica, ma in Ucraina si segnala un netto peggioramento negli ultimi mesi. La fuga di notizie del sitoMyrotvorets e l’omicidio, a luglio, del giornalista Pavel Sheremet sono solo la punta dell’iceberg del nuovo clima instaurato ai danni dei reporter, di ogni nazionalità, che coprano argomenti ritenuti sensibili dai dirigenti del Paese.Myrotvorets scheda i giornalisti Un sito nazionalista ucraino sin ad allora sconosciuto, “Myrotvorets” (Il Conciliatore), lo scorso maggio e poi di nuovo in agosto, ha pubblicato i dati personali di oltre 4mila giornalisti ucraini e stranieri che avevano richiesto l’accredito stampa rilasciato dal Ministero dell’Informazione della cosiddetta “Repubblica del Popolo di Donetsk” per visitare e operare nei territori da essa controllati. In questo modo, giornalisti appartenenti alle più importanti testate internazionali, inclusa la Rai, hanno trovato il loro nome sul sito in questione e sono stati additati come cooperanti con le “organizzazioni terroristiche” che occupano l’est del Paese. I giornalisti elencati, soprattutto coloro che risiedono in Ucraina, vivono ora nel timore costante di subire rappresaglie da parte dei cosiddetti gruppi di “cittadini patriottici” ucraini. Secondo l’Istituto d’Informazione di Massa (IMI), l’ufficio del Procuratore Generale a Kiev ha registrato 113 reati - inclusi attacchi fisici, danni alla proprietà, e ostruzione di attività professionali - nei confronti di giornalisti, solo nella prima metà del 2016. Nei due terzi dei casi si tratterebbe di atti commessi non dalle forze dell’ordine o da funzionari pubblici, ma da privati cittadini. L’omicidio Sheremet Il 20 luglio, il giornalista bielorusso Pavel Sheremet è rimasto ucciso in un attentato con autobomba nel centro di Kiev. Sheremet - che aveva ricevuto nel 2002 il premio per il giornalismo e la democrazia dall’Assemblea Parlamentare dell’Osce- viveva in Ucraina da cinque anni ed era conosciuto per i suoi taglienti editoriali su “Ukrainskaya Pravda” contro i leader corrotti e il malaffare di Kiev e Mosca. Due anni fa si era licenziato dall’emittente russa ORT, in segno di protesta contro la propaganda guerrafondaia portata avanti contro l’Ucraina. Anche a causa del lento procedere delle indagini sul caso, il 3 agosto, il vice ministro per l’informazione, Tetyana Popova, ha rassegnato le dimissioni protestando contro la mancanza di volontà da parte del governo di indagare gli abusi contro i giornalisti e difendere la libertà di espressione. Infine, l’11 settembre i locali di “Inter TV” sono stati incendiati da un gruppo di manifestanti di estrema destra. I giornalisti che preparavano l’edizione domenicale sono rimasti intrappolati negli uffici e solo l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco è riuscito a condurli in salvo, limitando il numero di feriti. Anche in questo caso, l’incendio è stato accuratamente indirizzato contro uno dei maggiori canali televisivi del Paese, di proprietà di Serhiy Lyovochkin, oggi membro del Parlamento ucraino e del Partito di Opposizione, che servì come capo di gabinetto dell’ex presidente Viktor Yanukovych. La libertà di stampa sembra limitata anche nell’entità separatista della “Repubblica del Popolo di Donetsk” dove, secondo il rapporto sui diritti umani in Ucraina dell’Onu, il dipartimento del “Ministro dell’informazione” controlla con mano di ferro l’operato dei giornalisti e rilascia l’accredito solo a determinate condizioni. Mentre l’altra entità, la “Repubblica del Popolo di Luhansk” detiene una giornalista, sedicente membro dei servizi segreti ucraini, che attualmente rischia tra i 10 e i 20 anni di prigione con l’accusa di spionaggio. Guerra di accuse reciproche tra Mosca e Kiev La recrudescenza degli attacchi può anche essere interpretata come l’ultimo fronte del confronto a distanza tra Kiev e Mosca, visto che negli ultimi mesi si sono intensificate le accuse reciproche. Il 31 maggio scorso, è entrato in vigore il decreto presidenziale ucraino che dava attuazione alla risoluzione del Consiglio Nazionale di sicurezza e difesa per l’implementazione di sanzioni personali contro altri 17 giornalisti russi, che si aggiungono a quelli già sanzionati lo scorso anno. Tale decisione si aggiunge a quella dello scorso febbraio, quando il Consiglio Nazionale per le trasmissioni radio-televisive decise di mettere al bando un’ampia lista di canali televisivi russi, stralciandone l’autorizzazione a trasmettere in Ucraina. La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Il 3 ottobre scorso, la corte distrettuale di Lefortovo a Mosca ha confermato la detenzione provvisoria per i prossimi due mesi nei confronti del giornalista ucraino Roman Sushchenko, arrestato dai servizi segreti russi con l’accusa di spionaggio. Sushchenko, che lavora a Parigi come corrispondente per l’agenzia di stampa online Ukrinform, si trovava a Mosca per affari personali. Buona parte della pressione esercitata sul governo di Kiev è venuta dalla rappresentante per la libertà dei media dell’Osce, Dunja Mijatovic, che solo nel 2016 ha pubblicato nove appelli che richiamano l’attenzione dei Paesi membri dell’Osce al rispetto degli impegni assunti nel campo della libertà dei media. Come affermato da Maxim Eristavi, uno dei fondatori di “Hromadske International”, celebre piattaforma multimediale ucraina: dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’Occidente si è disinteressato dei giornalisti sotto attacco, poiché tutta l’attenzione era rivolta alla gestione dei rapporti politici coi nuovi leader di Mosca. Oggi è il turno dell’Ucraina. Gli attori internazionali non devono lasciarla sola: il Paese ha compiuto 25 anni di indipendenza quest’anno, e deve imparare a proteggere i giornalisti e la libertà di stampa come uno dei presupposti per la realizzazione di una democrazia più matura. Cono Giardullo lavora in Ucraina con l’Osce (Twitter: @conogiardullo). |
Realizzazione Albo d'Oro Nazionale dei Decorati Italiani e Stranieri dal
1793 ad oggi
-
*ANNESSO*
*A: *BOLLETTINO NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE
Situazione bimestrale dello stato di sviluppo, approntamento e
finalizzazione ...
3 ore fa
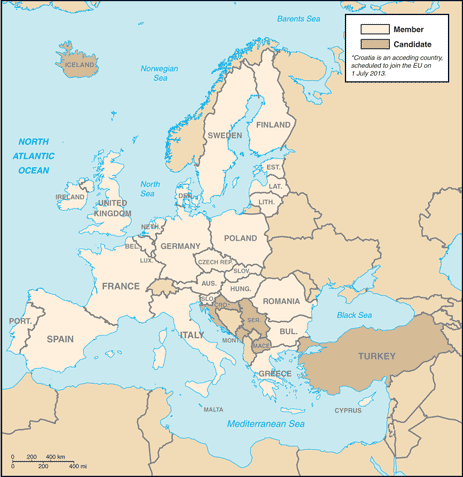
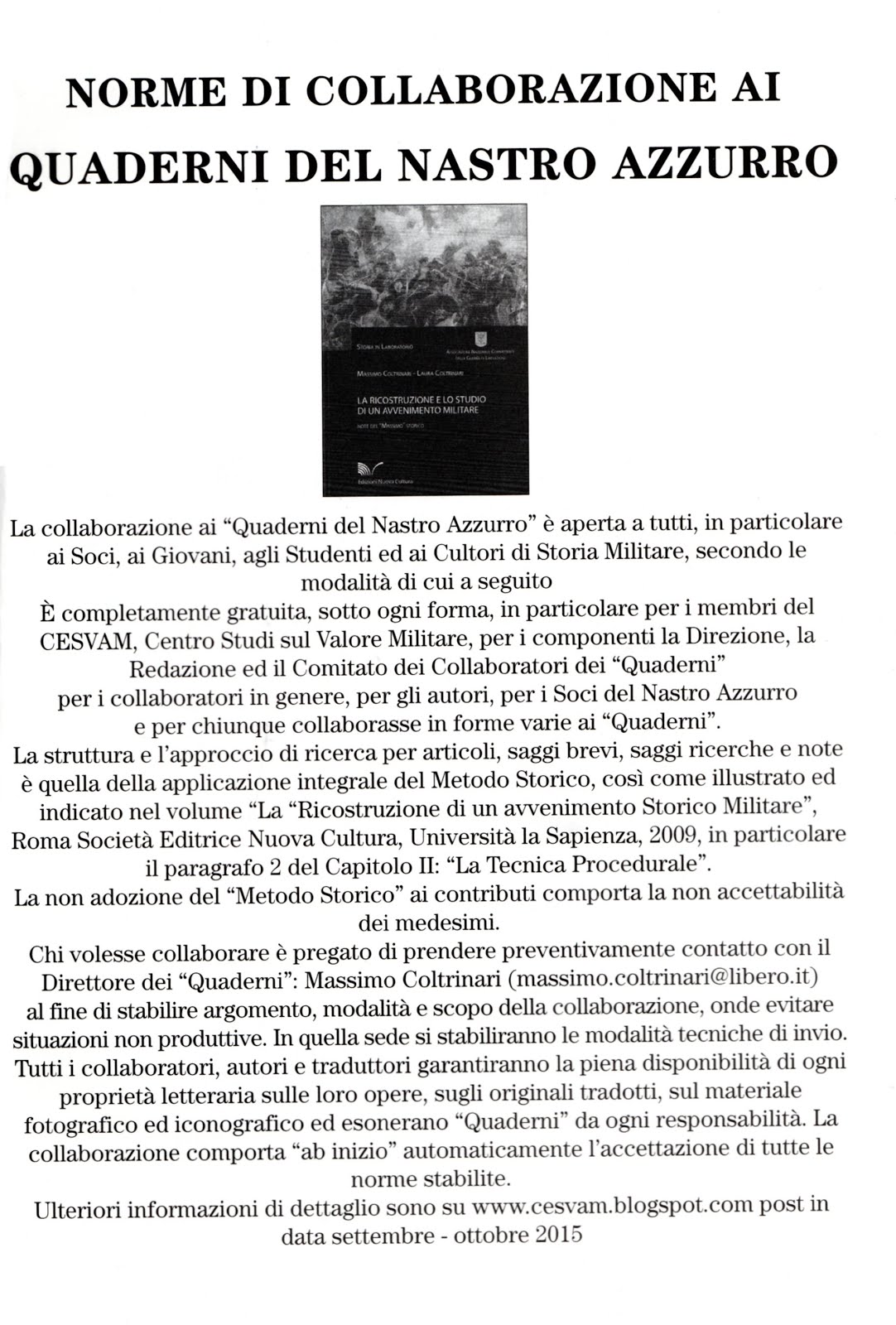



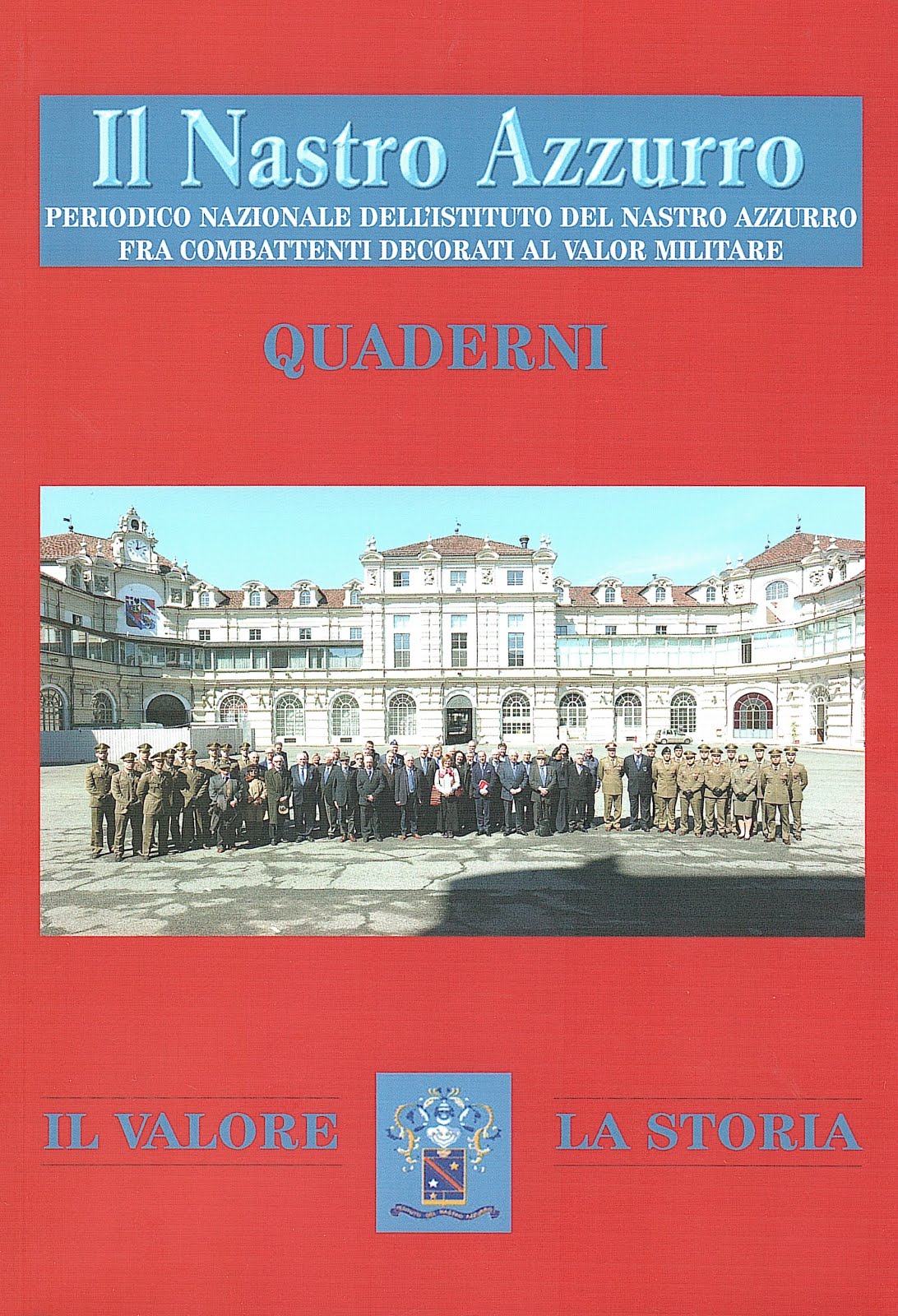
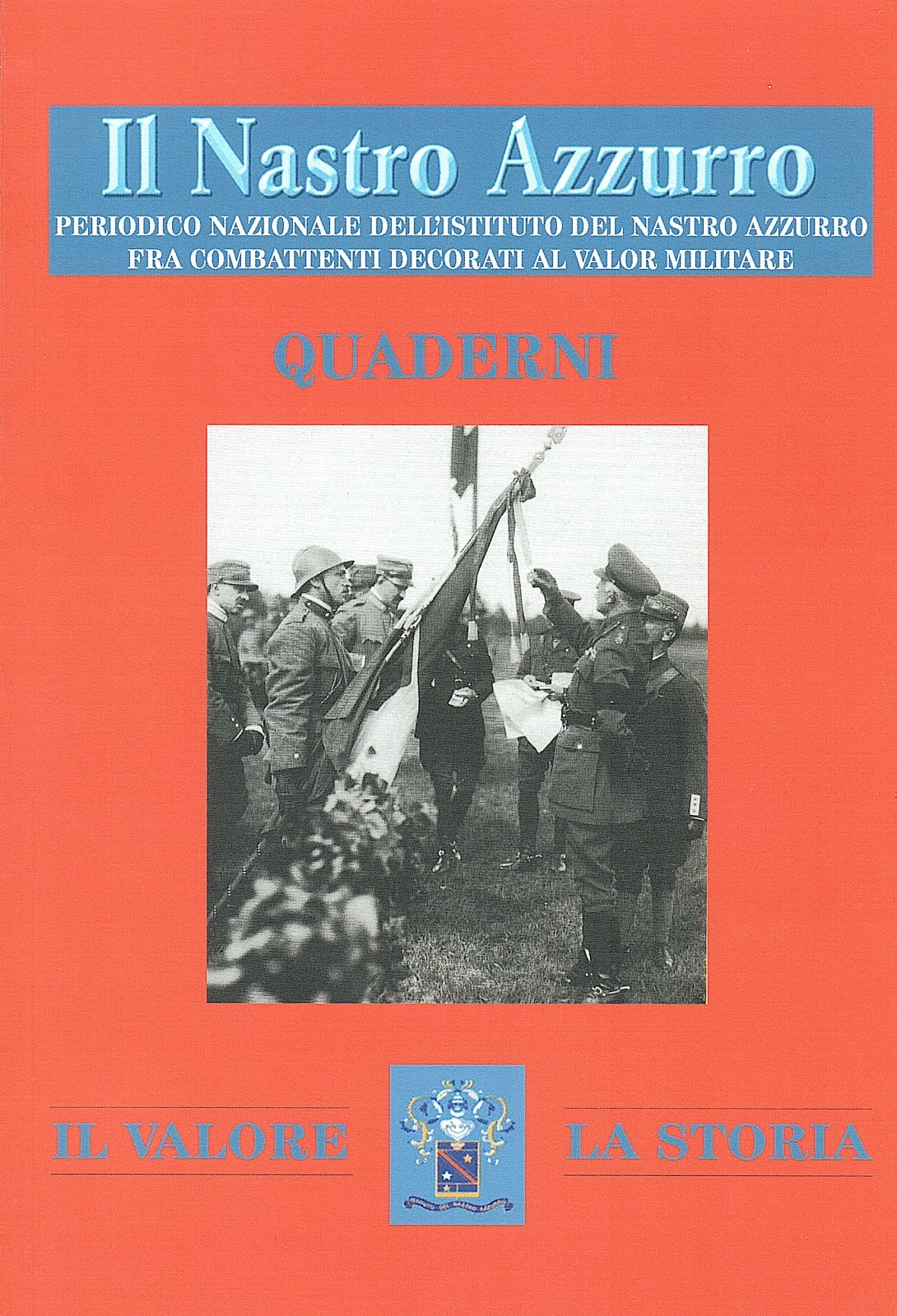


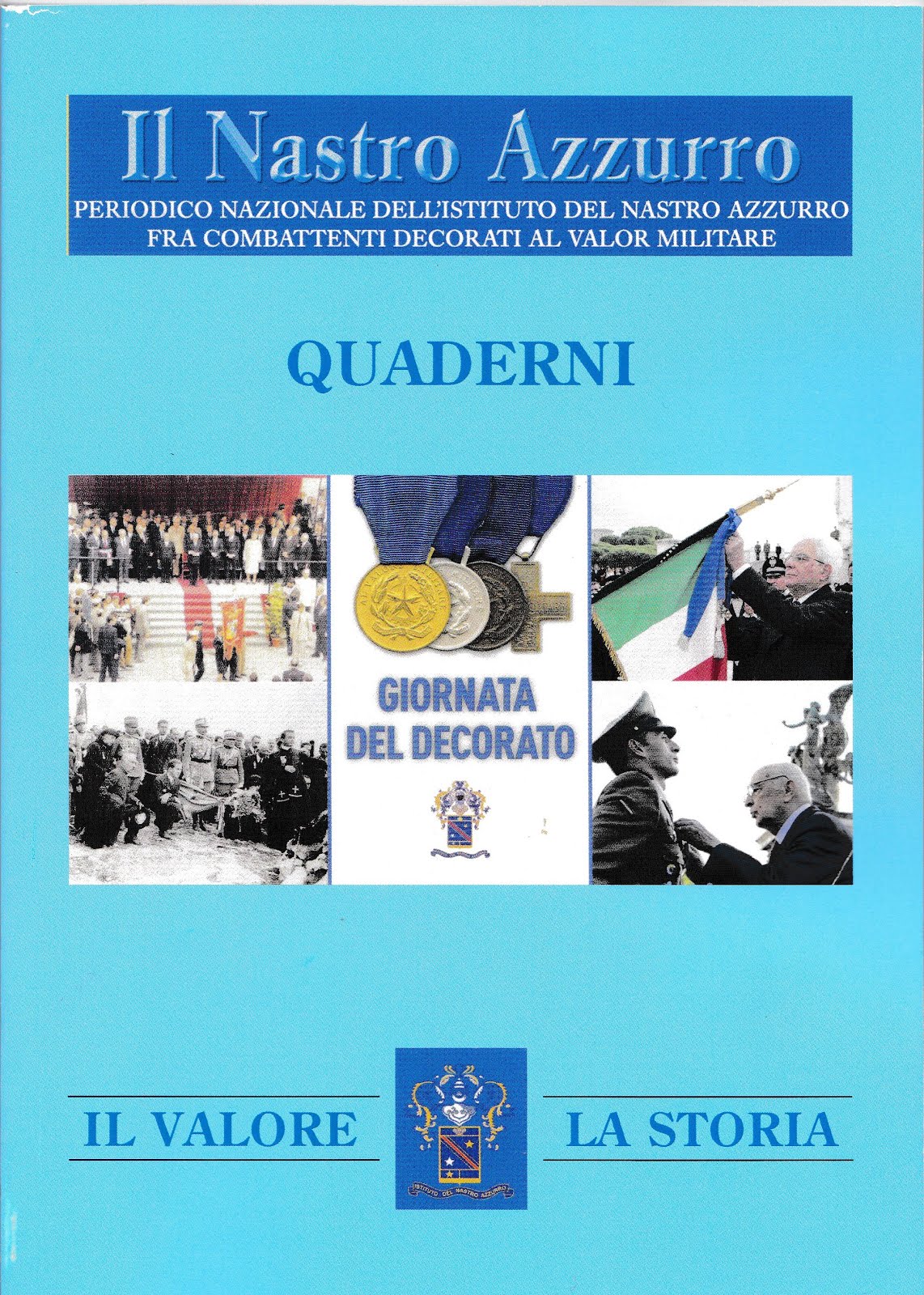
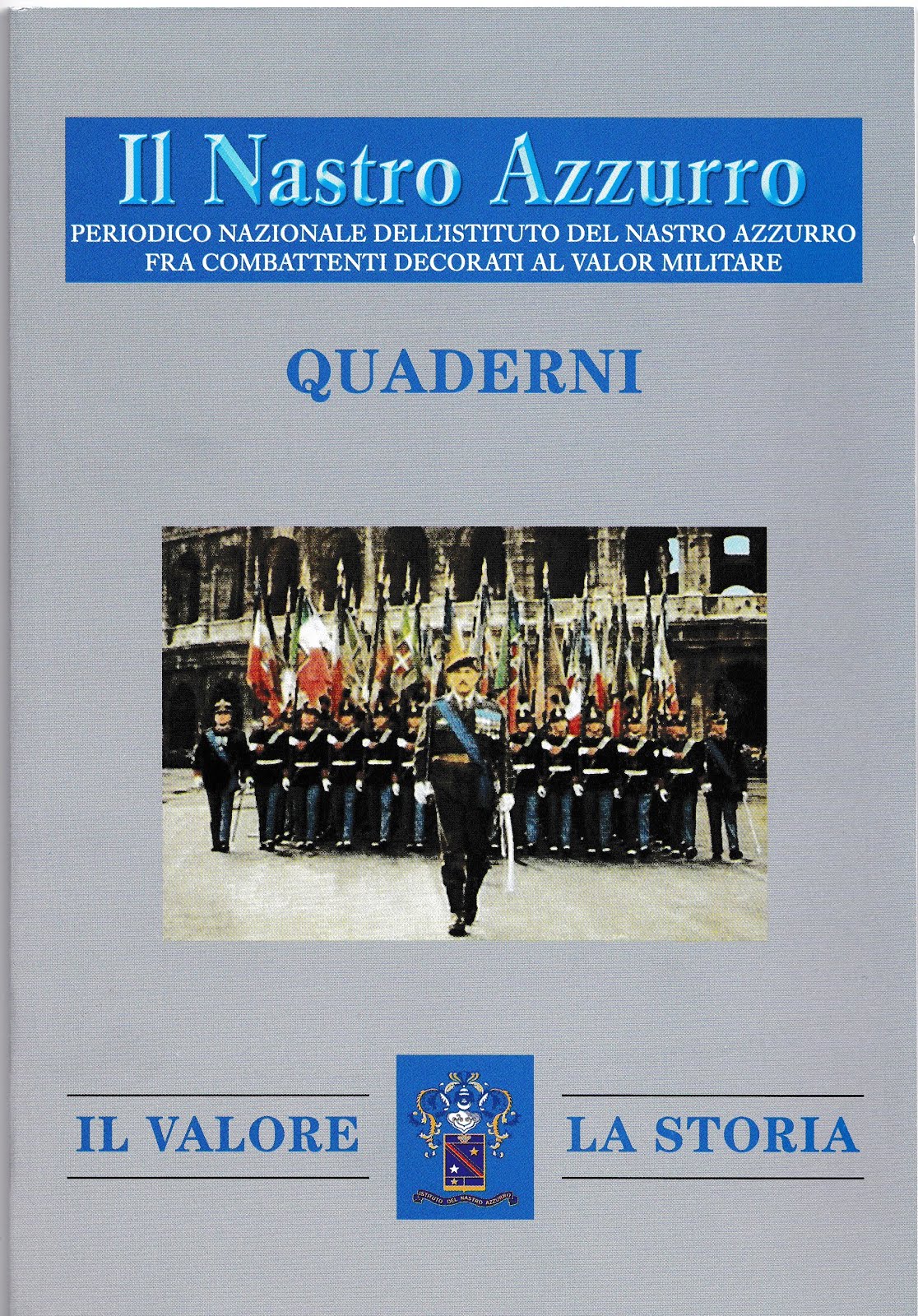

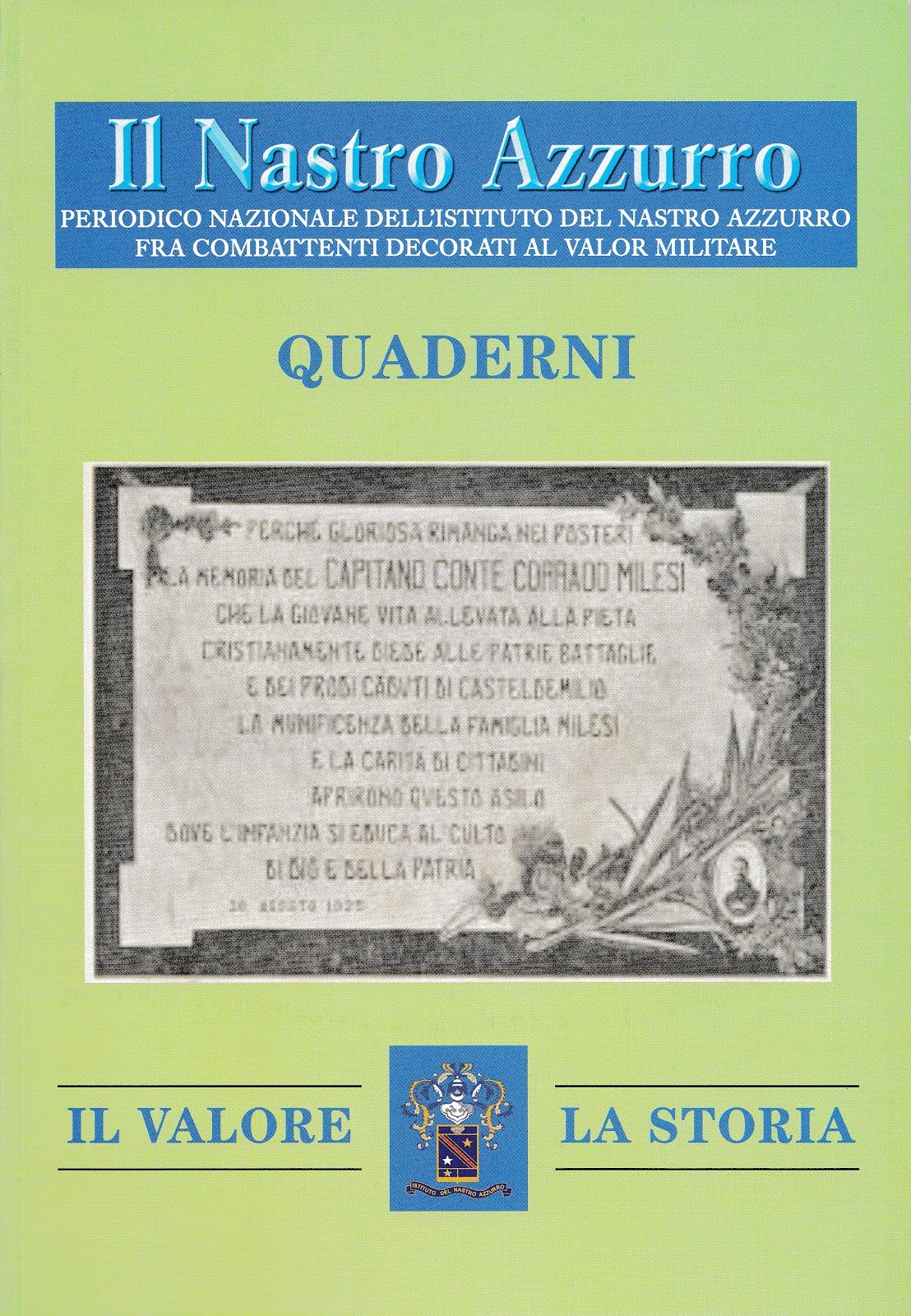
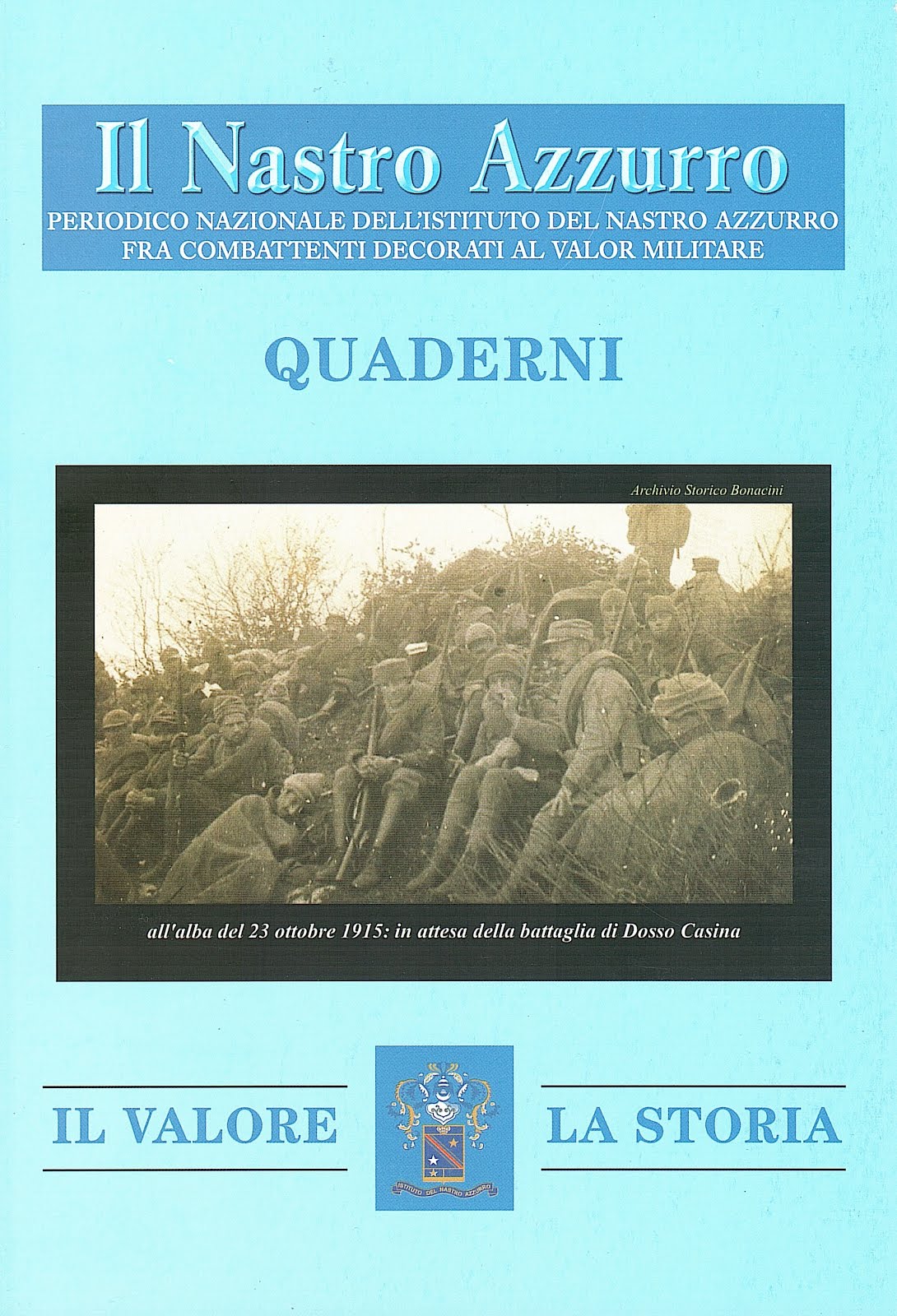


























































.jpg)



