 La Corte Suprema britannica ha confermato la necessità di un passaggio parlamentare prima di avviare il negoziato sulla Brexit, contribuendo a fare chiarezza in una situazione che resta molto, molto confusa ed incerta. La Corte Suprema britannica ha confermato la necessità di un passaggio parlamentare prima di avviare il negoziato sulla Brexit, contribuendo a fare chiarezza in una situazione che resta molto, molto confusa ed incerta.
Ha rintuzzato le tentazioni secessioniste di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ma per quel che riguarda Edimburgo la sfida sembra rinviata, piuttosto che annullata.
La ‘Royal prerogative’ invocata da Theresa May ha subito un ridimensionamento dalle implicazioni costituzionali rilevanti per l’azione del governo, specie in politica estera. Sembrano essersene accorti in pochi nel resto d’Europa, dove l’intero meccanismo appare di difficile comprensione, scarsamente democratico e quasi esoterico, ma la dice lunga circa le differenze che - anche sotto questo aspetto - rendono più larga la Manica.
La battaglia si sposta ora sui termini del provvedimento con cui il Parlamento autorizzerà l’avvio del negoziato: la May punta su un testo ‘secco’ e su un White Paper privo di indicazioni dettagliate, per evitare di precostituire gabbie negoziali che rischierebbero di indebolire il suo margine di manovra (argomento questo, fra i pochi condivisibili della posizione britannica).
Il fronte del remain cercherà di allungare il brodo con emendamenti più o meno vincolanti, ma la conclusione non dovrebbe discostarsi molto da quanto vuole il governo.
Inevitabilità della Brexit? Scenari
Alla Camera dei Comuni c’è una maggioranza trasversale contraria alla Brexit e il Paese è profondamente diviso, come non ci si scorda di sottolineare, ma è difficile che possa pronunciarsi contro quella che è stata pur sempre una manifestazione legittima della volontà popolare, ancorché “consultiva”.
Sarebbe troppo in contrasto con la visione del rapporto fra rappresentanza e democrazia in cui si sostanzia la tradizione parlamentare britannica. Altrettanto vale per la Camera dei Lord, dove la maggioranza dei remainers è schiacciante: cedere alla tentazione di un filibustering finirebbe per accentuare la crisi di credibilità di una istituzione la cui legittimazione è già per molti versi sotto attacco.
Un contro-referendum a breve, aldilà delle petizioni e dell’iperbole mediatica, non è credibile, ma la battaglia non è finita e potrebbe riproporsi al momento della conclusione del negoziato. Se, come è probabile, questa dovesse essere assai più pesante per Londra di quanto prospettato, delusione e proteste potrebbero spianare la strada ad un nuovo referendum (non più sulla Brexit, bensì sull’accettabilità del suo risultato), ma prima e soprattutto a un passaggio parlamentare questa volta di sostanza.
È uno scenario su cui sta lavorando un gruppo traversale che a livello politico va da Peter Mandelson a Kenneth Clarke e trova con personalità come John Kerr una eco più vasta in parti significative dell’opinione pubblica. Resta da chiedersi come si riuscirebbe a gestire il pasticcio di una Londra che, giunta alla fine del percorso, chiedesse di fare marcia indietro con il rischio molto concreto di far esplodere le contraddizioni all’interno dell’Ue che il negoziato avrebbe messo in evidenza. Si salverebbe l’unità dei Ventotto, forse, ma a un prezzo pesante.
Incognite e prospettive del negoziato
Se è vero che il Trattato di Lisbona indica un termine di due anni, concludere una trattativa di questa complessità in un tempo che sarà caratterizzato da scadenze elettorali importantissime, sembra sempre più velleitario. Senza contare che il negoziato sulla Brexit è solo la premessa di una sistemazione più complessa dell’insieme delle relazioni con quanto resterà dell’Ue che, contrariamente a quanto vorrebbe Londra, non potrà essere condotta in parallelo. La possibilità di una proroga, che Lisbona prevede anche se tutti fingono di ignorarlo, si fa sempre più concreta: un rompicapo che contribuirà a ingarbugliare ancor più la vita dei Ventisette.
Il discorso di Theresa May a Lancaster House è stato interessante non tanto per i contenuti - più o meno noti o prevedibili - quanto per i toni. Ha rispecchiato l’approccio tradizionale britannico di “sparare alto” sin dall’inizio, per fare emergere i punti di fragilità della posizione avversaria e condizionare a proprio favore lo sviluppo del negoziato. Rientra in tale approccio il misto fra arroganza e condiscendenza con cui sono stati trattati i temi della difesa e della sicurezza, così come i riferimenti al danno che i Ventisette subirebbero nel recidere ogni legame con un Paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ecc.
Tutto ciò potrebbe rientrare nella normalità - passporting finanziario e accesso al mercato unico sono fondamentali per Londra -, se non tradisse una possibile, e assai pericolosa, sottovalutazione del clima che per ragioni diverse e talvolta opposte sta maturando fra i Ventisette, dove la bilancia fra comprensione ed insofferenza per le richieste britanniche tende a pendere vieppiù verso la seconda.
Le elezioni condizionano francesi e tedeschi, gli italiani non sono né di qua né di là, polacchi, ungheresi e altri non sono pronti a dare spago a Londra.
Rischi di frammentazione e ombre di dissoluzione
C’è una preoccupazione crescente che la Brexit possa innescare un processo di frammentazione dietro il quale si staglia l’ombra della dissoluzione dell’Ue. L’Europa la vogliono cambiare un po’ tutti, ma nessuno è pronto a rinunciarvi; anche quelli fra i vari populisti che dicono di volerlo non sanno bene come e, soprattutto, non sono disposti a farlo seguendo diktat britannici.
Le percezioni psicologiche sono fondamentali in una trattativa dalle mille sfaccettature, come quella che si annuncia: sarà indispensabile tenerlo sempre a mente per evitare di finire in situazioni da cui potrebbe risultare molto costoso uscire. Né Londra né Bruxelles sembrano avere ancora valutato a fondo questo aspetto: quanto prima ci riusciranno, tanto prima si allontaneranno da uno scenario da chicken game.
L’asse con Donald Trump fa parte di una visione britannica ben descritta dall’Economist in una vignetta in cui allo stesso tavolo siedono Trump, che addenta una bistecca dalla forma della Gran Bretagna, e May che guarda un bicchiere d’acqua mezzo vuoto. Aveva annunciato un programma di governo volto a recuperare la tradizione popolare del partito conservatore e si trova con un compagno di viaggio concettualmente agli antipodi, da cui ha poco da guadagnare e che molto danno, per contro, può fare all’Ue.
L’evocazione di stampo churchilliano di una Gran Bretagna con ma non in Europa e ancorata al Commonwealth, che recupera la missione storica di potenza marittima rivolta verso il Mondo, può servire a raccogliere consenso in una parte dell’opinione pubblica, ma è lontana dalla realtà.
Trump è un presidente che non vuole aprirsi ad un mondo di liberi commerci, ma chiudersi al proprio interno, il Commonwealth è a metà fra una associazione culturale e un elegante relitto storico. I rapporti di forza sono quelli che sono e un accordo commerciale bilaterale non si negozia in trenta giorni e neanche in trenta mesi (senza contare che i vincoli Ue magari non sembrano rilevanti a Washington, ma invece ci sono).
Il danno che l’Amministrazione Trump può fare all’Ue - che la stessa May dice di voler difendere - è assai maggiore dei vantaggi che Londra potrebbe sperare di conseguire in un futuro peraltro lontano e incerto. E tuttavia, la seduzione della via americana ha molto a che vedere con quella divaricazione di percezioni psicologiche di cui si è fatto cenno e che, proprio per questo, va presa molto sul serio.
Come andrà a finire? Gli scenari catastrofisti sono sempre di moda, ma se una previsione si può tentare adesso è che dovremmo prepararci a un percorso assai più lungo di quanto si è sin qui detto, che dovrebbe poter concludersi con uno dei tanti compromessi con cui si è sin qui mantenuto in vita il processo europeo. Ma se dovesse fallire, il rischio di disintegrazione diverrebbe tutt’altro che aleatorio.
Antonio Armellini è Ambasciatore d’Italia.
|
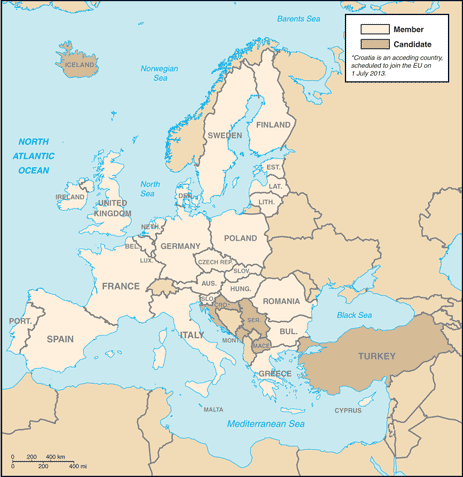
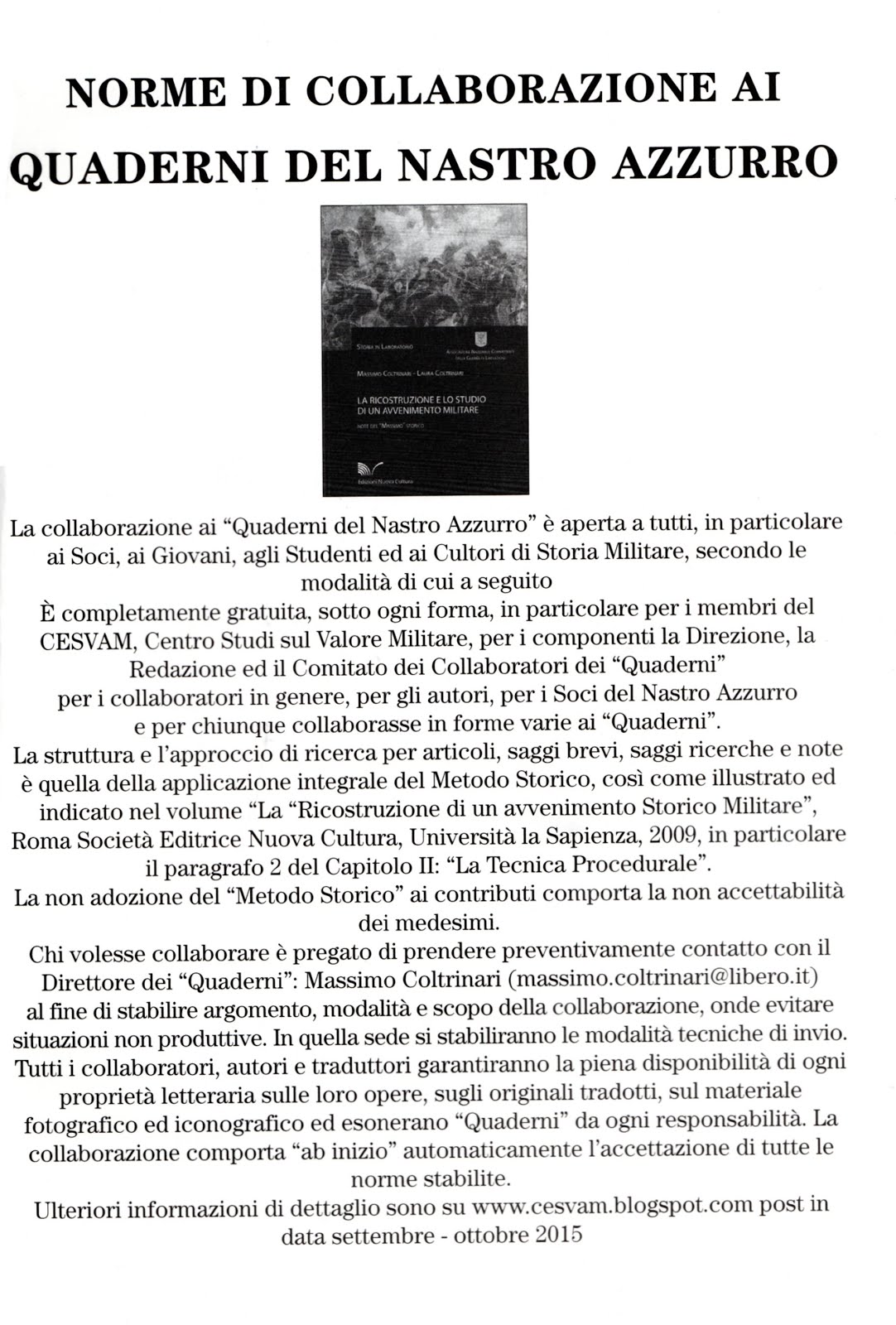



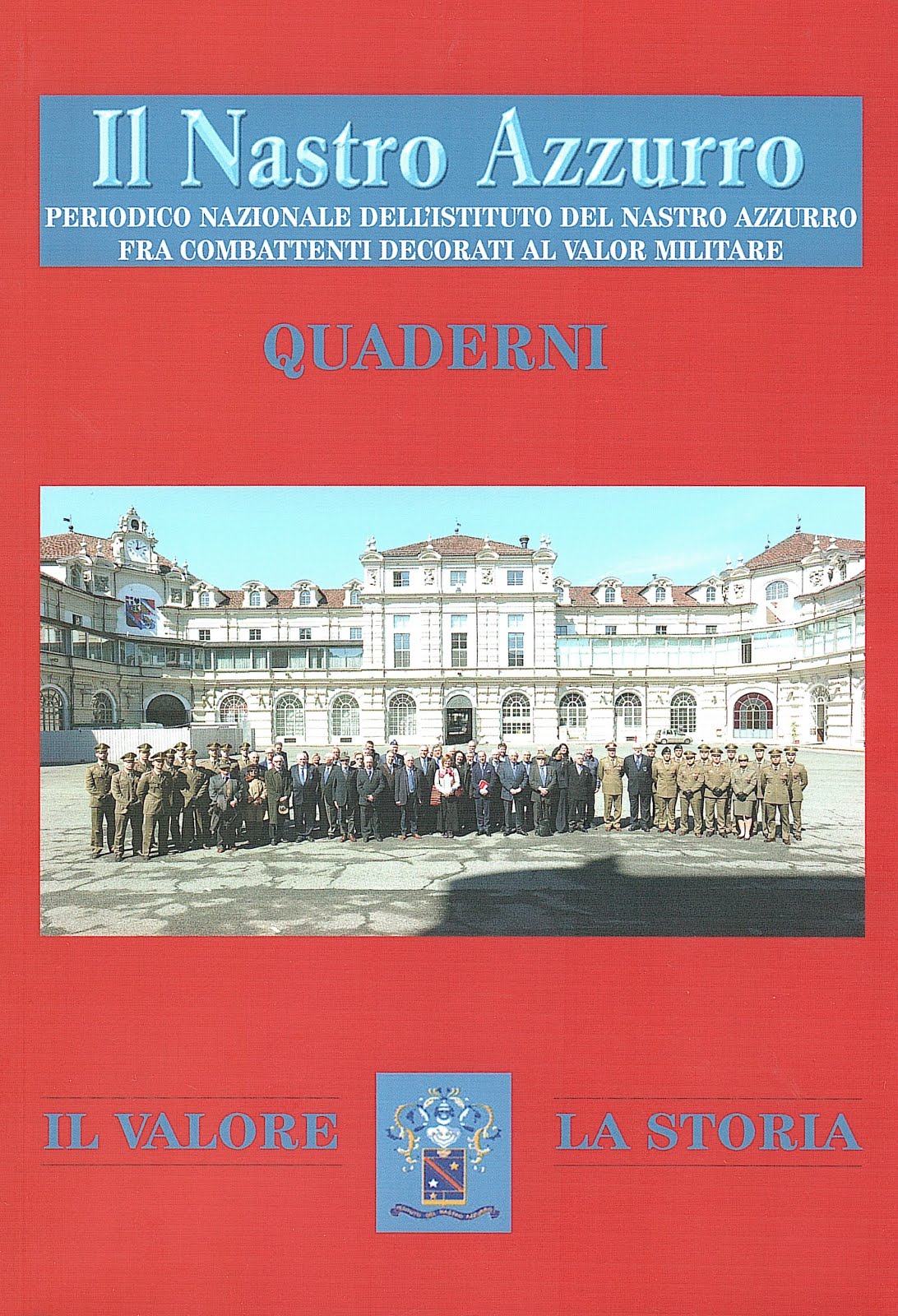
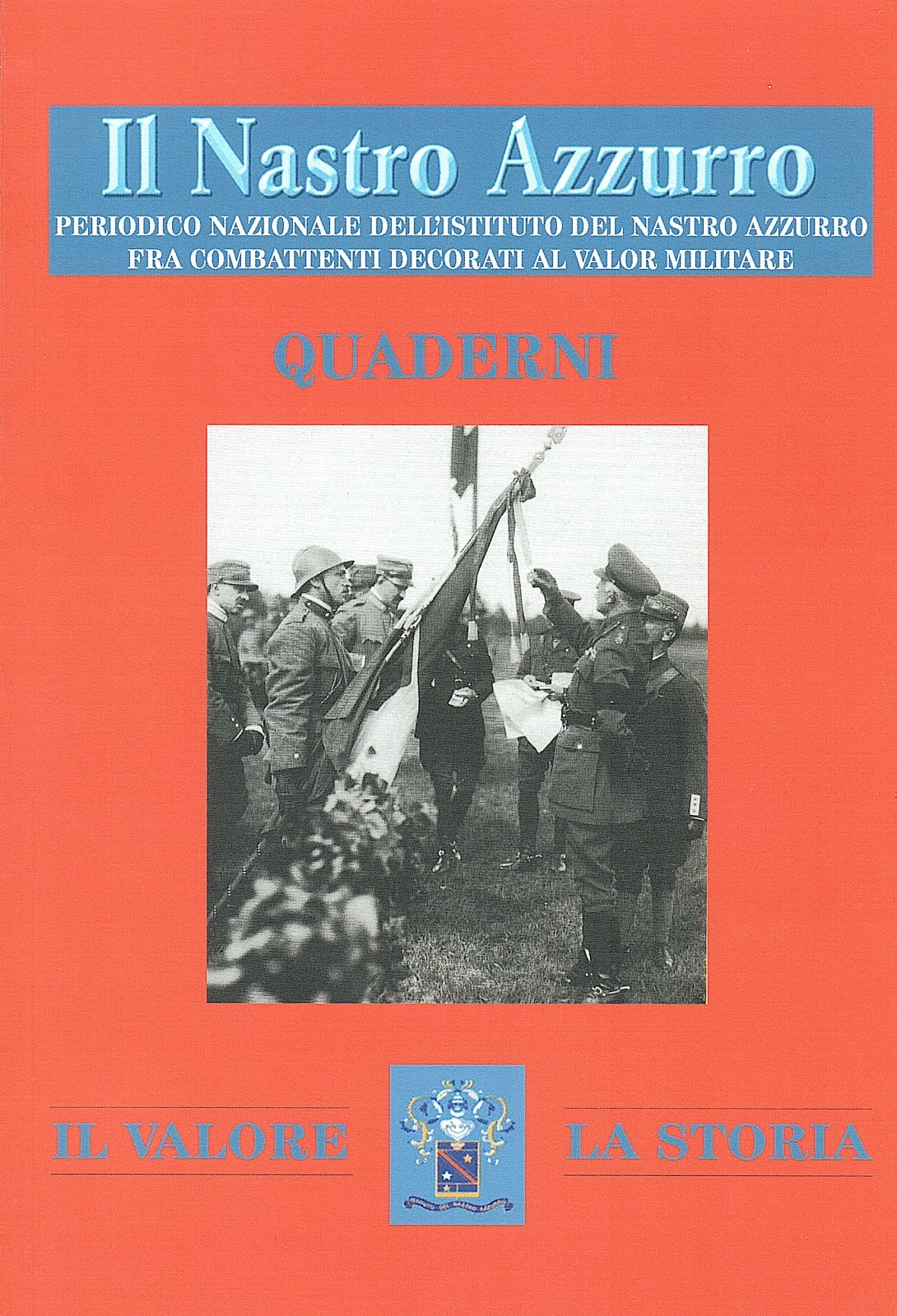


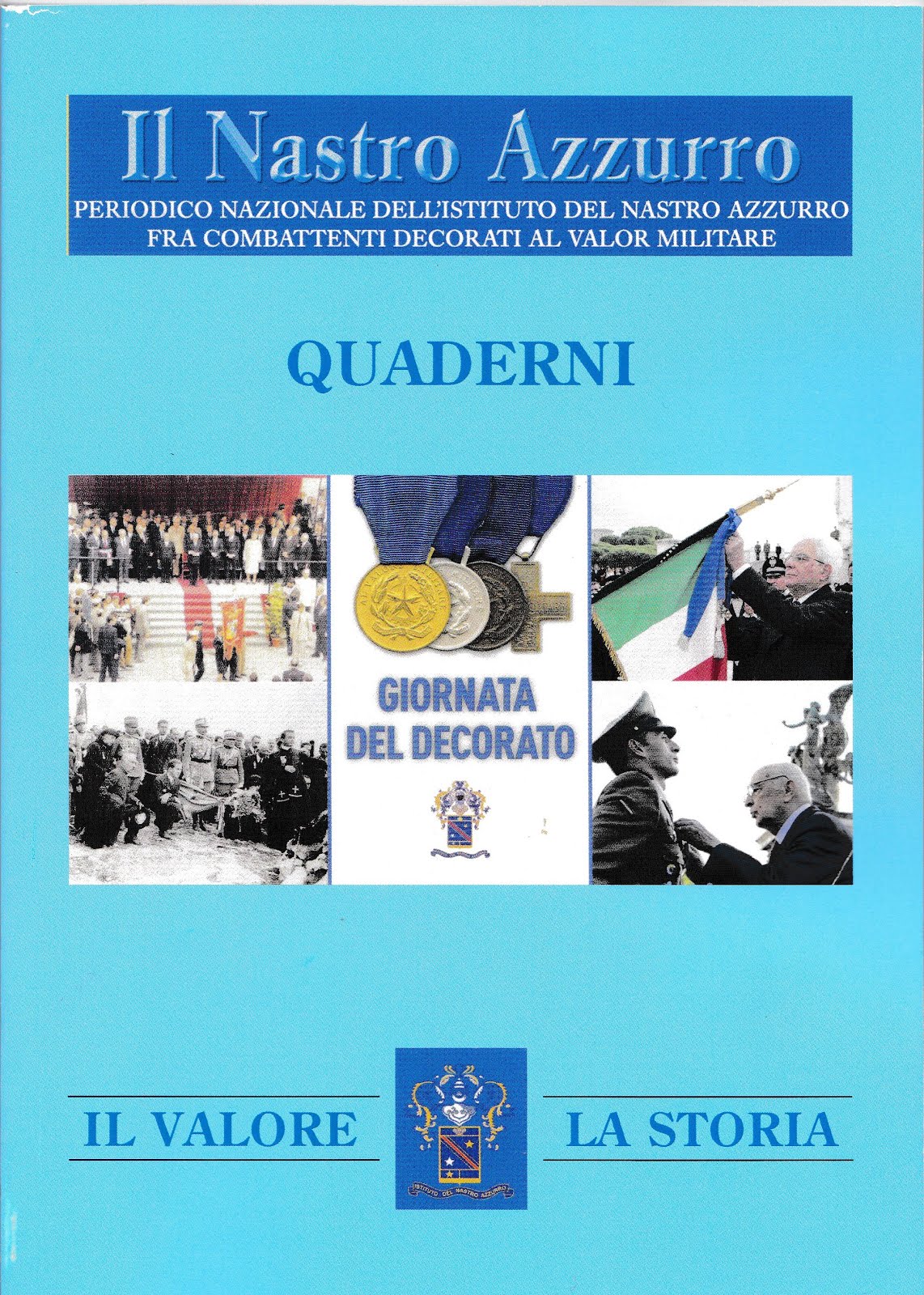
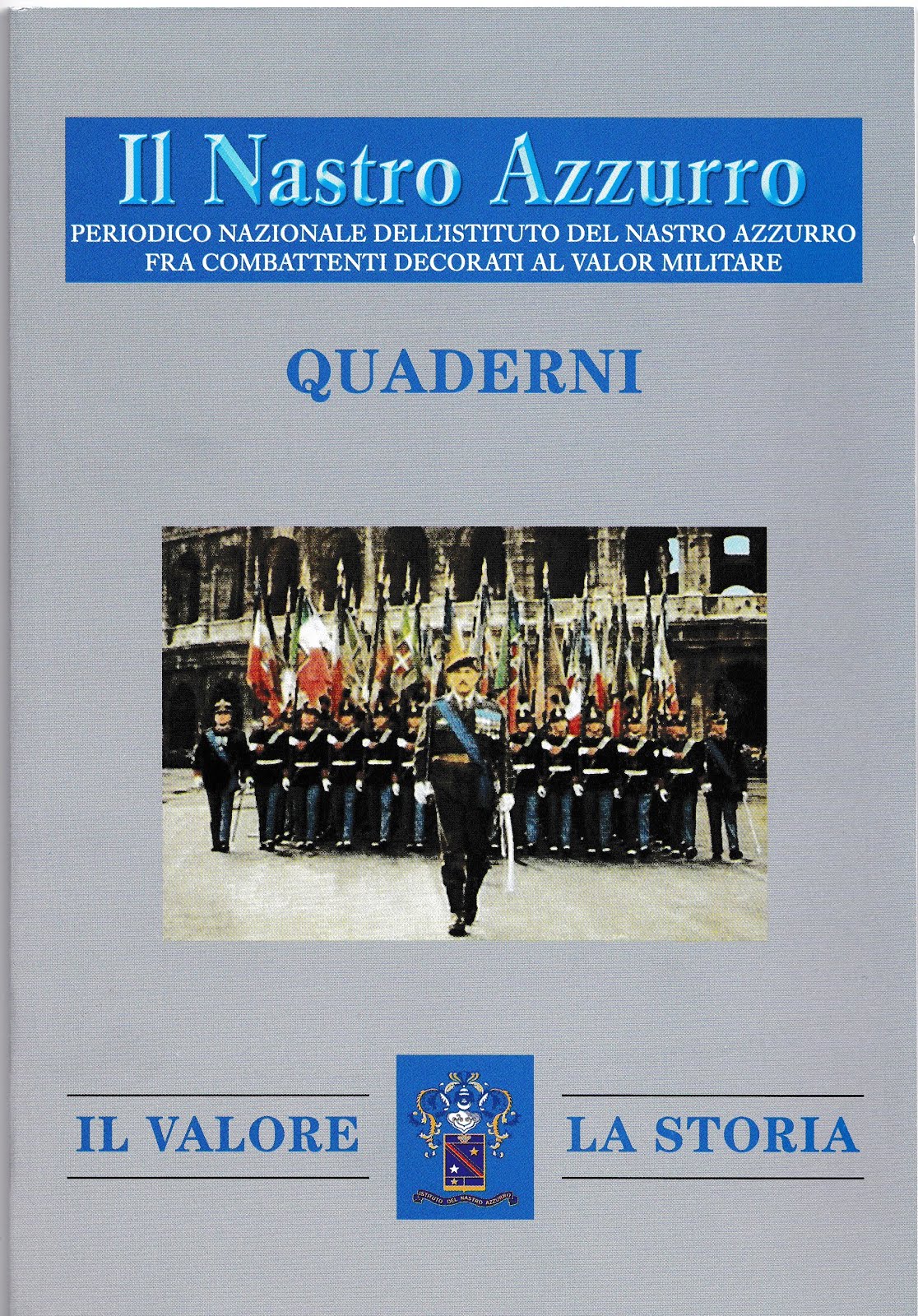

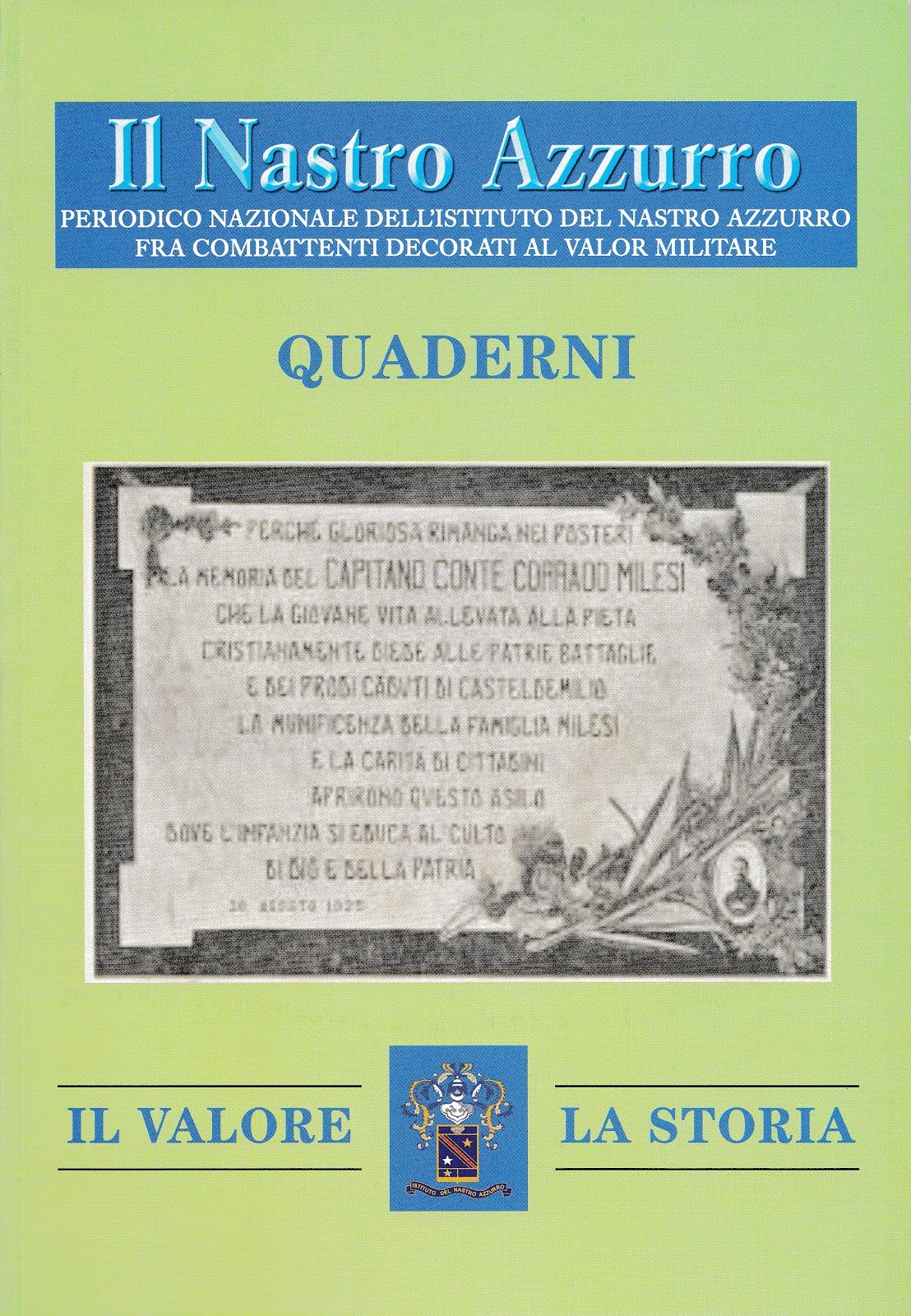
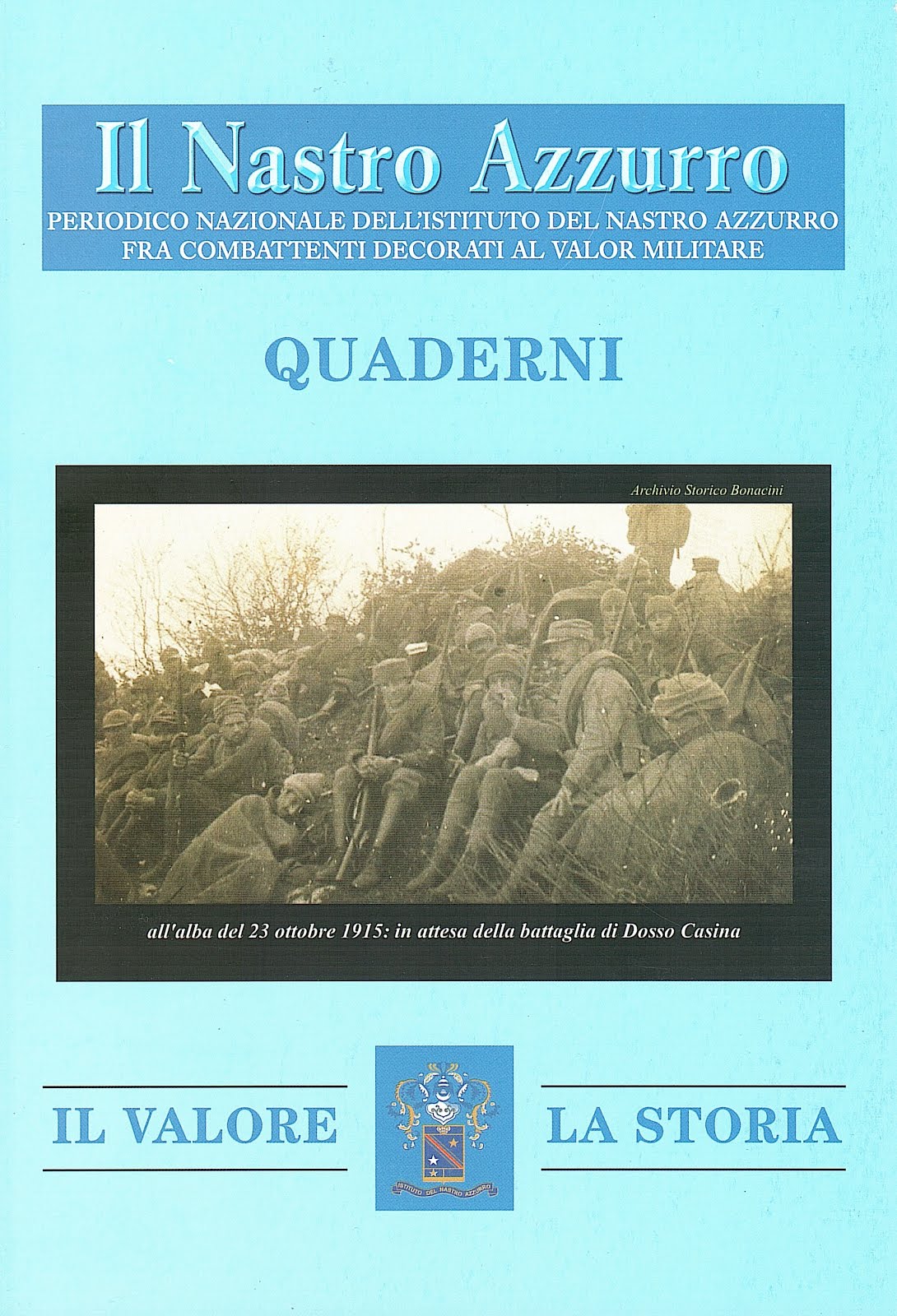
























































.jpg)



