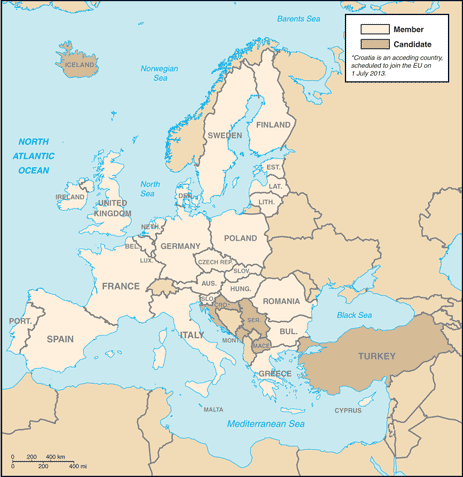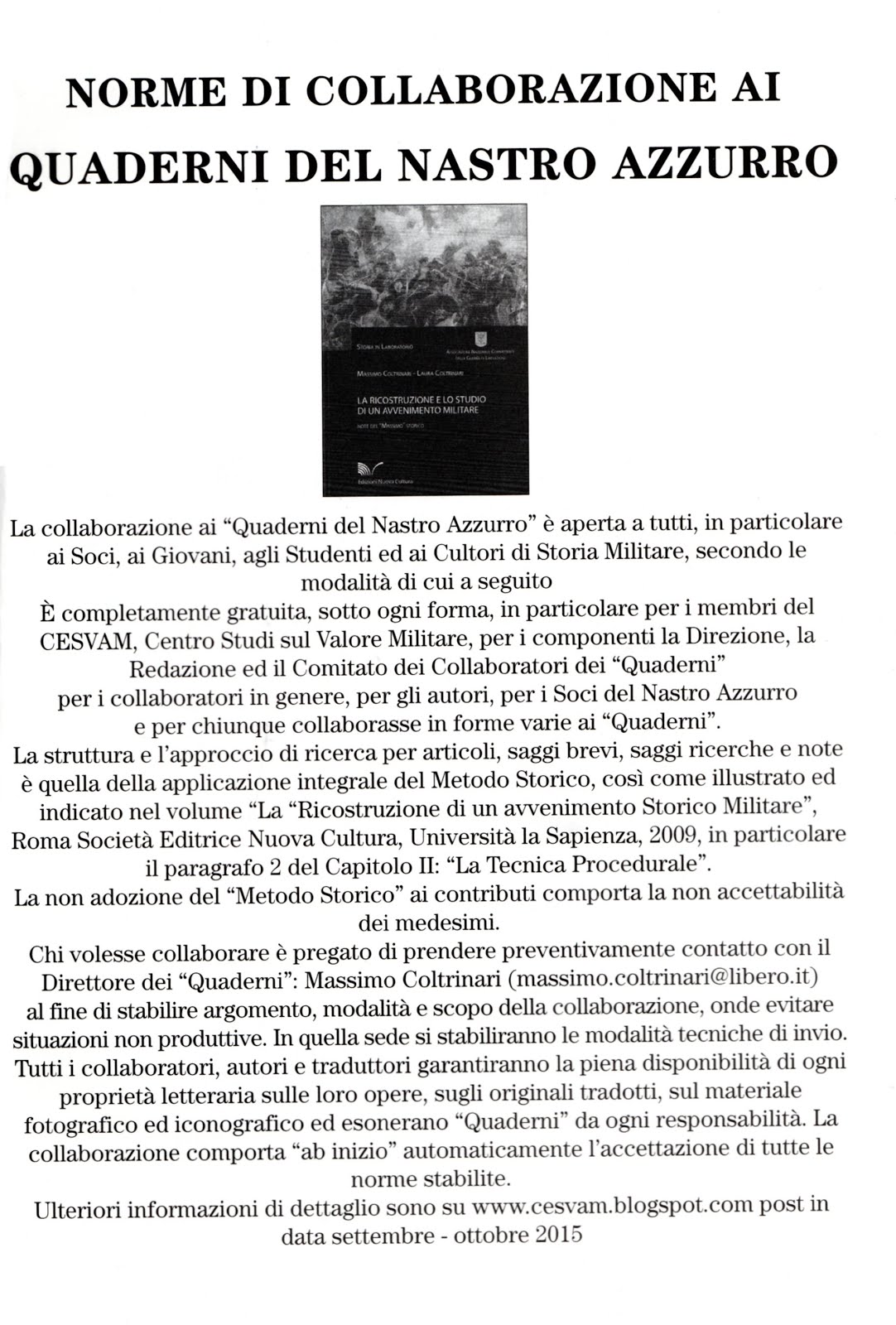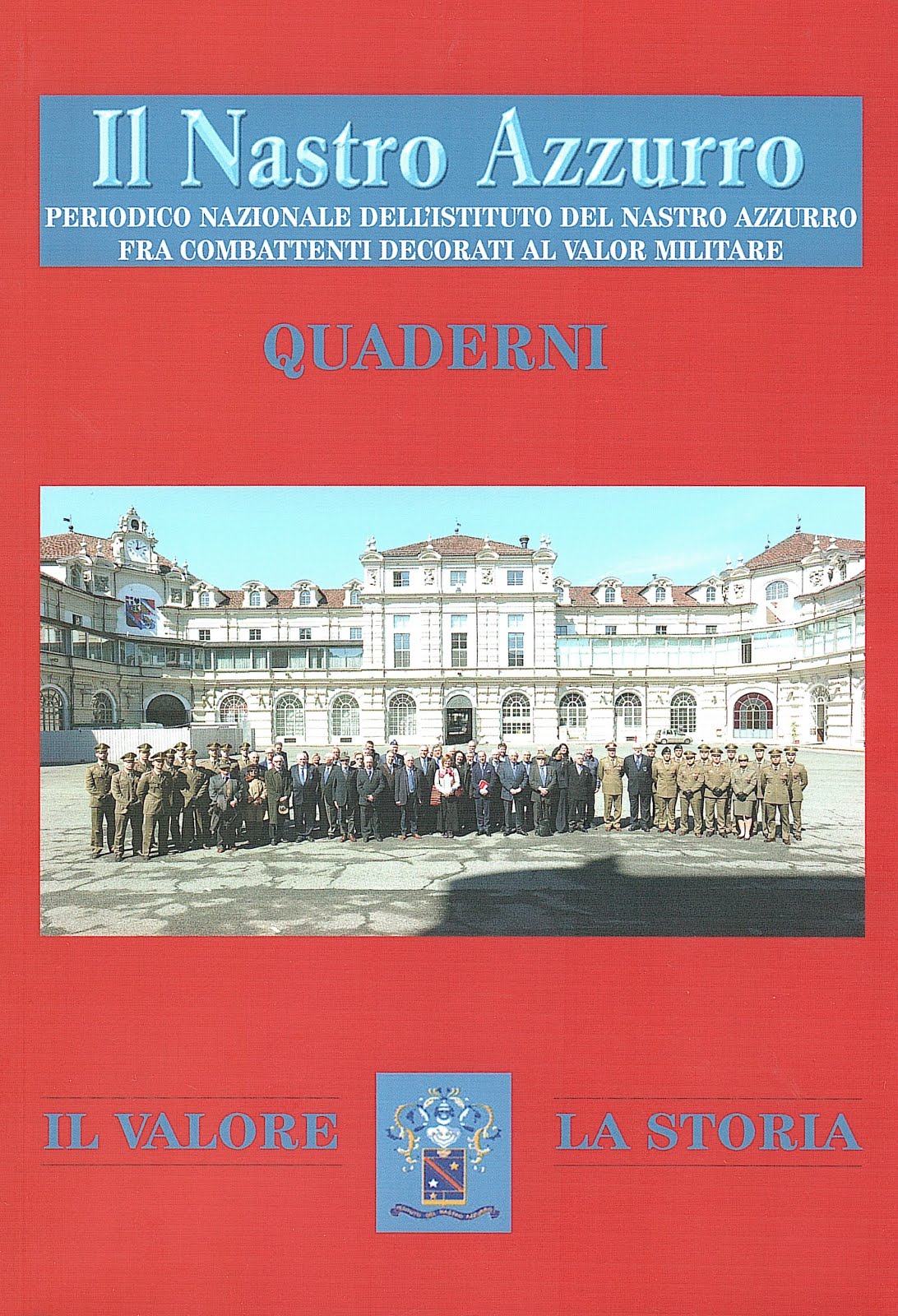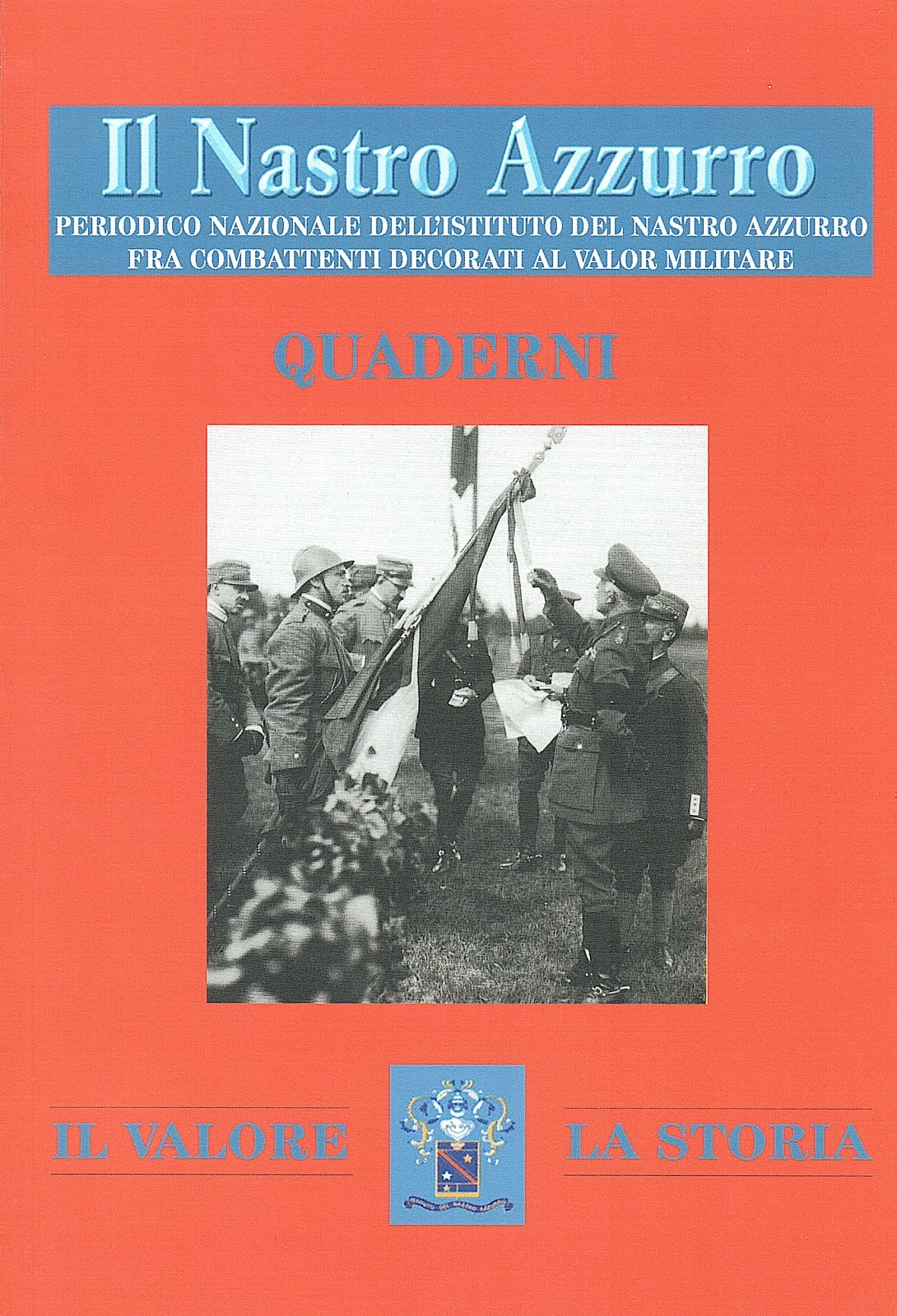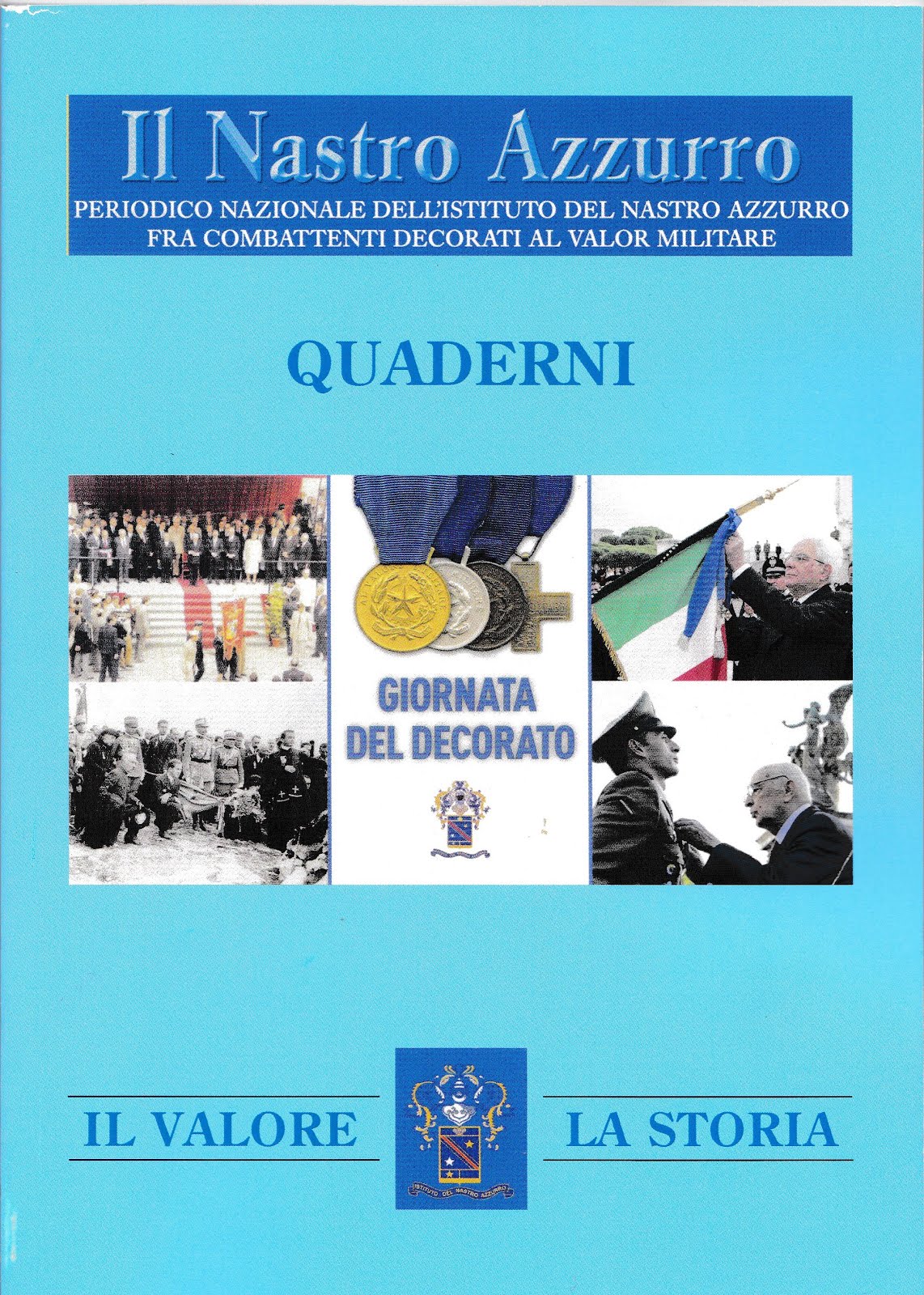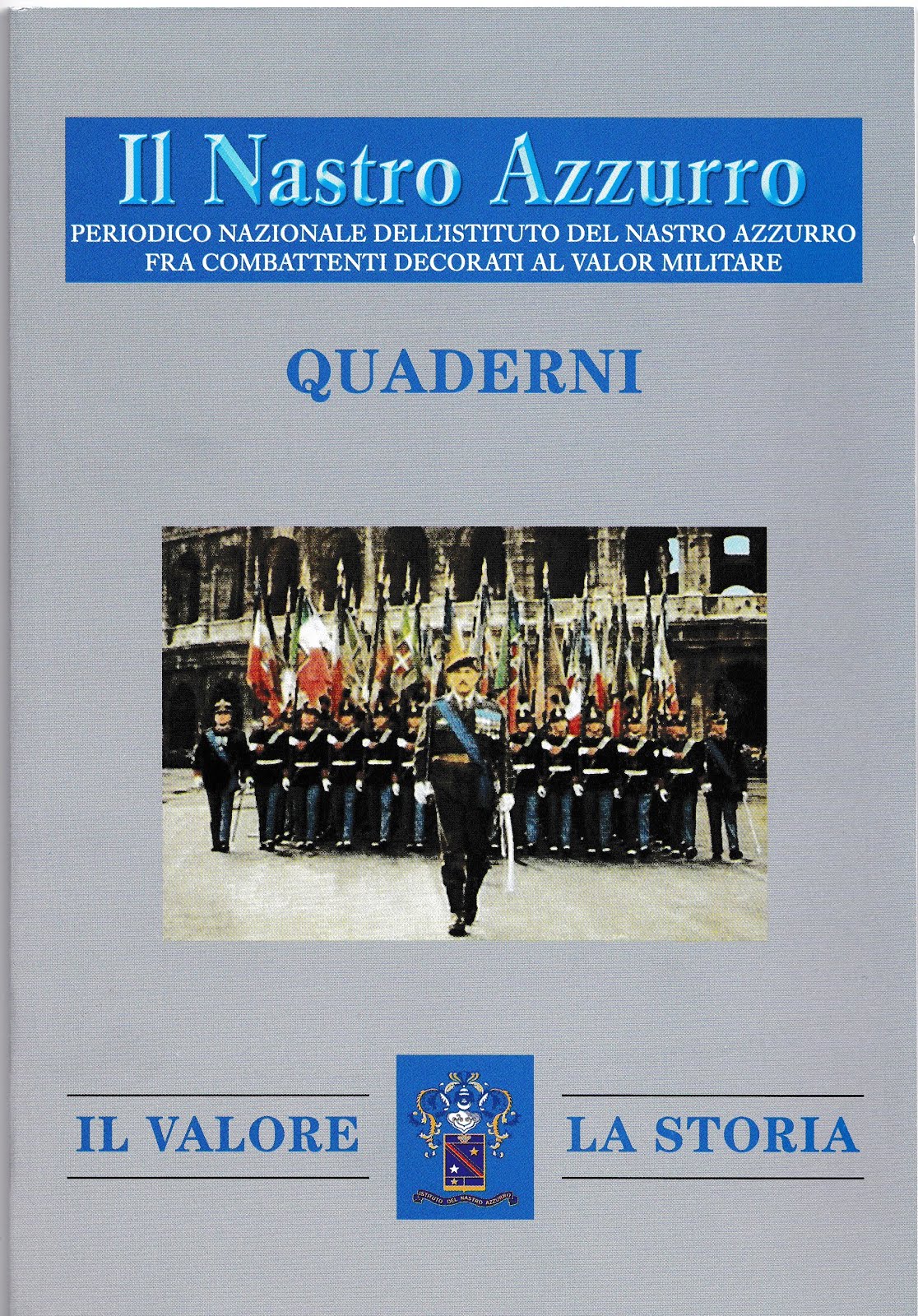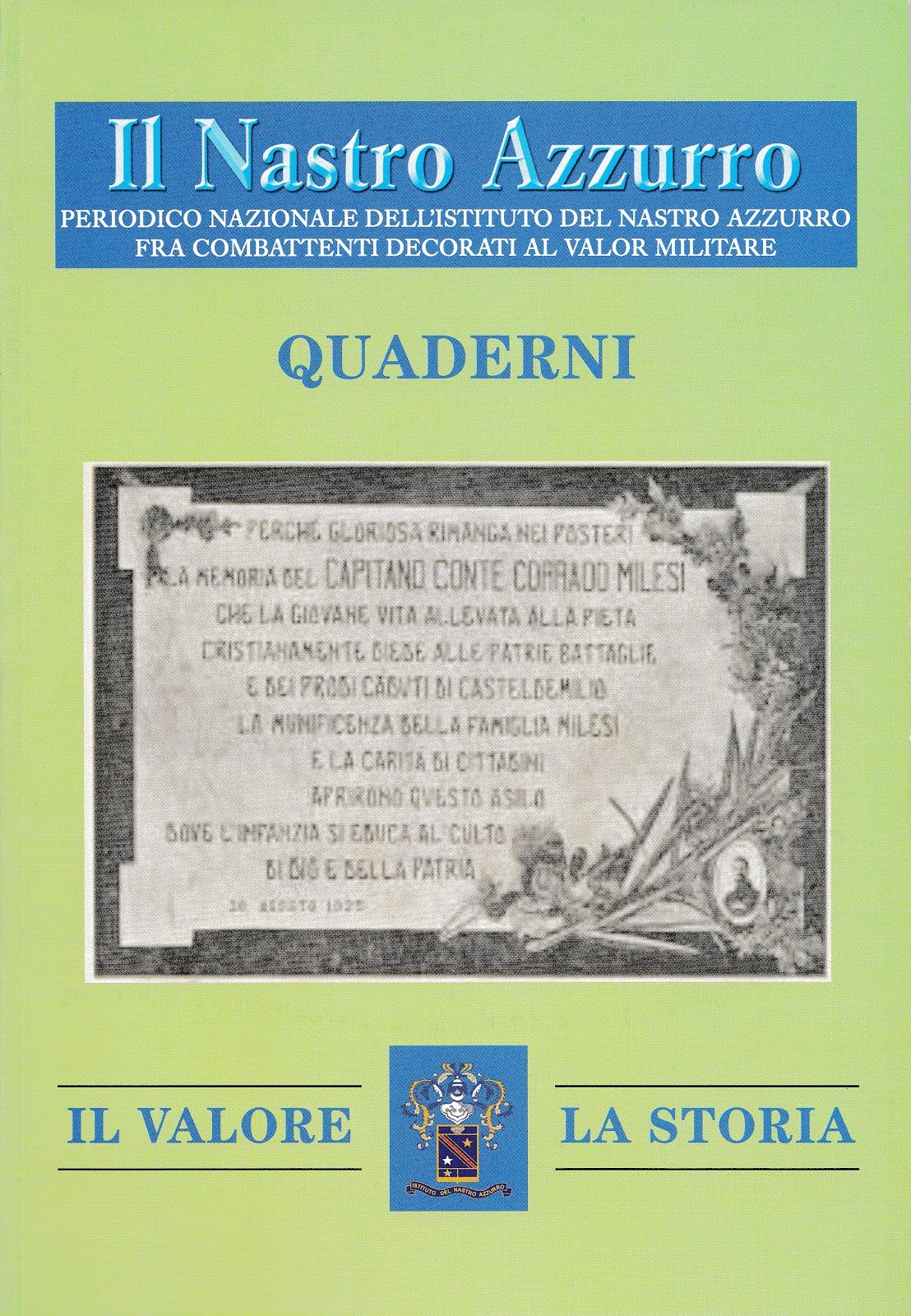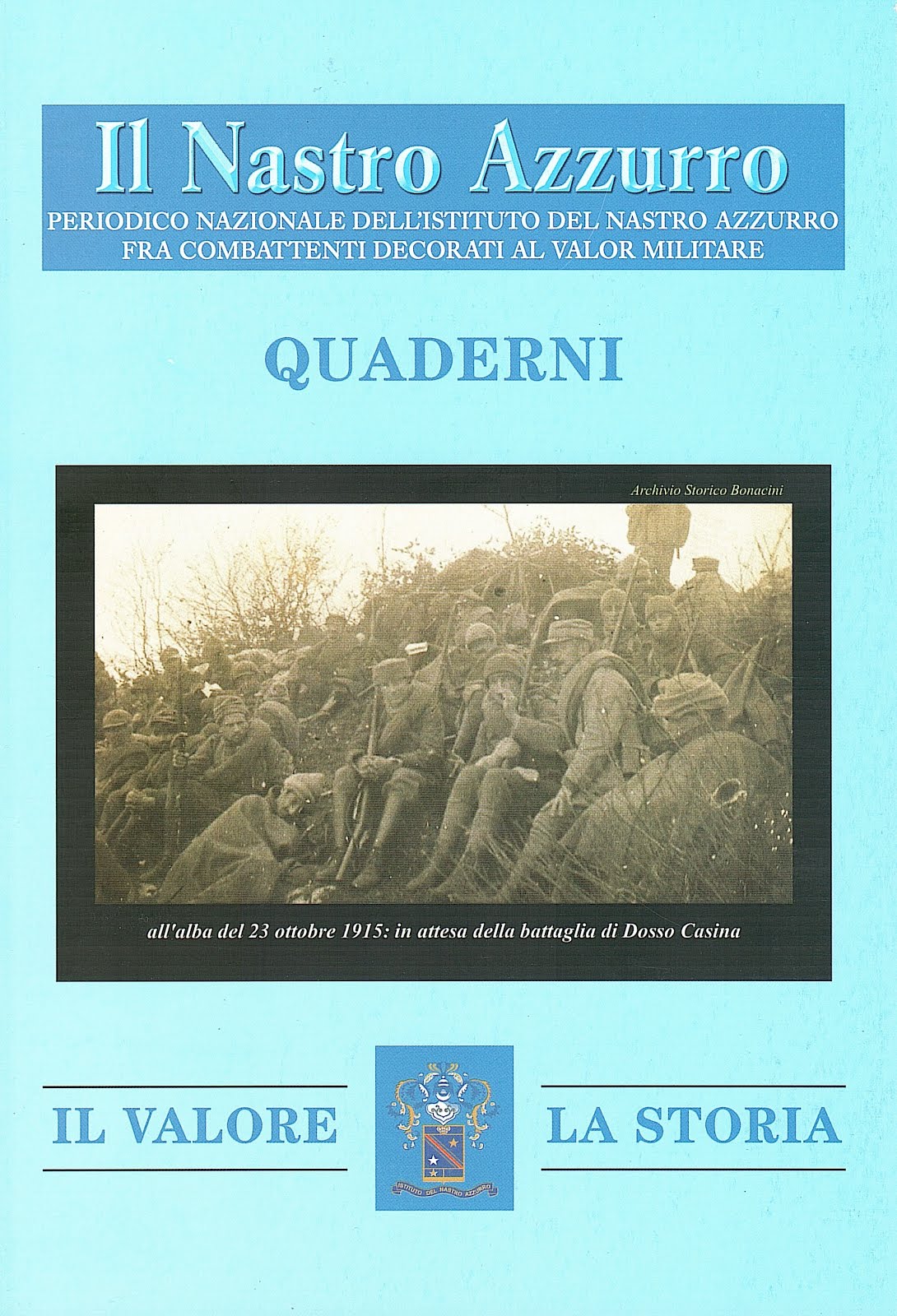Che David Cameron, il grande artefice del disastro Brexit, resti al suo posto per altri tre mesi, e oltre, è francamente impensabile. Era scontato che, se gli elettori avessero optato per l’uscita dall’Ue, le prime mosse sarebbero spettate a Londra. La prima è stata proprio del premier britannico che ha annunciato che si dimetterà, e che non sarà quindi lui, ma il suo successore, a guidare i negoziati con Bruxelles per il recesso dall'Unione. Ma quel che ha aggiunto non è affatto piaciuto agli altri leader europei. Che David Cameron, il grande artefice del disastro Brexit, resti al suo posto per altri tre mesi, e oltre, è francamente impensabile. Era scontato che, se gli elettori avessero optato per l’uscita dall’Ue, le prime mosse sarebbero spettate a Londra. La prima è stata proprio del premier britannico che ha annunciato che si dimetterà, e che non sarà quindi lui, ma il suo successore, a guidare i negoziati con Bruxelles per il recesso dall'Unione. Ma quel che ha aggiunto non è affatto piaciuto agli altri leader europei.
Secondo Cameron, il nuovo capo del governo dovrebbe essere scelto “entro ottobre”, quando si terrà la conferenza del partito conservatore. Solo a quel punto le sue dimissioni diverrebbero effettive. Tempi decisamente troppo lunghi, che fanno a pugni con la necessità, evocata all’unisono da tutti gli altri leader europei, di fare in fretta per evitare pericolosi vuoti legali e una prolungata incertezza politica.
In verità, Cameron non ha escluso che il cambio della guardia a Downing Street si realizzi prima di ottobre, ma, dichiarando di ritenere prematuro un “calendario preciso”, ha suscitato il legittimo timore che il futuro dell’Unione possa nuovamente diventare ostaggio delle convulsioni interne al Partito conservatore. Proprio quel che è successo quando Cameron, per contenere la fronda della fazione euroscettica dei tories, ha preso, con un madornale errore di calcolo politico, la fatale decisione di promettere il referendum sulla Brexit.
Braccio di ferro sui tempi
È sui tempi, quindi, che si è già virtualmente aperto il primo braccio di ferro tra Londra e i vertici dell’Unione, sostenuti dai leader degli altri principali paesi membri, in particolare da quelli dei sei fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi), i cui ministri degli Esteri sono stati i primi a riunirsi all’indomani del voto.
Nessuno, beninteso, contesta che la scelta del nuovo premier spetti al partito conservatore, che, grazie all’inaspettata vittoria alle elezioni del 2015, dispone di poco più di metà dei seggi alla Camera dei Comuni (330 su 650). Bruxelles sta però moltiplicando gli appelli a fare in fretta, perché ha urgente bisogno di poter contare su un interlocutore politico pienamente legittimato.
Tuttavia, non solo Cameron, che vuole ancora dire la sua, ma anche i leader tory del fronte pro-Brexit, come l’ex-sindaco di Londra Boris Johnson, uno dei candidati più quotati per la nuova premiership, la vogliono, sembra, tirare per le lunghe.
La resa dei conti nel partito conservatore non è faccenda da poco, ci sono delle procedure da rispettare, e chi aspira alla leadership ha bisogno di tempo per assicurarsi il consenso necessario ad ottenerla. A riprova che le dinamiche della politica nazionale sono tutt’altro che facili da conciliare con quelle europee (come la crisi greca ha dimostrato ad abundantiam).
Melina britannica
Sul piano procedurale, i leader Ue vorrebbero che il governo britannico notificasse al più presto la decisione di uscire dall’Unione, attivando così l’art. 50 del trattato di Lisbona, ovvero il meccanismo attraverso cui il recesso viene negoziato. La speranza è che, una volta avviato il processo negoziale, l’estrema incertezza che si vive in questi giorni si attenui gradualmente.
D’altra parte, non c’è alcuna scadenza temporale per la notifica della decisione di recesso: teoricamente potrebbe essere rimandata a tempo indeterminato. E i leader conservatori della Brexit vorrebbero compiere questo passo più in là, non solo per le ragioni di politica interna summenzionate, ma anche perché, una volta attivato il processo, ci saranno solo due anni per raggiungere un accordo, salvo proroghe non facili da ottenere (servirebbe l’unanimità dei 27 membri restanti).
Allo scadere dei due anni, se non si fosse ancora trovato l’accordo, i trattati europei non si applicherebbero più alla Gran Bretagna, che resterebbe quindi priva di legami contrattuali con il resto dell’Europa. Johnson e gli altri conservatori pro-Brexit temono che Bruxelles possa usare questo scenario come arma di ricatto e non vogliono sedersi al tavolo delle trattative prima di avere un obiettivo chiaro in mente - ancora, sembra, non ce l’hanno - e il relativo mandato politico.
Iter complesso e insidioso
Bisogna inoltre tener conto che il referendum era consultivo: il suo esito non ha quindi un immediato effetto legale. Rimetterlo in discussione sarebbe un suicidio politico, ma resta il fatto che il governo britannico deve innanzitutto definire una proposta per l’attivazione dell’articolo 50 e sottoporla al voto del Parlamento. E si torna così alla questione cruciale della scelta di un nuovo leader con un chiaro mandato politico per iniziare i negoziati.
Peraltro, c’è da aspettarsi che il Parlamento britannico, dove una larga maggioranza avrebbe voluto che il Regno Unito rimanesse nell’Ue, svolgerà un ruolo attivo nei passaggi - e non sono pochi - che lo vedranno come protagonista. Certo non si limiterà a dare il suo avallo a soluzioni preconfezionate, tanto più in quanto i leader pro-Brexit non hanno indicato uno sbocco univoco per il voto referendario.
Né si può del tutto escludere che, per un impasse nel partito conservatore o in Parlamento, si decida alla fine di andare ad elezioni anticipate, un passaggio prima o poi obbligato per qualsiasi nuovo leader in cerca di legittimazione popolare. Se malauguratamente ciò avvenisse prima che si fosse impostato il negoziato, la situazione si complicherebbe ulteriormente.
Anche perché, più i tempi si allungano, più cresce il rischio di atti unilaterali, da una parte o dall’altra. Le improvvise dimissioni di Lord Jonathan Hill, il membro britannico della Commissione europea responsabile dei servizi finanziari, segnalano quanto concreto sia questo rischio. Anche alla luce di questo episodio, che potrebbe essere il primo di una lunga serie, riesce difficile immaginare che tutto possa restare congelato per mesi, in attesa che i tories trovino la quadra.
Convergenze parallele
Hanno quindi ragione da vendere i leader delle istituzioni europee quando esortano Londra a “dare effetto alla decisione del popolo britannico appena possibile”, anche se passerà inevitabilmente un certo tempo per i necessari chiarimenti e scelte politiche oltre Manica. È opportuno però che i leader europei associno, a questa fermezza sui tempi, un atteggiamento flessibile su altri aspetti.
In particolare, sarebbe importante che, parallelamente al negoziato sull’accordo di recesso, si avviino colloqui anche sui nuovi rapporti che dovranno instaurarsi tra il Regno Unito e l’Ue, come vorrebbe Londra. Le due trattative sono formalmente distinte, ma funzionalmente collegate. Anche l’art. 50 stabilisce che l’accordo sul recesso deve tenere conto del “quadro delle future relazioni con l’Unione”.
Un atteggiamento punitivo verso Londra sarebbe altamente controproducente. Si manderebbe un messaggio sbagliato anche al popolo britannico, che, non va dimenticato, continuerà ad essere uno dei protagonisti di questa vicenda, e sarà chiamato, prima o poi, in una forma o nell’altra, a pronunciarsi nuovamente sul futuro del suo paese.
Ettore Greco è direttore dell’Istituto Affari Internazionali (IAI).
|