 Nonostante l’Olanda sia uno dei 6 paesi fondatori dell’Unione europea, Ue ed addirittura precursore del progetto integrazione in quanto membro del Benelux - un sistema di cooperazione economica e di unione doganale con il Belgio e il Lussemburgo nato nel 1944 - le elezioni politiche olandesi del 15 marzo potrebbero minare la già traballante stabilità europea. Nonostante l’Olanda sia uno dei 6 paesi fondatori dell’Unione europea, Ue ed addirittura precursore del progetto integrazione in quanto membro del Benelux - un sistema di cooperazione economica e di unione doganale con il Belgio e il Lussemburgo nato nel 1944 - le elezioni politiche olandesi del 15 marzo potrebbero minare la già traballante stabilità europea.
Se la maggioranza dell’establishment politico non è radicalmente anti-europeo, la posizione degli olandesi nei confronti dell’Ue è divenuta negli anni sempre più critica, con un supporto al progetto di integrazione che si attesta attorno al 40%.
Alla vigilia delle elezioni, si alimentano inoltre le speculazioni che proprio l’Olanda, Paese che negli Anni ‘70 fu uno dei principali sostenitori dell’adesione britannica all’Ue, potrebbe essere il prossimo Paese ad uscire dall’Unione.
Al momento, nonostante i 28 partiti in gara per i 150 seggi alla Tweede Kamer, la Camera bassa del Parlamento, la battaglia politica è giocata principalmente tra il leader del Partito delle libertà (PVV), Geert Wilders, e l’attuale primo ministro Mark Rutte, a guida del Partito per la libertà e democrazia (VDD).
Secondo gli ultimi dati, si stima che proprio il VDD potrebbe conquistare dai 23 ai 27 seggi, facendo meglio del PVV e acquisendo così l’opportunità di formare un nuovo governo di coalizione.
La crisi migratoria ed il qualunquismo politico
Il PVV, che ha come secondo punto del suo programma l’uscita dell’Olanda dall’Ue, si attesta comunque come il secondo partito. La campagna elettorale di Wilders si basa su una retorica anti-islam e anti-immigrazione e dipinge l’Ue coma la causa principale dell’arrivo di rifugiati nel Paese.
Tuttavia, dal 2015, il numero dei richiedenti asilo in Olanda è diminuito della metà grazie all’accordo con la Turchia e alla chiusura della via dei Balcani. Questo suggerisce che la retorica anti-immigrazione non è solamente legata alla crisi corrente, ma ad un generale timore che il sistema di welfare olandese non possa reggere la presenza di immigrati provenienti sia da paesi extra-europei che da alcuni paesi membri.
Questa teoria è supportata dal fatto che ad oggi, su una popolazione di circa 17 milioni, il numero di persone provenienti da altri Paesi è di 3,8 milioni, di cui solo la metà non è costituita da cittadini europei. In questo frangente, così come in altri stati membri, più che la crisi migratoria, è stata proprio la globalizzazione ad avere favorito lo sviluppo di tendenze refrattarie all’apertura, che supportano forme di nazionalismo su cui il PVV, ma non solo, ha costruito la propria campagna elettorale.
In effetti, lo stesso VDD ha basato parte della propria campagna sulla necessità di recuperare i valori olandesi e combattere contro l’abuso delle libertà garantite dallo Stato da parte degli immigrati. Seppur non utilizzando la retorica estremista del PVV, nelle sue dichiarazioni Rutte sostiene che gli stranieri in Olanda devono integrarsi ed accettare i valori liberali, oppure andarsene.
L’economia potrebbe garantire la vittoria al VDD
Fortunatamente le elezioni non si vinceranno solo grazie al tema dell’immigrazione, ma anche sulla base dei trend economici. La Commissione europea ha previsto che l’Olanda crescerà nel 2017 del 2%. Questo dato è superiore alla media dei Paesi dell’eurozona che al momento è dell’1,6%.
Inoltre, si prevede una riduzione ulteriore della disoccupazione che si dovrebbe assestare attorno al 5,2%. Dato anche quest’ultimo eccezionale, rispetto al 9,6% della media europea. Sono proprio questi trend positivi che potrebbero garantire al VDD, il partito più grande dell’attuale governo, la vittoria.
Il VDD gioca inoltre sui risultati del referendum in Gran Bretagna e delle elezioni negli Stati Uniti, incitando i cittadini olandesi ad essere pragmatici e a considerare il caos in cui questi due paesi sono finiti a causa di un voto.
Tuttavia la partita rimane ancora aperta ed un altro tema su cui ci si giocheranno le elezioni sono le politiche di austerità implementate dal governo di colazione guidato proprio da Rutte, che ha portato ad un taglio del welfare sociale soprattutto nel campo della sanità.
In effetti, se dal punto di vista delle politiche commerciali l’Olanda è molto vicina a Gran Bretagna e Stati Uniti, mentre l’approccio della politica monetaria e fiscale è in linea con quello tedesco, il modello di welfare sociale era tradizionalmente generoso, molto simile a quello svedese. In questo frangente, proprio il supporto garantito dal Partito Laburista alle politiche di austerità di Rutte è costato alla sinistra la legittimità politica.
La débâcle del Partito Laburista e le possibili coalizioni
I Laburisti si vedranno quasi certamente sorpassare dai Cristiano-Democratici, che potrebbero ottenere 21 seggi, dal partito di centro dei Democratici 66 e dai Verdi, con 17 seggi ciascuno. Le coalizioni politiche non sono nuove in Olanda e, in caso di vittoria, il VVD potrebbe formare un'alleanza con le altre forze di centro, soprattutto in chiave anti-Wilders. Tuttavia, è piuttosto improbabile che gli ambientalisti accettino di entrare in maggioranza con i liberali di Rutte.
Inoltre, il costo-opportunità delle coalizioni politiche, che stanno pesando non solo sulla legittimità del Partito Laburista olandese ma anche su quella di molti partiti tradizionali europei, sarà severamente analizzato dai partiti vincenti, proiettando scenari di non facile previsione anche nei giorni post-elezione, quando il partito vincente dovrà probabilmente negoziare una coalizione con altri per poter governarne il Paese.
In effetti, se il VDD ha alte probabilità di riuscire a formare un gruppo con altri partiti, questa operazione non sembrerebbe possibile per il PVV, anche in caso di vittoria, visto che la maggior parte dei partiti ha dichiarato di non voler entrare in coalizione con un partito così estremista.
L’Olanda sarà il primo stress test della resistenza dei parti tradizionali alle forze populiste, aprendo la via agli appuntamenti elettorali di Francia e Germania. In effetti, al di là della possibile vittoria del PVV, che comunque riuscirebbe difficilmente a governare, il dato allarmante delle elezioni in Olanda sta proprio nell’utilizzo, seppur in forma moderata, di retoriche populiste anche da parte di partiti tradizionali.
Pratica quest’ultima che sommata alla difficoltà di rispondere in maniera efficace alle necessità dei cittadini, sta minando la legittimità politica dei partiti tradizionali, lasciando ampio margine di crescita alle stesse forze populiste anti-europee che si stanno combattendo.
Eleonora Poli è ricercatrice dello IAI.
|
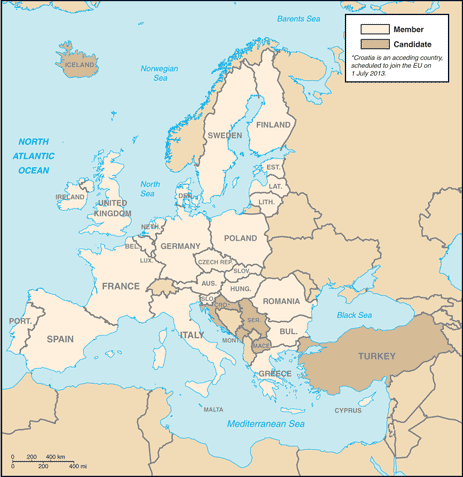
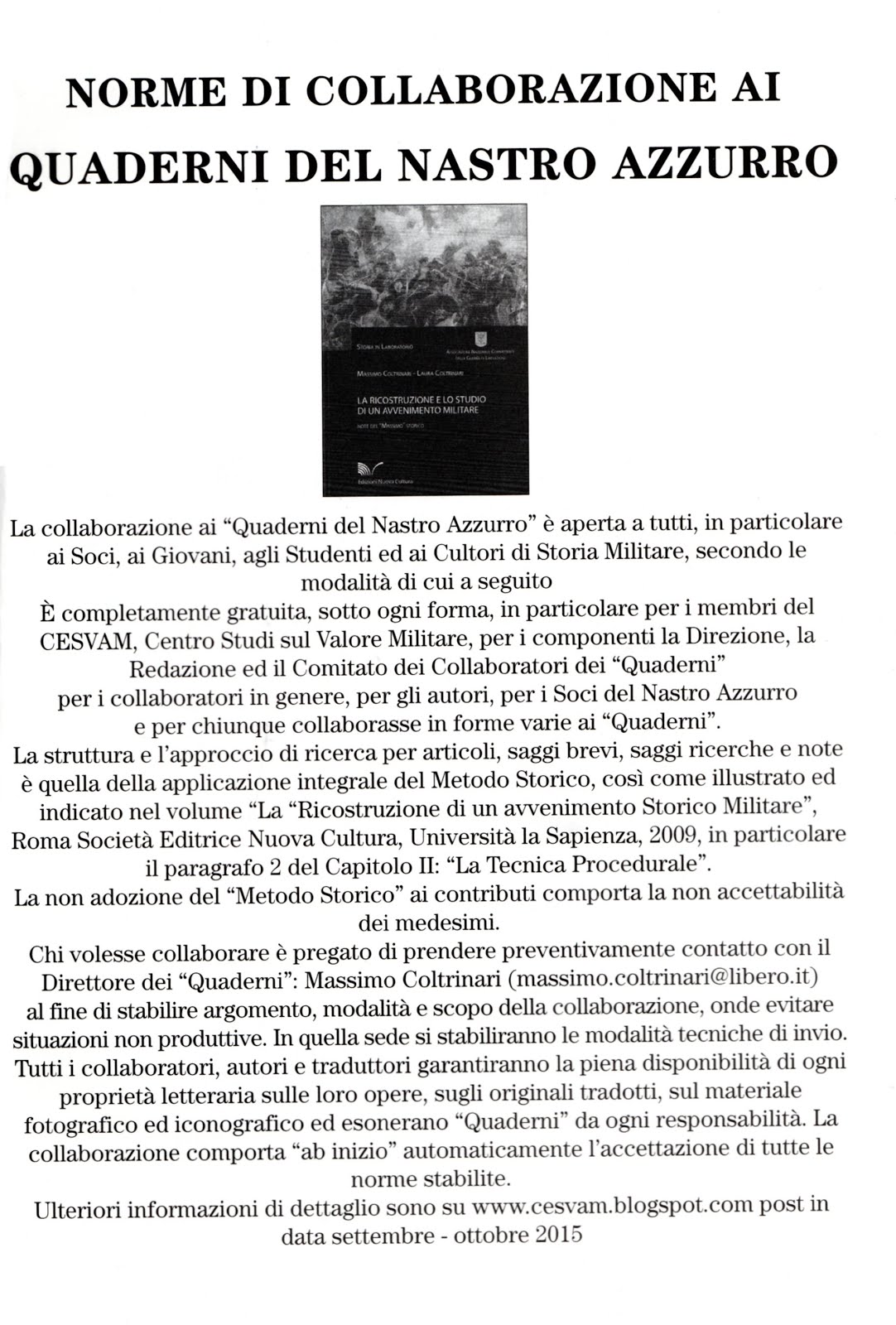



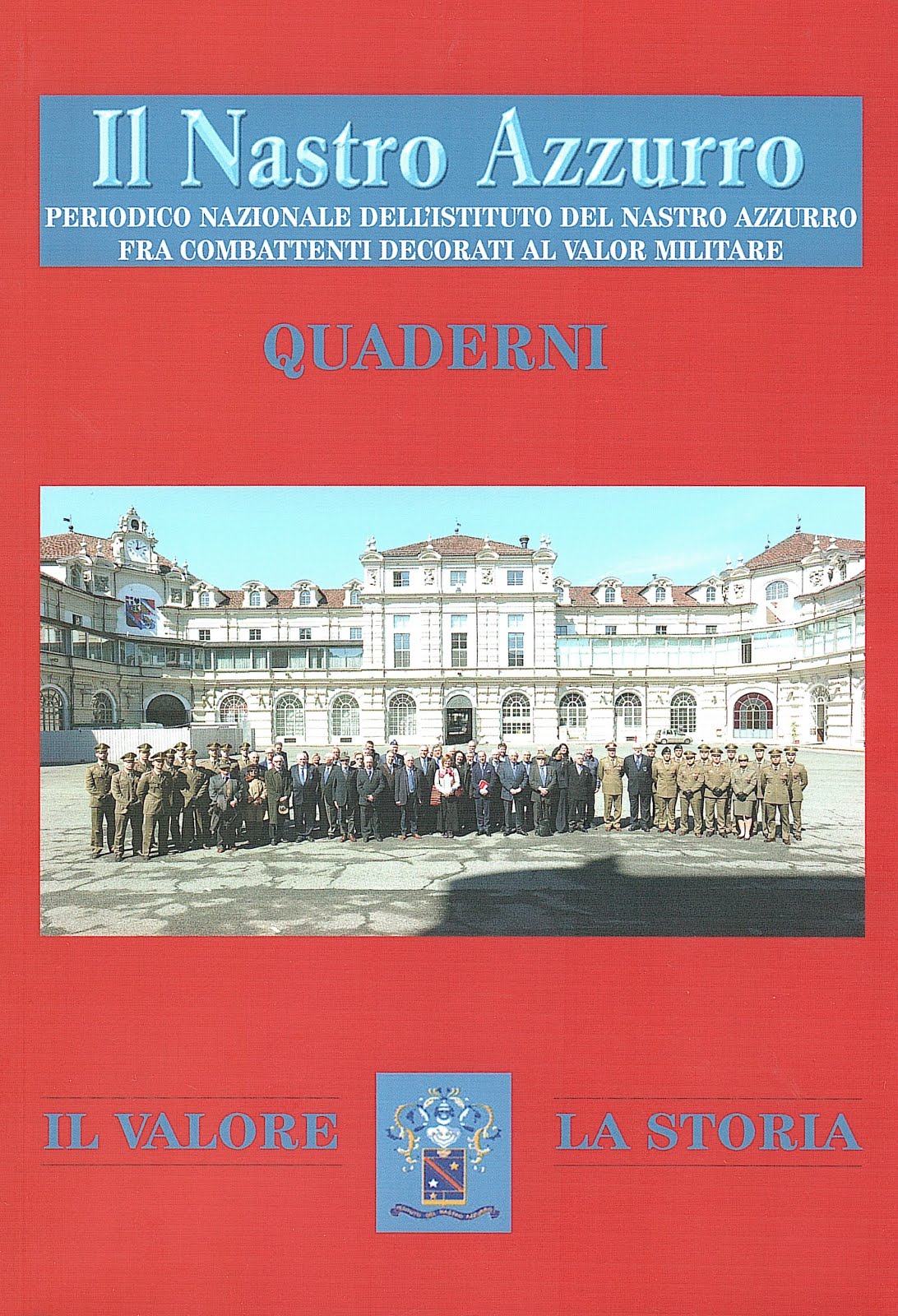
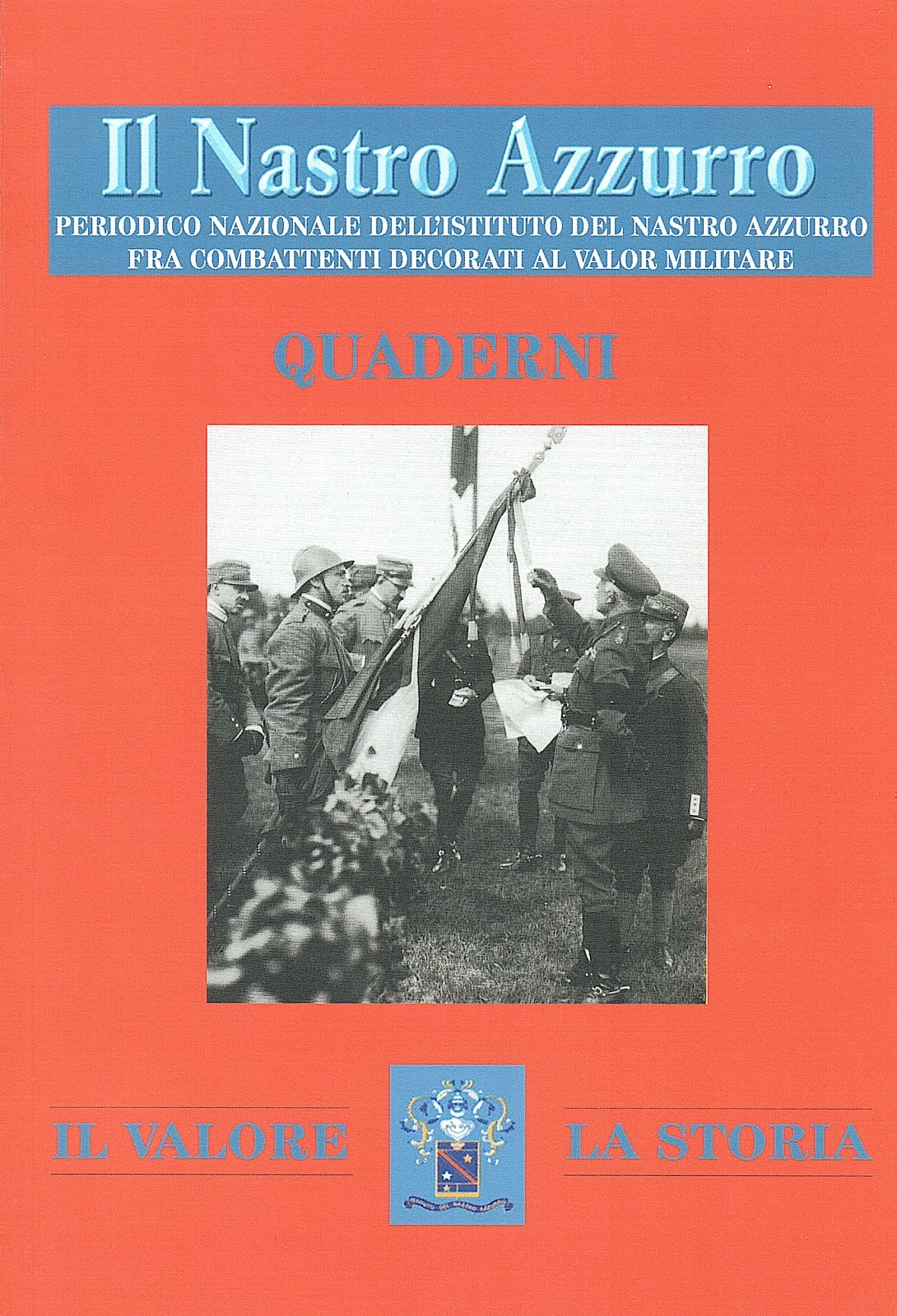


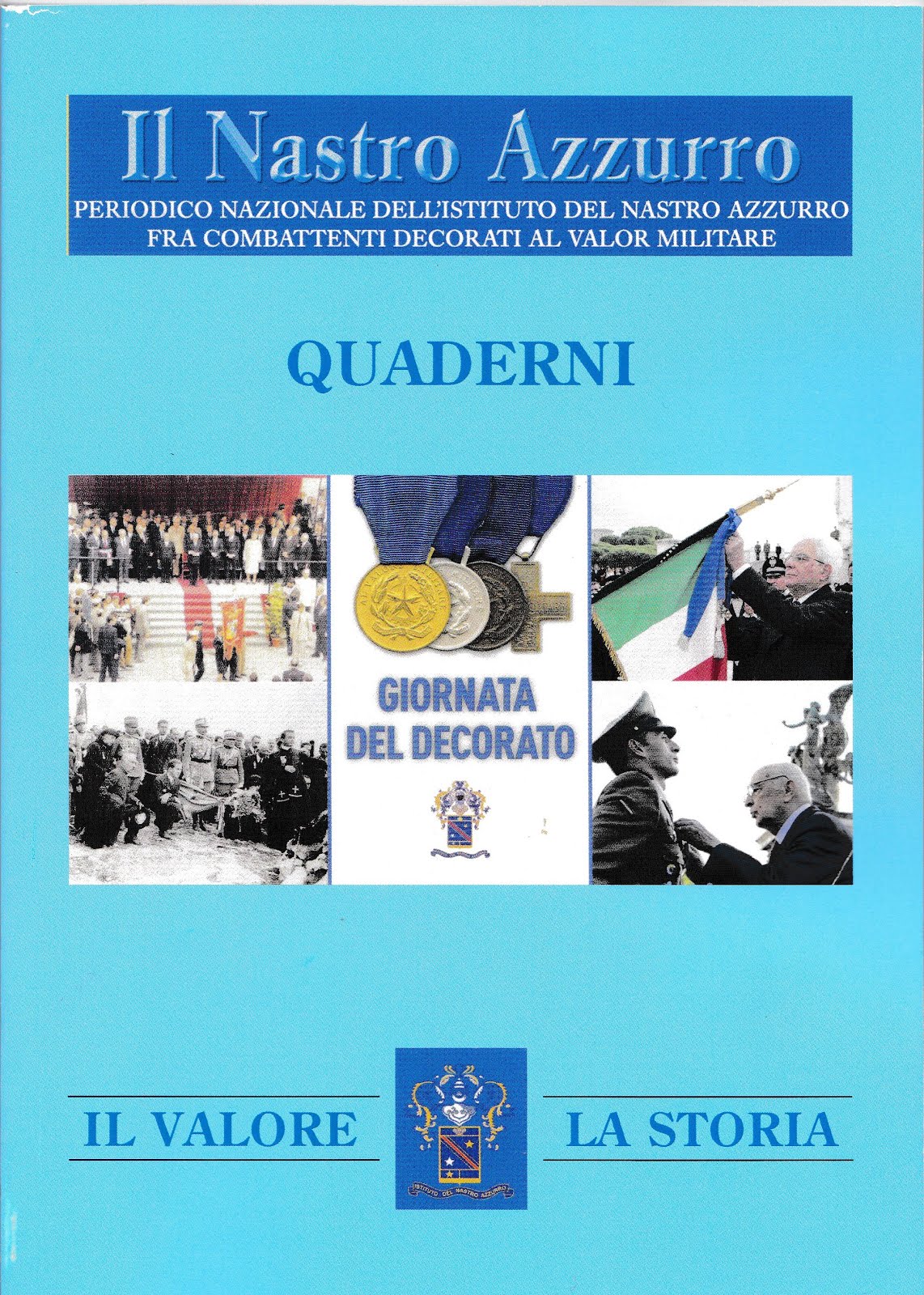
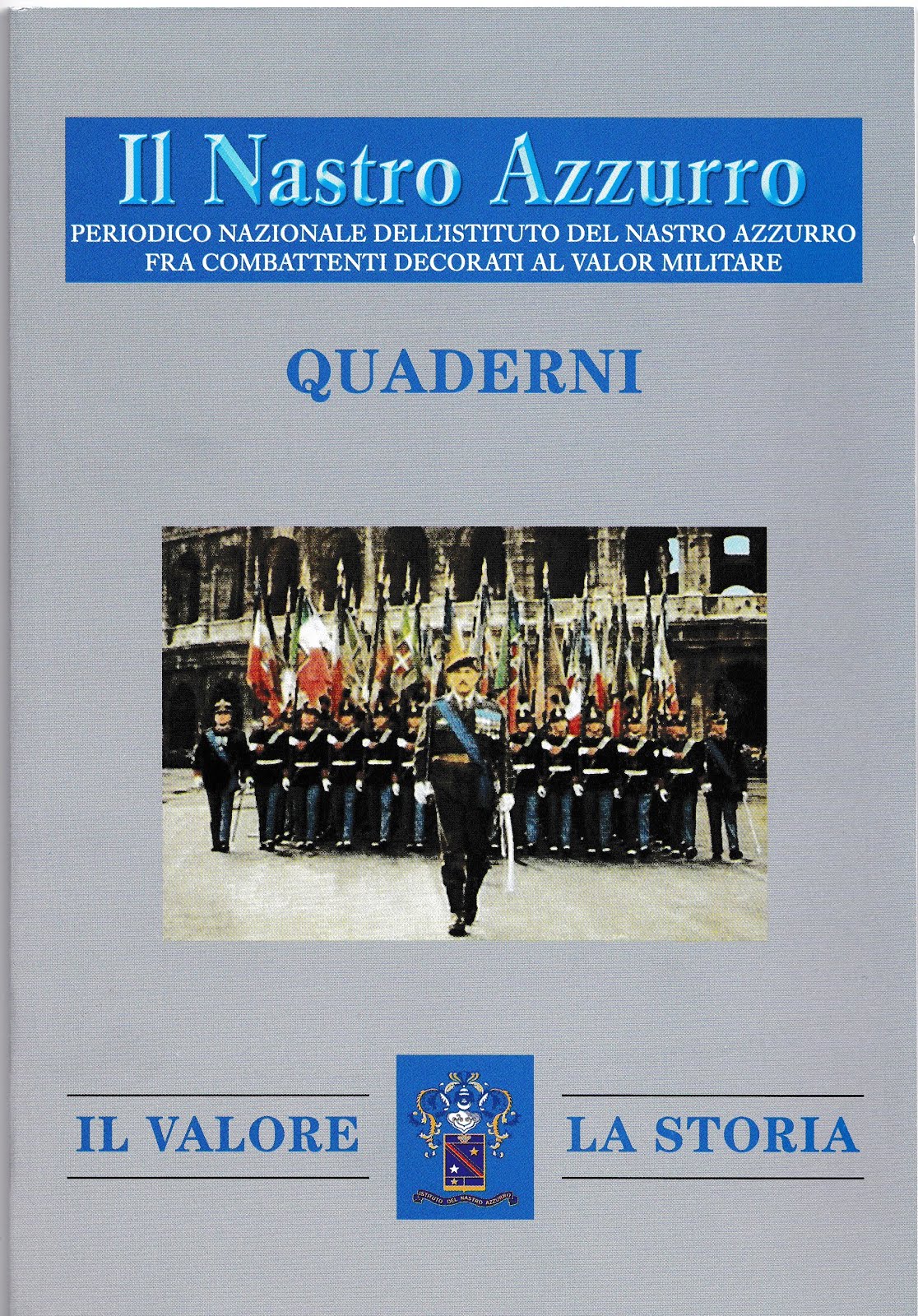

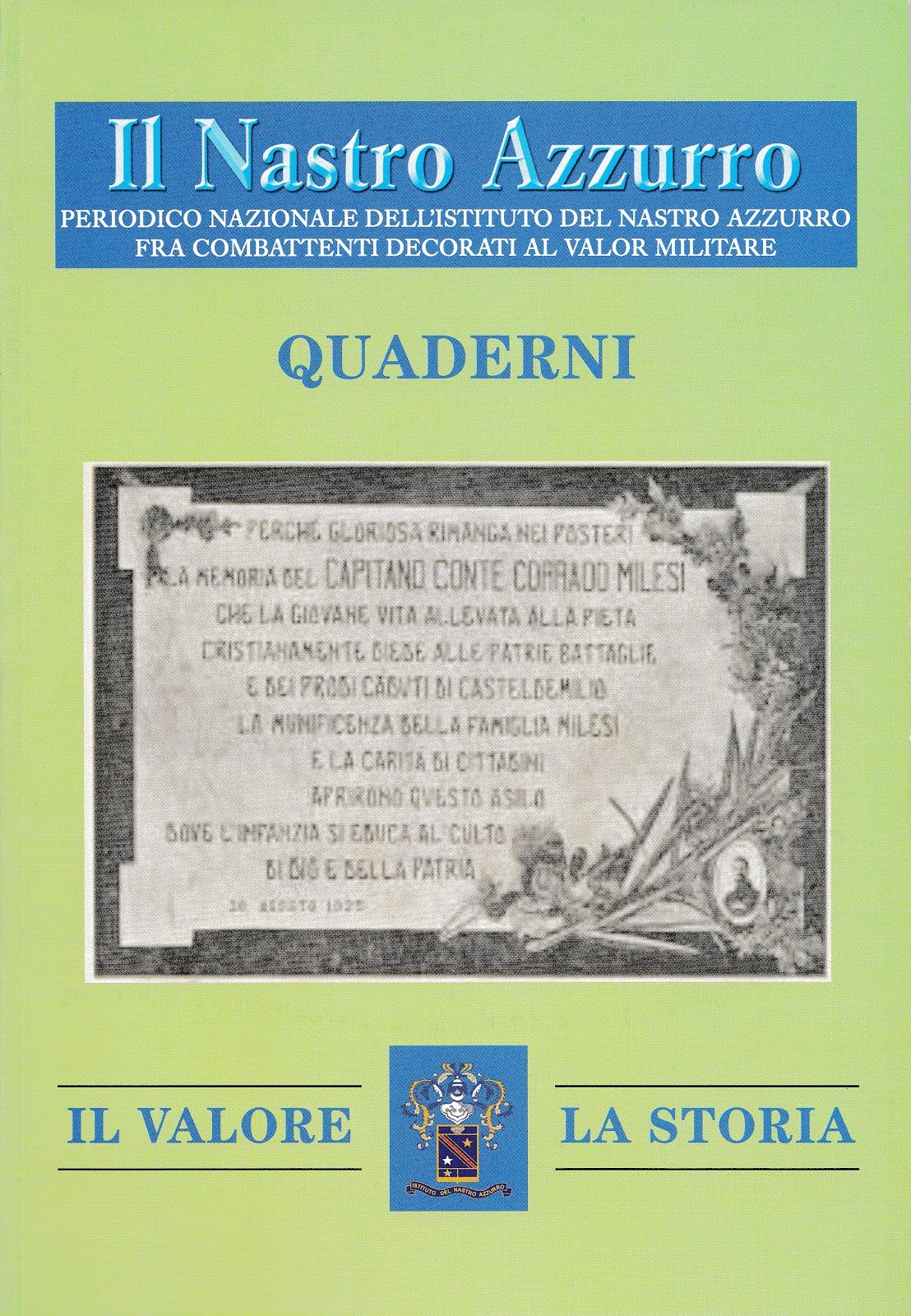
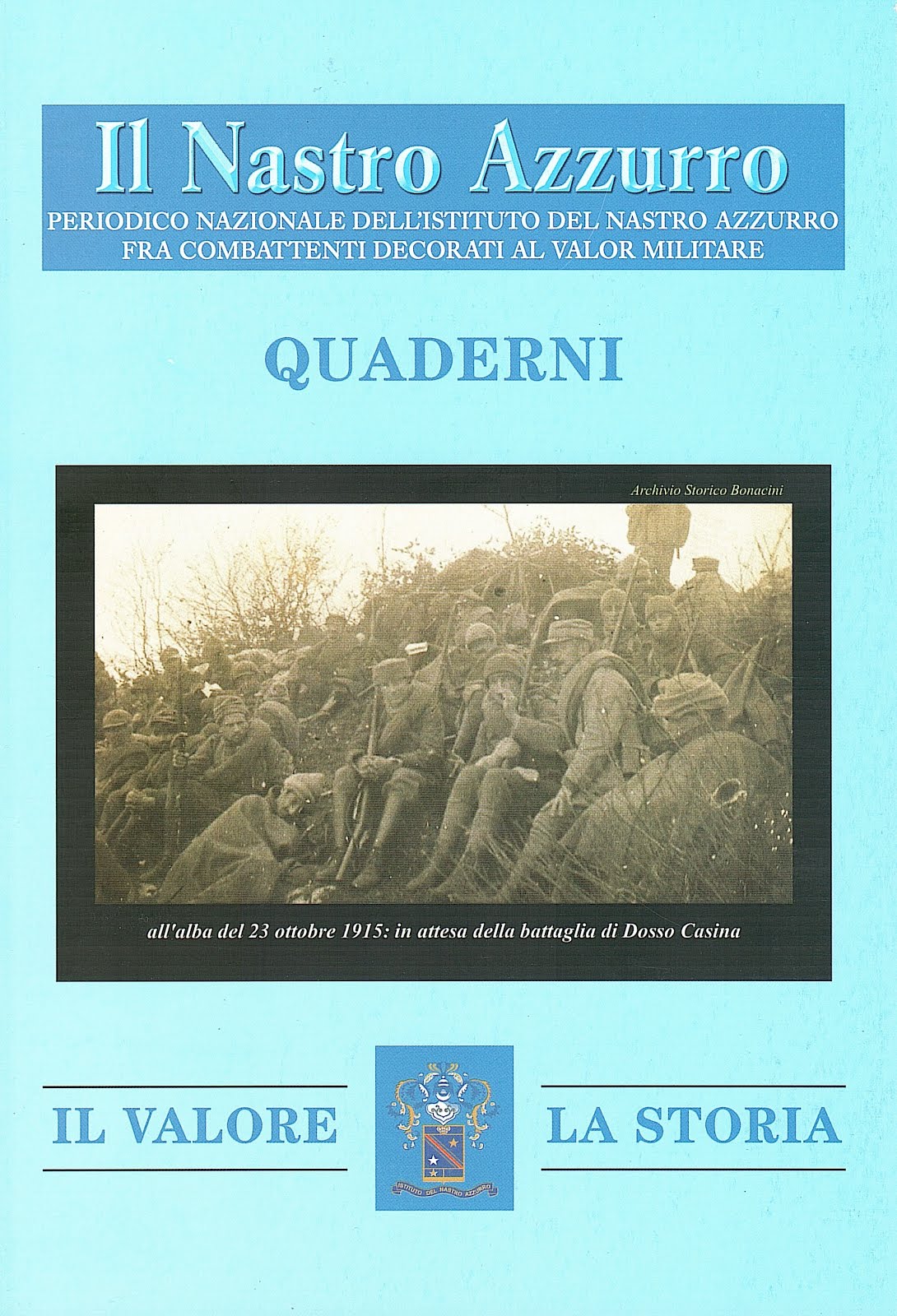

























































.jpg)



