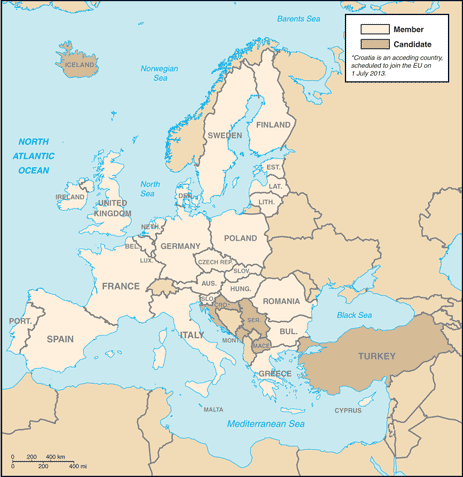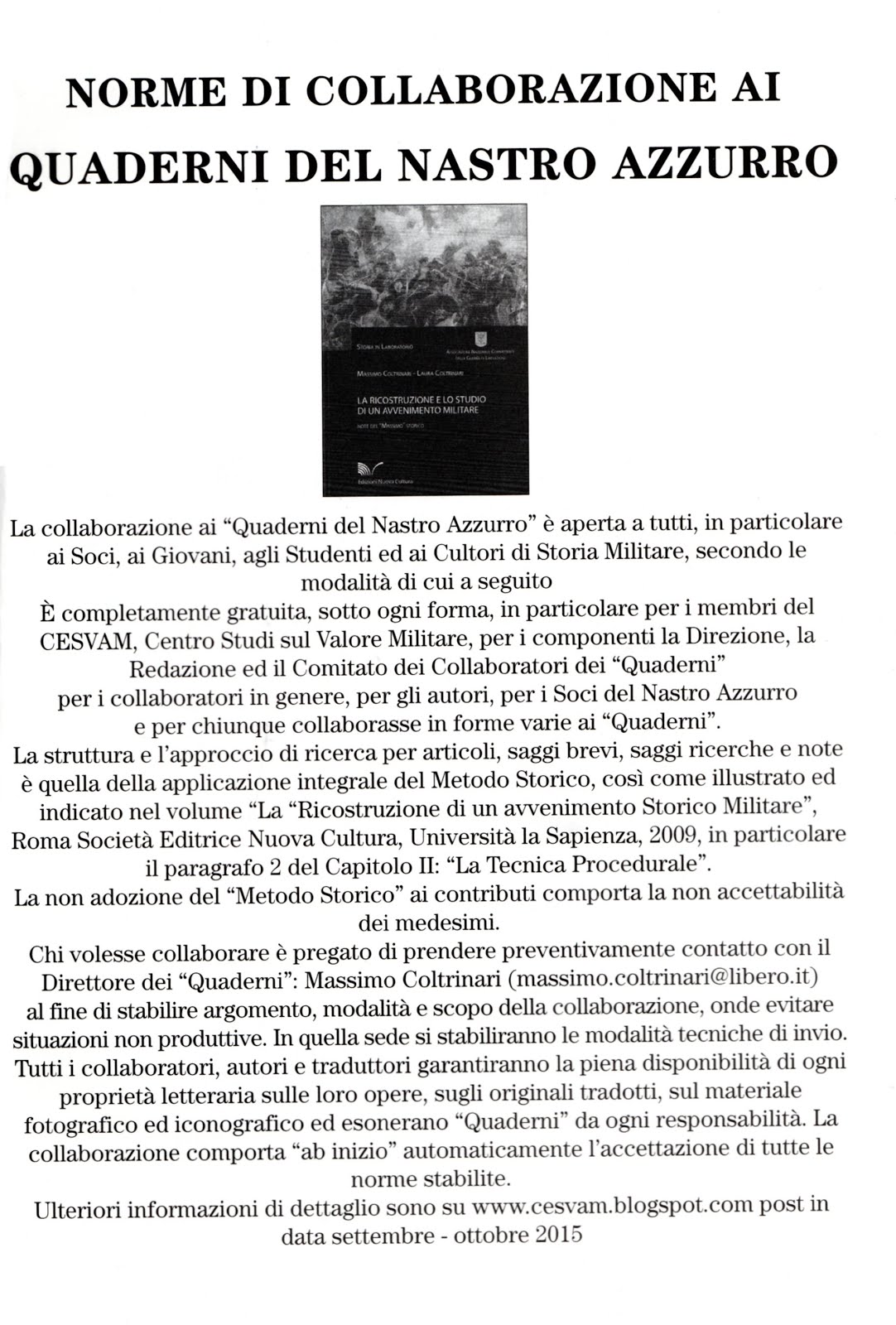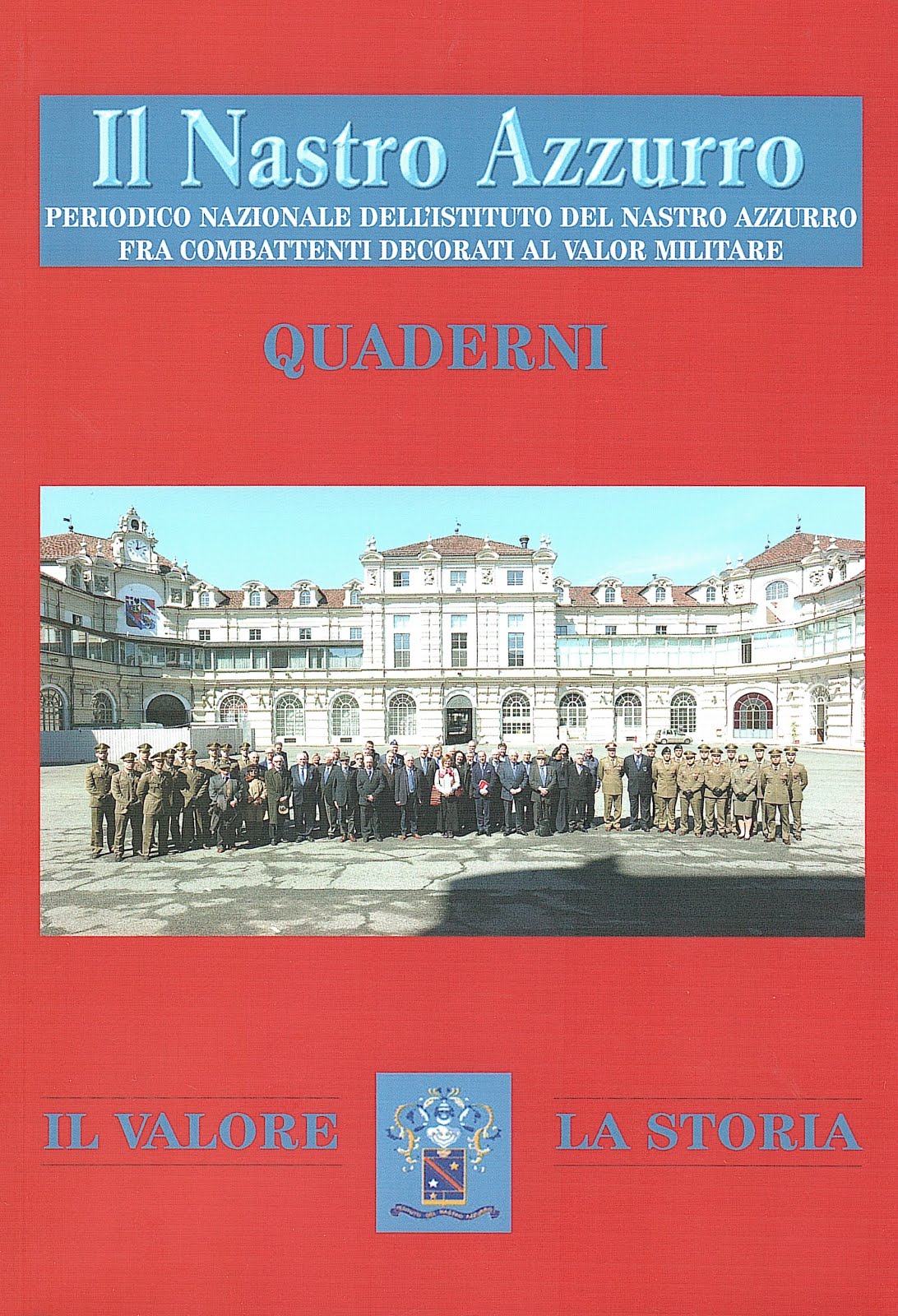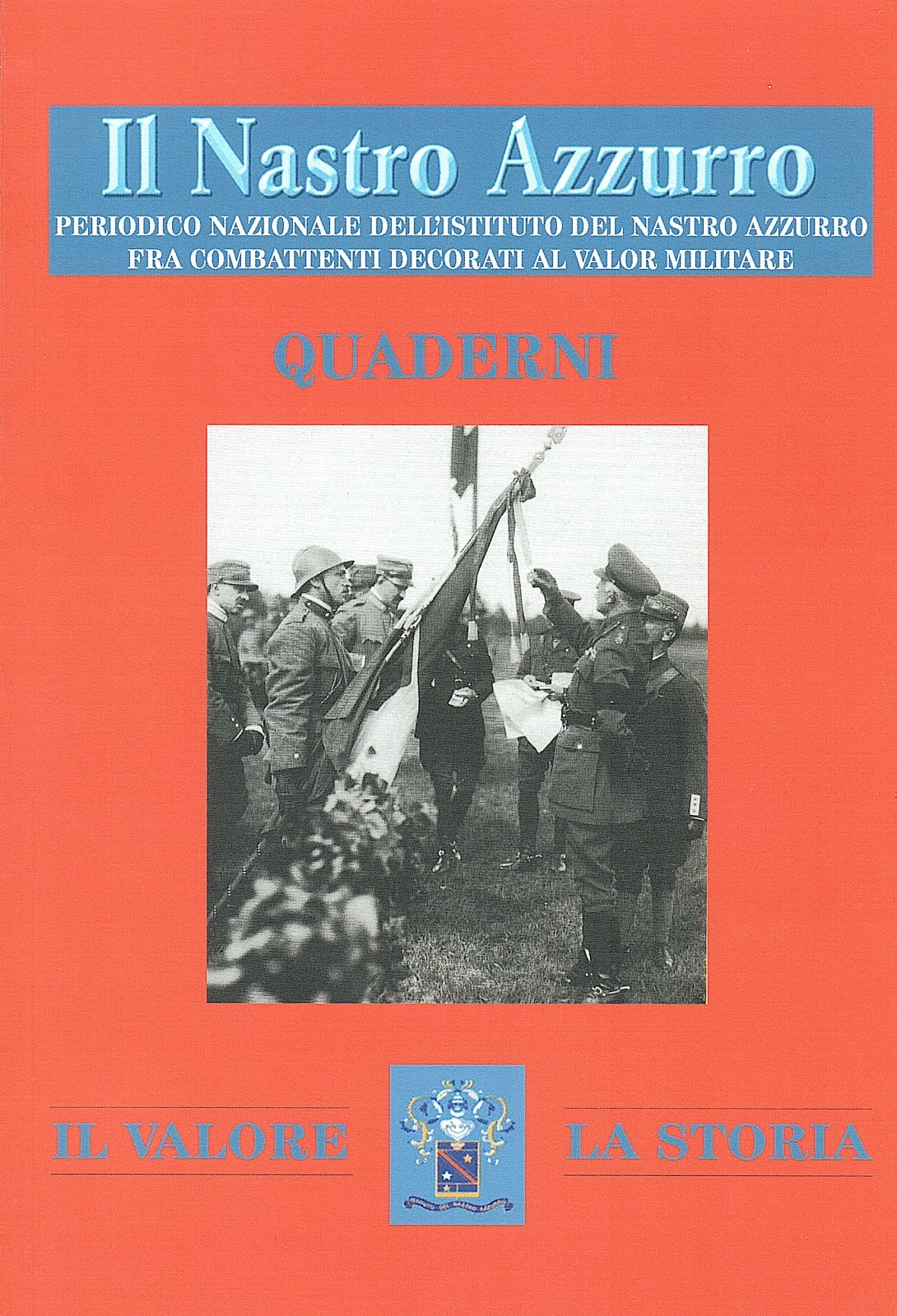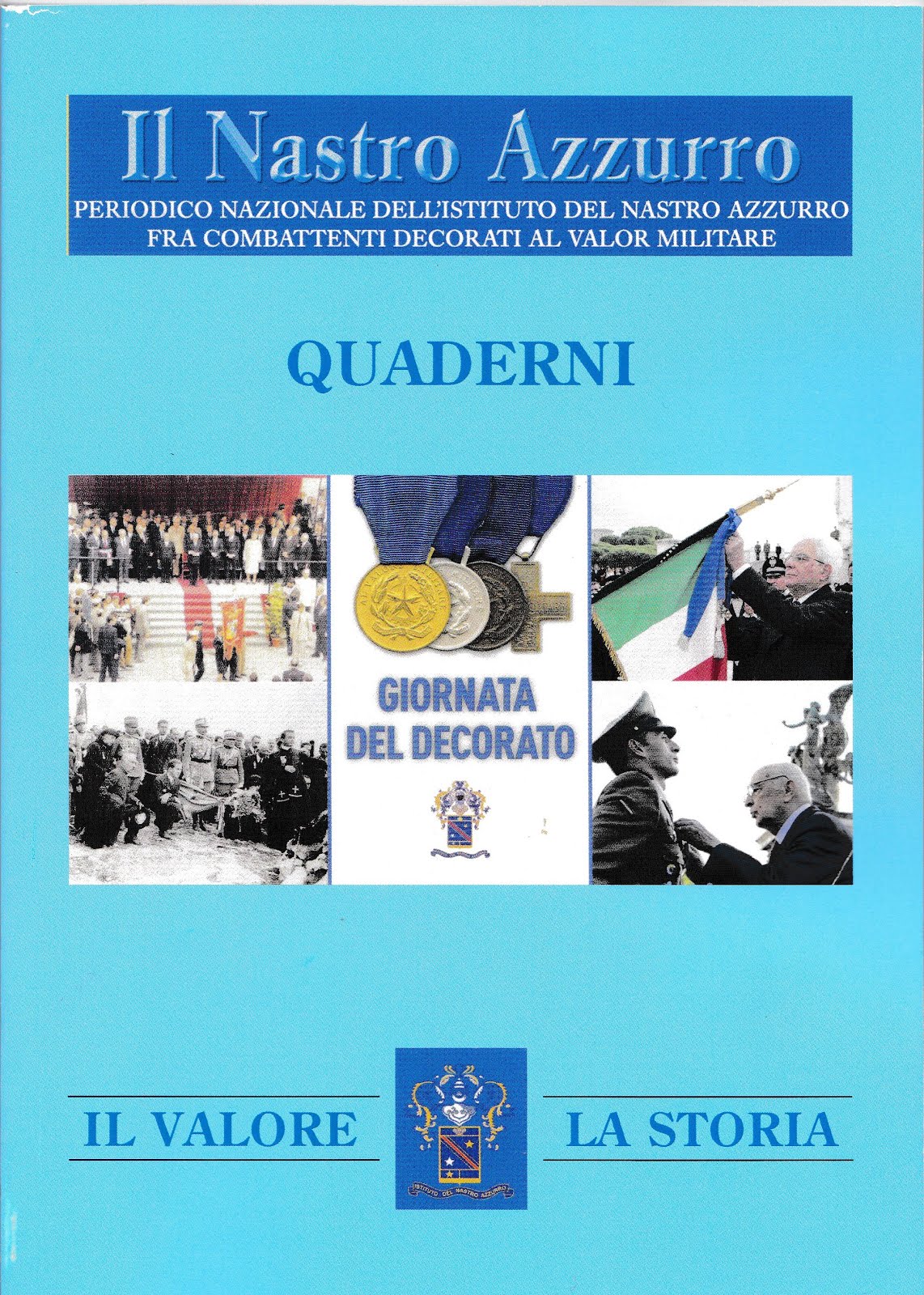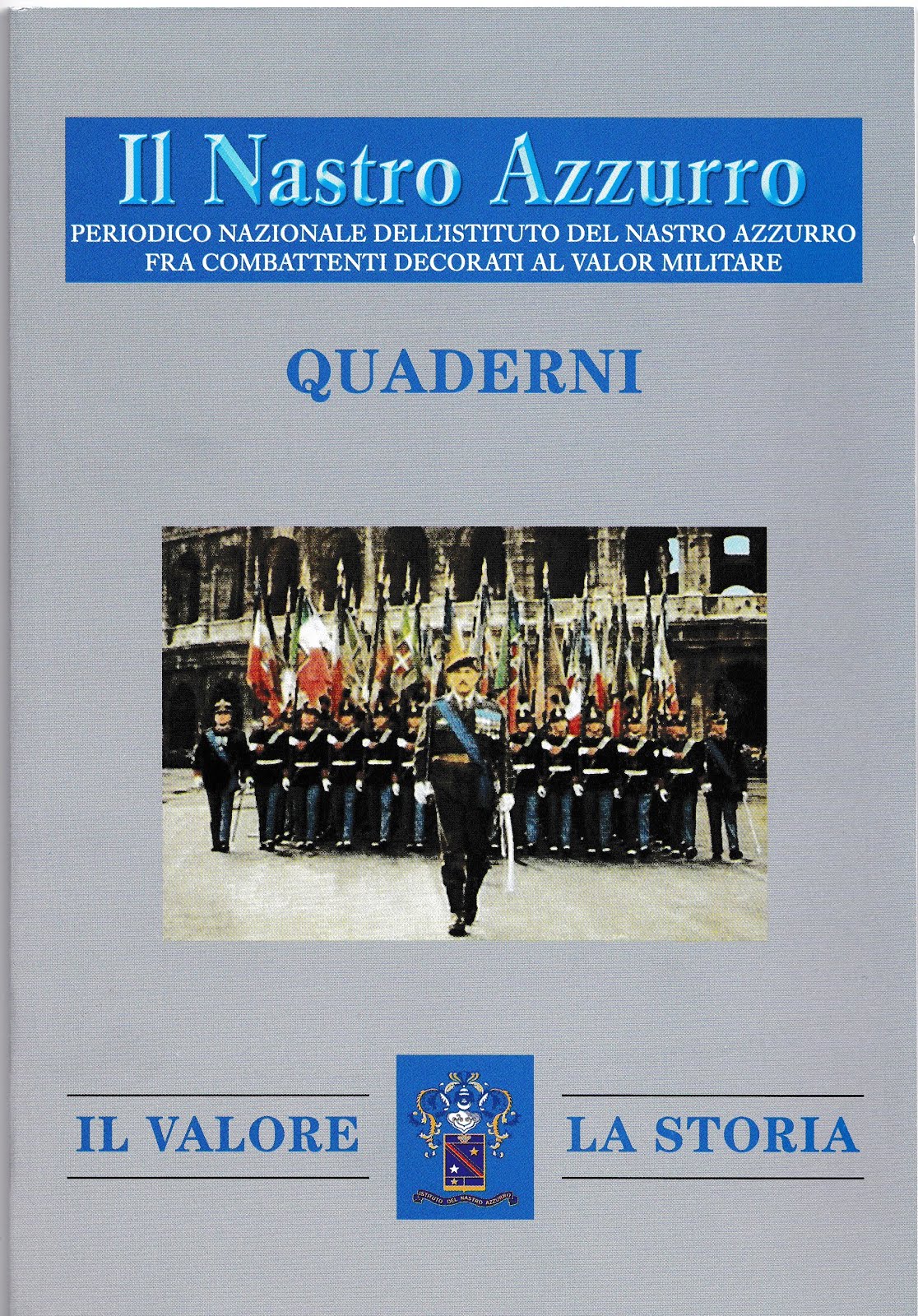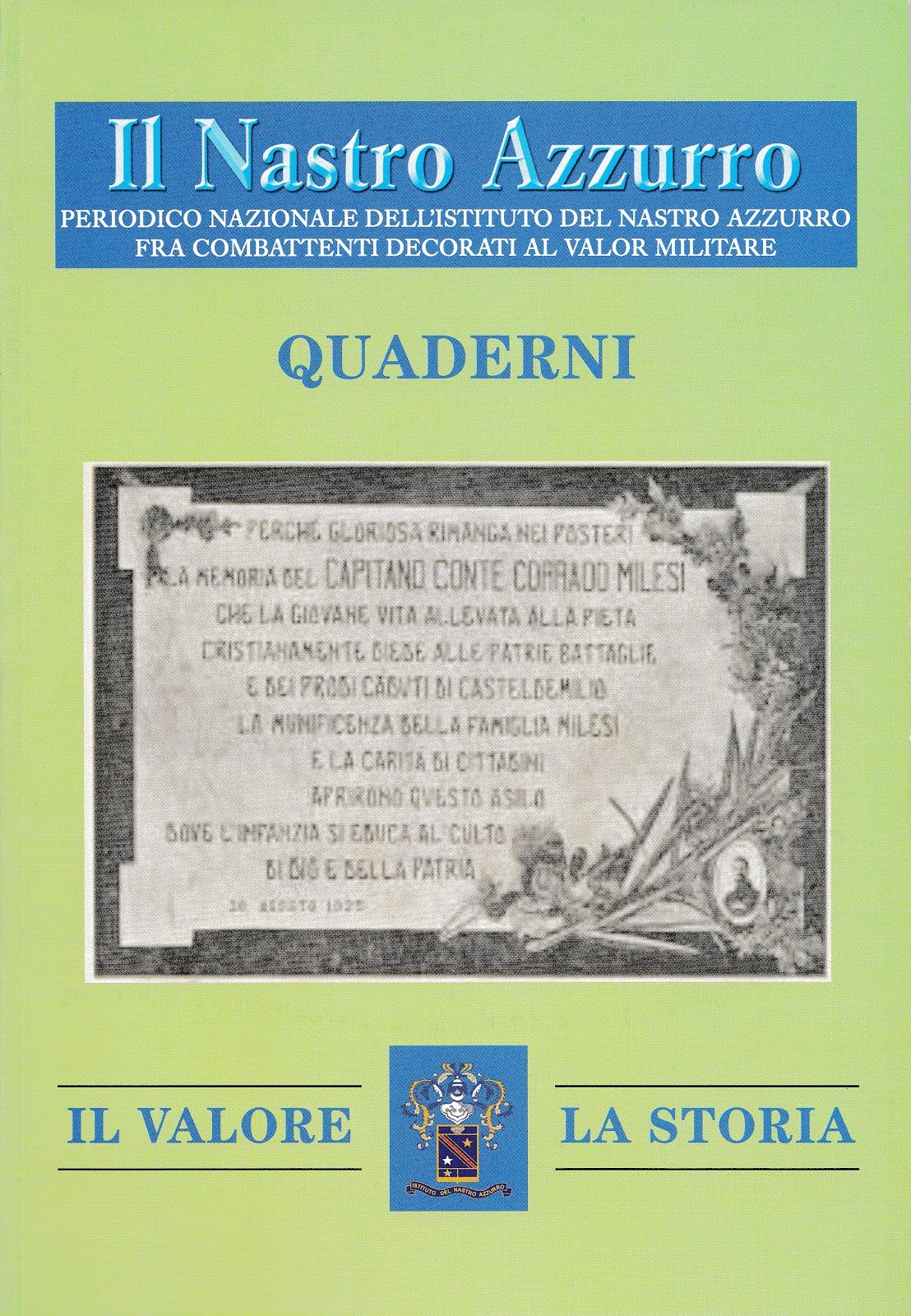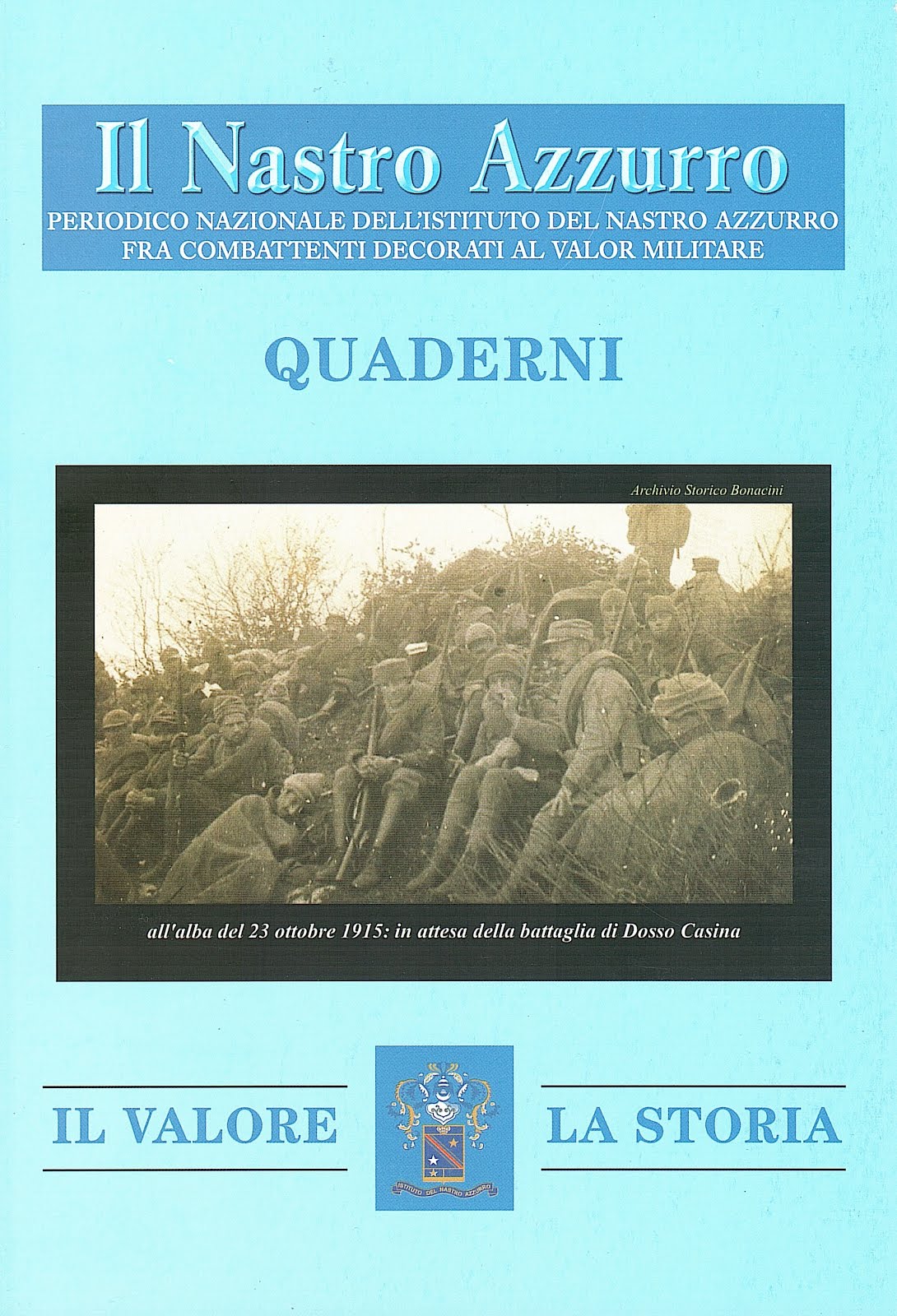| Politica economica europea Il piano d’investimenti di Juncker, cronaca di una morte annunciata Alessandro Giovannini, Ilaria Maselli 07/12/2014 |
|
 L’incapacità dell’eurozona di uscire in modo deciso dalla crisi è confermata dai dati pubblicati questa settimana dall’Ocse. Dal 2012 a oggi, la crescita complessiva del Pil del continente è stata negativa: -0.3%, a fronte di una crescita del 6.7% negli Stati Uniti.
L’incapacità dell’eurozona di uscire in modo deciso dalla crisi è confermata dai dati pubblicati questa settimana dall’Ocse. Dal 2012 a oggi, la crescita complessiva del Pil del continente è stata negativa: -0.3%, a fronte di una crescita del 6.7% negli Stati Uniti.Le previsioni per i prossimi anni non sono necessariamente migliori: per il biennio 2015-2016 l’Ocse stima una crescita del 2.7% nella zona euro contro un 6% oltreoceano. Uno scenario ancora più desolante se si considera che in passato queste stime si siano rivelate sbagliate per eccesso di fiducia nella crescita.
Rilanciare l’economia europea
La performance deludente delle economie nostrane rende sempre più evidente l’imperfezione dell’architettura dell’eurozona: l’assenza di una politica fiscale condivisa che sappia controbilanciare in modo efficace le divergenze interne e assicurare un sentiero generale di crescita economica per l’intera unione monetaria.
Una politica economica simile alla politica monetaria della Bce, la quale ha come principale obiettivo il livello di inflazione generale dell’eurozona, non quello nei singoli paesi.
Davanti a questi dati molti governi europei hanno chiesto da un lato di allentare la morsa delle politiche restrittive per quei paesi con deficit di bilancio eccessivo, e dall’altro, un maggiore impulso economico da parte di quelle economie, come la Germania, in cui le attuali condizioni fiscali permettono una politica espansiva più decisa.
Abbastanza per rilanciare la crescita? Sicuramente no: le concessione accordate all’Italia (così come alla Francia) in termini di maggiore flessibilità di bilancio, difficilmente riusciranno a imprimere un cambiamento economico significativo.
Piccole modifiche al margine nel deficit pubblico possono al massimo evitare l’impatto negativo di ulteriori tagli, ma difficilmente porteranno una spinta economica decisiva.
Pacchetto Juncker
Un vento di novità sembra essere arrivato dalla nuova Commissione europea a guida Jean Claude Juncker: il lancio di un pacchetto che ha come obiettivo la mobilizzazione di 315 miliardi di euro in investimenti nel corso dei prossimi tre anni (pari a circa l’1% del Pil europeo ogni anno).
Senza voler ricoprire lo sfortunato ruolo di cassandre, è prevedibile che le grandi aspettative saranno probabilmente disattese.
In primo luogo perché i fondi effettivamente previsti a garanzia per il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) sono per ora 21 miliardi (di cui solamente 13 esplicitamente individuati con certezza), su cui ci si aspetta un effetto leva di 15 volte grazie al coinvolgimento di altri fondi privati incentivati dalla presenza dell’attore pubblico nell’investimento.
Il secondo motivo per cui ci sentiamo di scrivere questa cronaca di una morte annunciata è che il meccanismo previsto assomiglia molto al pacchetto di 120 miliardi di euro per la crescita europea annunciato a giugno del 2012 dove, come oggi, la maggior parte dei finanziamenti proveniva da una riallocazione delle linee di bilancio, insieme con la speranza partecipazione dei privati.
Un pacchetto il cui impatto è difficilmente ravvisabile sull’economia europea, tanto che neanche la stessa Commissione europea ne fa più menzione.
Ruolo degli stati membri
In questo quadro piuttosto grigio, emerge però un elemento interessante che potrebbe aiutare a comprendere se davvero l’eurozona si sta muovendo verso una gestione migliore e congiunta della politica economica.
Da un lato il piano prevede che gli stati membri abbiano l'opportunità di contribuire con il proprio capitale al Feis senza infrangere le regole del Patto di stabilità.
Dall’altro prevede che la scelta di quali progetti finanziare con tale fondo seguirà una pura logica di merito, senza ipotesi di allocazioni geografiche e quote per paese. In altre parole, i fondi e le garanzie messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti italiana o dallo stesso governo nazionale potrebbero andare a finanziare infrastrutture in Germania o Polonia.
Un apparente controsenso, che tuttavia rappresenta quello che succede davvero quando la politica economica dell’eurozona è veramente unitaria.
Se infatti i fondi della Cassa depositi e prestiti dovessero andare a finanziare progetti di infrastrutture in Germania (perché meglio progettati e più rapidamente implementabili), questo dovrebbe anche beneficiare l'Italia attraverso una crescita per vie indirette dell’export italiano.
Se quindi gli stati membri sono davvero convinti, come spesso hanno ripetuto in questi anni, che quello che serve all’eurozona è una gestione coordinata dell’economia, dovremo aspettarci una forte partecipazione di fondi nazionali al capitale del Feis così come augurato da Juncker e una maggiore possibilità di raggiungere davvero il traguardo di 315 miliardi di investimenti.
Se invece i discorsi degli ultimi anni si dovessero rivelare solamente parole per coprire una logica di ritorno economico nazionale, allora l'incentivo a contribuire al Fondo sarebbe praticamente nullo e il rischio di fallimento del progetto complessivo ancora più alto.
“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”, ripeteva Giulio Andreotti. Che il principio si applichi anche alla politica europea?
Alessandro Giovannini e Ilaria Maselli sono entrambi ricercatori della Economic Policy Unit del Centre for European Policy Studies di Bruxelles.