| Brexit L’azzardo di Cameron e l’imperscrutabile riforma dell’Ue Ettore Greco 27/02/2016 |
|
 Non sarà facile per David Cameron convincere l’elettorato che, se la Brexit fosse bocciata al referendum del 23 giugno, il Regno Unito farebbe parte, grazie all’accordo raggiunto all’ultimo Consiglio europeo, di un’Unione europea, Ue, “riformata”, come ha ripetutamente sostenuto in questi giorni. Nella Decisione approvata a Bruxelles si fa infatti molta fatica a trovare traccia di effettive misure di “riforma” dell’Unione.
Non sarà facile per David Cameron convincere l’elettorato che, se la Brexit fosse bocciata al referendum del 23 giugno, il Regno Unito farebbe parte, grazie all’accordo raggiunto all’ultimo Consiglio europeo, di un’Unione europea, Ue, “riformata”, come ha ripetutamente sostenuto in questi giorni. Nella Decisione approvata a Bruxelles si fa infatti molta fatica a trovare traccia di effettive misure di “riforma” dell’Unione.C’è chi aveva dato credito all’afflato riformatore di Cameron, sperando che il negoziato per evitare la Brexit potesse almeno dare impulso ad alcuni utili cambiamenti al modus operandi dell’Ue. Ma già le concrete richieste avanzate da Cameron il 10 novembre scorso, tutte incentrate su preoccupazioni e interessi tipicamente britannici, avevano spento ogni illusione.
La foglia di fico della riforma
Larga parte di quelle richieste sono state recepite nella Decisione assunta dal Consiglio Europeo il 19 febbraio. È positivo che si sia trovato un compromesso, evitando rotture traumatiche e potenzialmente destabilizzanti, ma da qui a dire che si è così aperta una qualche apprezzabile prospettiva di “riforma” dell’Ue ce ne corre.
Al Vertice è anzi emerso plasticamente lo iato tra le questioni, di portata tutto sommato limitata, su cui si è laboriosamente negoziato con Londra, e i paralleli tentativi di trovare una soluzione a problematiche di urgenza estrema - a partire dalla crisi migratoria- che stanno rimettendo in causa la stessa ragion d’essere dell’Ue. Di qui anche l’atmosfera un po’ surreale dell’incontro.
La Decisione del Consiglio Europeo include, a dire il vero, una sezione, quella sulla competitività, dedicata a un aspetto cruciale della riforma dell’Ue, ma si tratta della parte più debole del documento, essendo del tutto priva di efficacia cogente.
I 28 si sono infatti limitati a reiterare in una “Dichiarazione” l’impegno alla semplificazione burocratica e legislativa - peraltro parte integrante del programma della Commissione Europea - senza offrire nuove indicazioni o strumenti per il superamento degli ostacoli politici e tecnici che ne hanno finora frenato l’attuazione.
Integrazione differenziata
In realtà, quando Cameron parla di “Unione riformata”, sembra aver in mente soprattutto la sezione del documento sulla “sovranità” che sancisce, fra l’altro, lo status speciale del Regno Unito all’interno dell’Ue, con i suoi vari “opt-outs”, esentando Londra dall’impegno a realizzare un’”unione sempre più stretta”, e riconosce la possibilità che i paesi membri seguano differenti percorsi d’integrazione.
Quest’ultimo punto non è una grande innovazione: già nelle conclusioni dell’incontro del 26-27 giugno 2014 il Consiglio Europeo aveva esplicitamente ammesso la possibilità di un’integrazione differenziata, sminuendo la portata della clausola dell’”unione sempre più stretta”. Cameron può però legittimamente sostenere che questa volta il principio della differenziazione è stata formulato in modo più netto.
Un contributo alla chiarezza, se si vuole, ma resta da capire se e come una progressiva differenziazione – ammesso che questo sia il destino dell’Ue – sia compatibile con il mantenimento di un quadro istituzionale coerente. Anche perché il documento approvato al vertice sottolinea al contempo la necessità che, in ossequio ai trattati, si sviluppi ulteriormente il processo di integrazione dell’eurozona. Le nuove forme di governance da adottare per un’Unione a integrazione differenziata restano un nodo ancora tutto da sciogliere. Tuttavia, si può sostenere che l’accordo del 19 febbraio contribuisce a dare maggiore risalto alla questione.
Mossa difensiva
Quanto allo status speciale per il Regno Unito, si tratta di una mossa difensiva che ha ben poco a vedere con la “riforma” dell’Ue. L’obiettivo dichiarato di Londra è di proteggersi dalla prospettiva di un’ulteriore integrazione politica, mettendo al sicuro i suoi residui poteri sovrani. Molti dubitano però che l’esenzione dalla clausola dell’Unione più stretta serva davvero allo scopo. Sarebbe peraltro incorporata nei trattati solo in occasione della loro “prossima revisione”, cioè in un futuro imprecisato.
Molto più significativa e concreta è la parte della Decisione che mira a salvaguardare gli interessi e i diritti dei Paesi che non fanno parte dell’eurozona, evitando discriminazioni, ma anche escludendo ogni potere di blocco da parte dei non-euro su ulteriori progressi nell’ambito dell’Unione economica e monetaria. Su questo aspetto si è, in effetti, raggiunto un apprezzabile punto di equilibrio fra opposte esigenze.
L’accordo non prevede in ogni caso alcun rimpatrio di poteri da Bruxelles - men che meno il ripristino della supremazia delle leggi nazionali su quelle comunitarie - con grande scorno degli euroscettici, almeno di quelli che si erano fatti delle illusioni, e che ora accusano Cameron, non del tutto infondatamente, di aver tradito le promesse elettorali. D’altronde, non è mai stata formulata, neanche da parte dei tories, un’indicazione precisa sui poteri che Londra dovrebbe riprendersi. Siamo insomma lontani da quel “cambiamento fondamentale” nelle relazioni tra Regno Unito e Ue che Cameron aveva baldanzosamente prospettato.
Incognite
L’accordo è stato presentato dai 28 come legalmente vincolante e perfettamente compatibile con i trattati, ma restano alcune incognite sulla sua attuazione che verranno inevitabilmente rinfacciate a Cameron durante la campagna referendaria. Due soprattutto.
Per entrare in vigore, alcune disposizioni, in particolare quelle che limitano l’accesso dei lavoratori migranti Ue alle prestazioni sociali richiedono modifiche di non poco conto alla legislazione secondaria (anche se difficilmente Cameron riuscirà a dimostrare che possono produrre un effettivo alleggerimento della pressione migratoria).
Per la loro entrata in vigore è quindi necessario l’assenso del Parlamento europeo che non si può dare per scontato. Inoltre, è probabile che scatterebbero alcuni ricorsi alla Corte di giustizia europea che, come paventato, fra gli altri, dal ministro della Giustizia Michael Gove, uno dei membri del gabinetto Cameron favorevole alla Brexit, potrebbe trovare alcune delle nuove norme in contrasto con i trattati (in particolare con il principio di non discriminazione e con quello della libera circolazione delle persone). Già adesso, d’altronde, la disputa politica s’intreccia con quella legale.
Cameron inedito
L’argomento dell’Unione “riformata” grazie all’accordo appare dunque quanto meno stiracchiato. Ed è perciò prevedibile che alla fine non sarà su quello che Cameron farà leva per conquistare gli indecisi. Ben altra presa potrà avere l’evocazione del “salto nel buio” in caso di Brexit a cui infatti il premier britannico sta ricorrendo con crescente intensità.
Cameron si sta in realtà già impegnando in una campagna positiva volta a sottolineare i vantaggi della permanenza nell’Ue. Di più: si è lanciato in un’inedita denuncia dell’”illusione della sovranità” in caso di Brexit, il che equivale a una sorprendente riabilitazione della sovranità condivisa. Resta da vedere come verrà accolto dall’elettorato questo drastico cambiamento di retorica politica dopo anni in cui i leader conservatori, e non solo, hanno condotto una sistematica denigrazione dell’Ue.
Ettore Greco è direttore dell’Istituto Affari Internazionali (IAI).
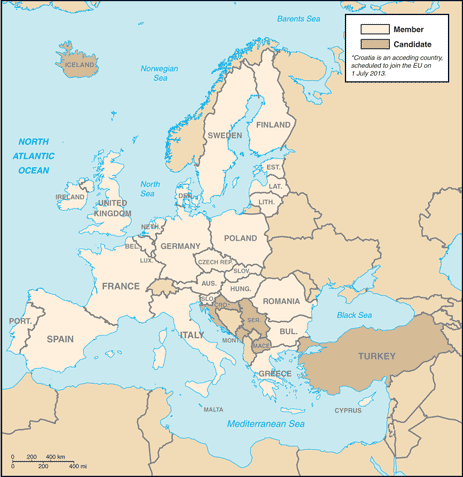
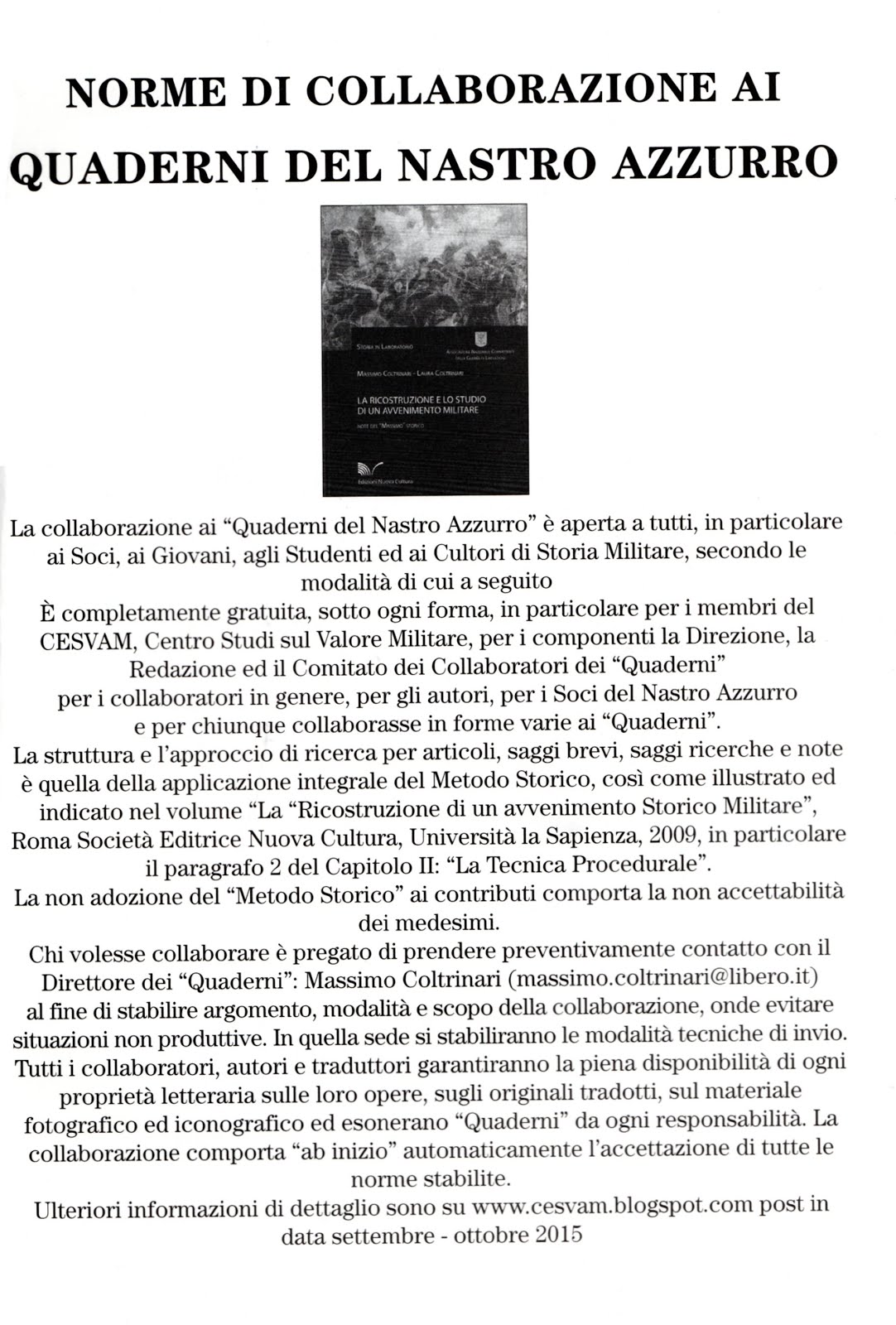



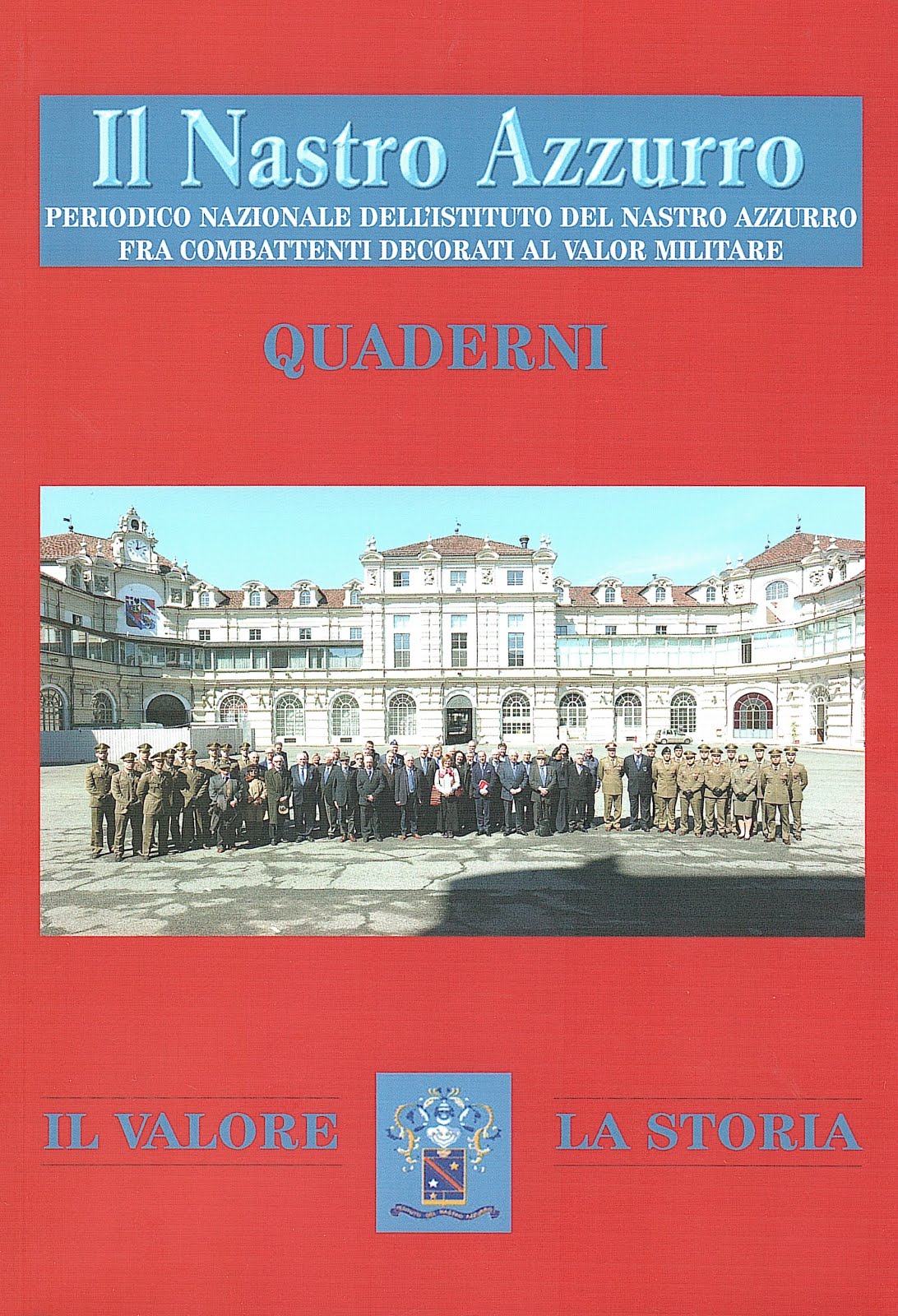
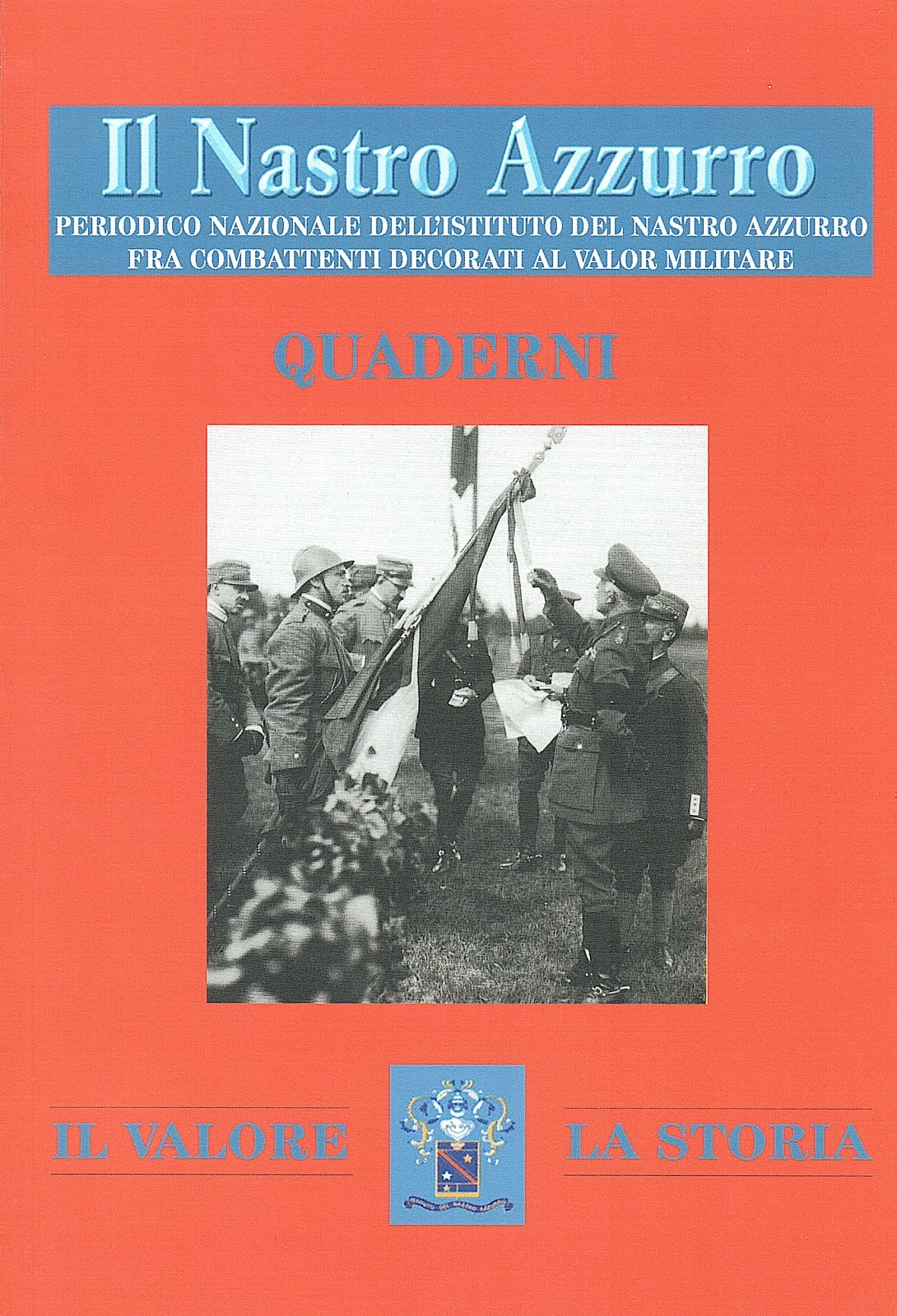


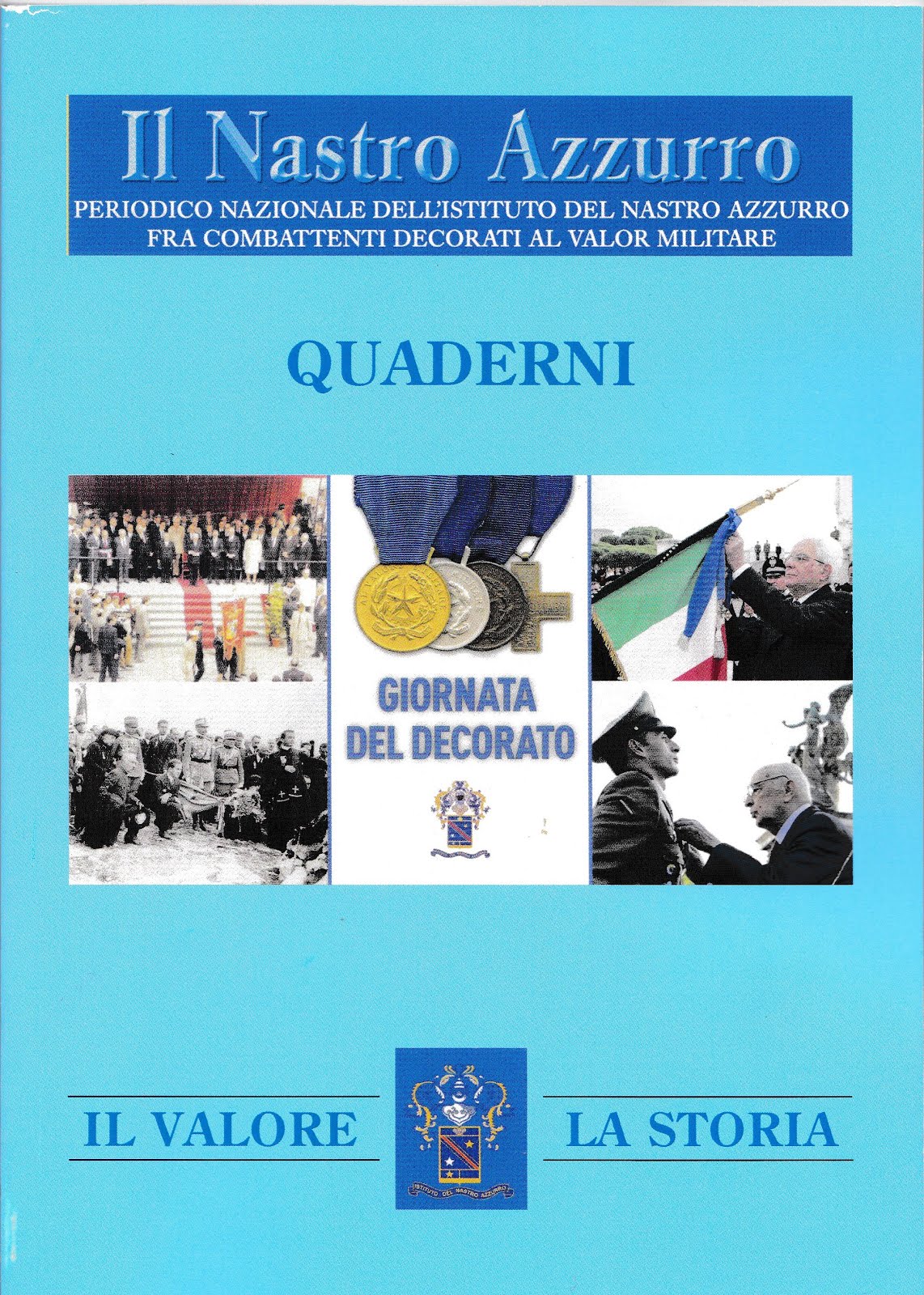
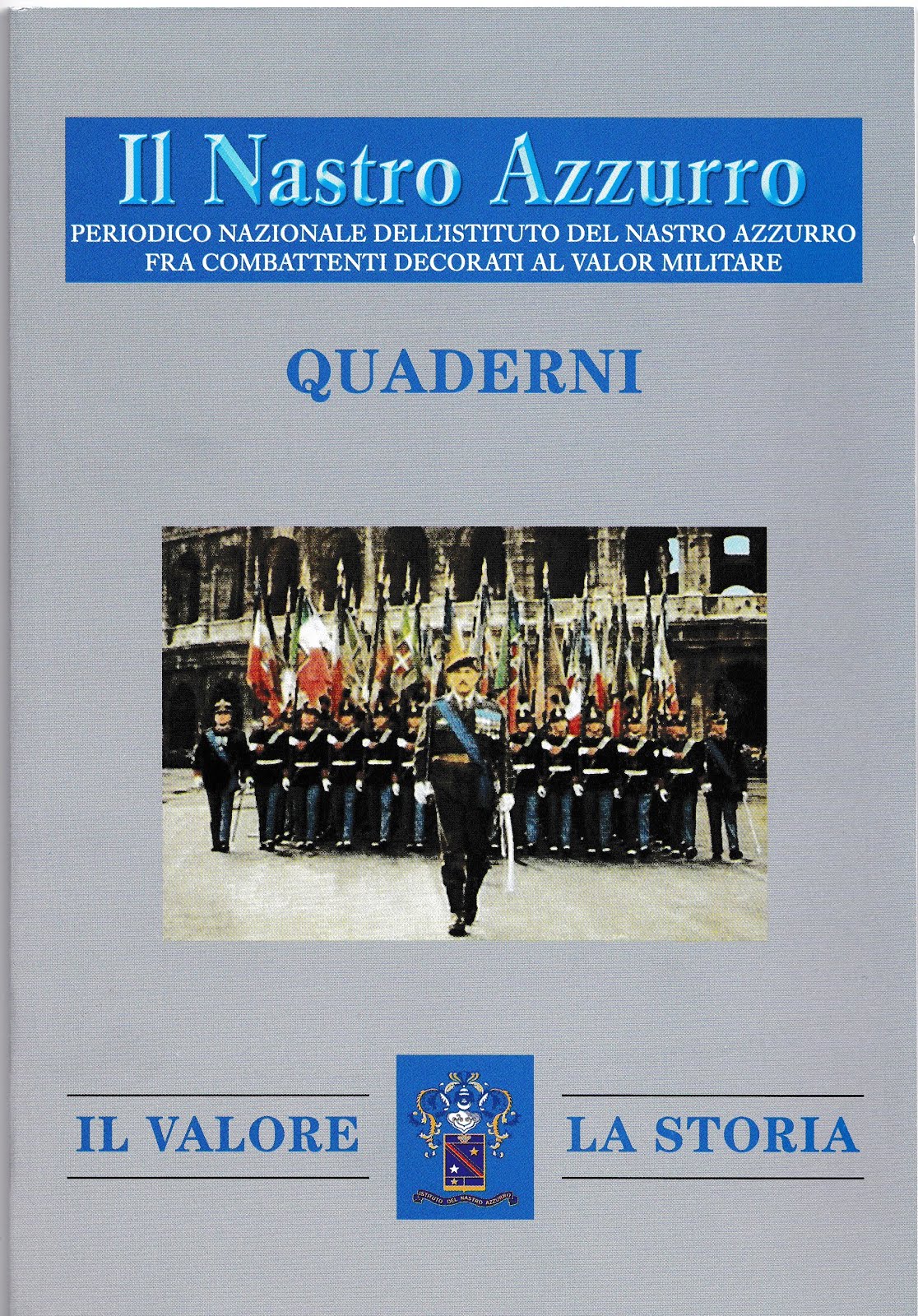

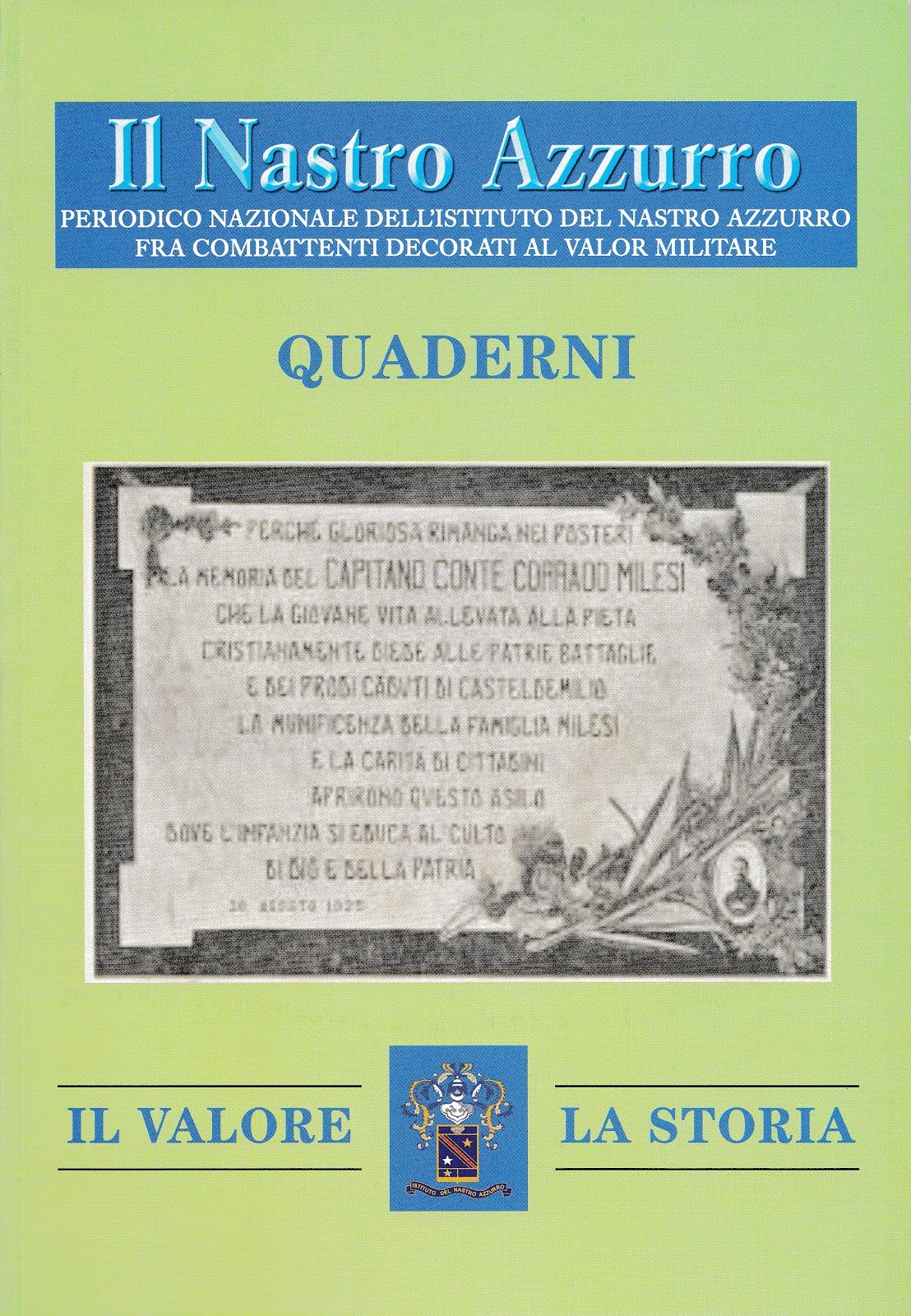
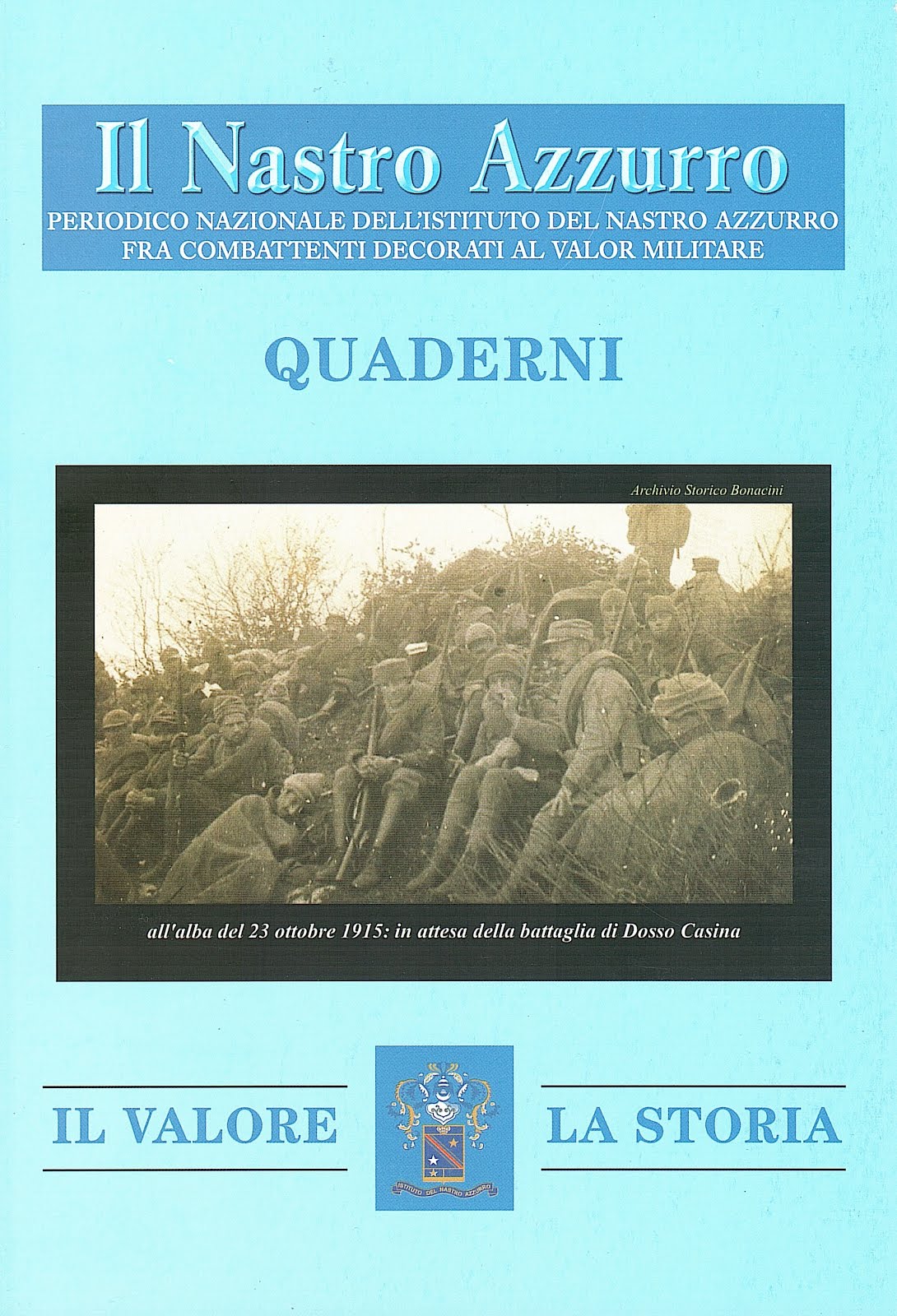






























































.jpg)



