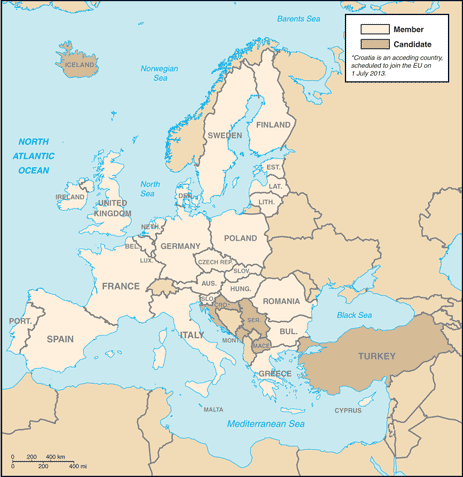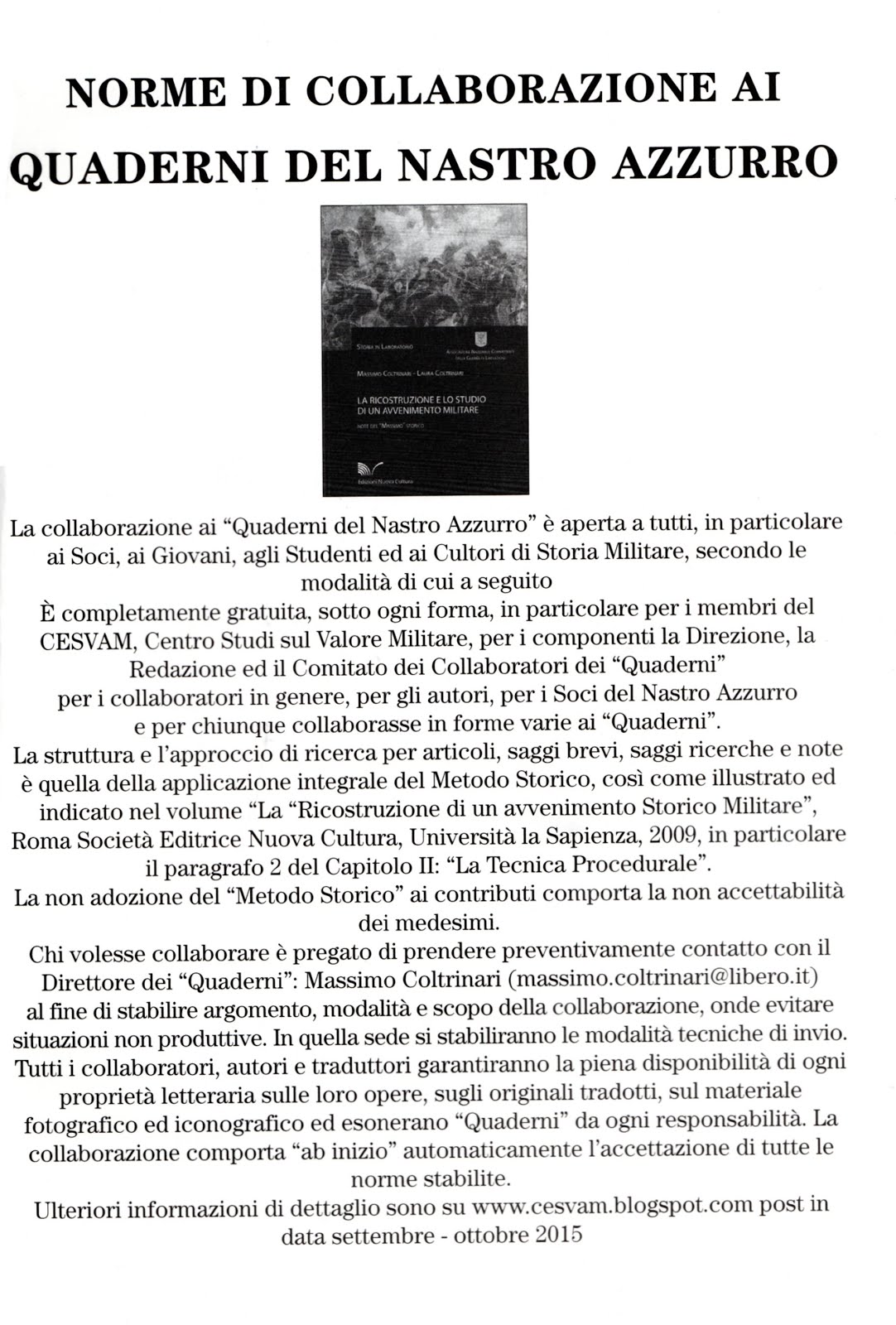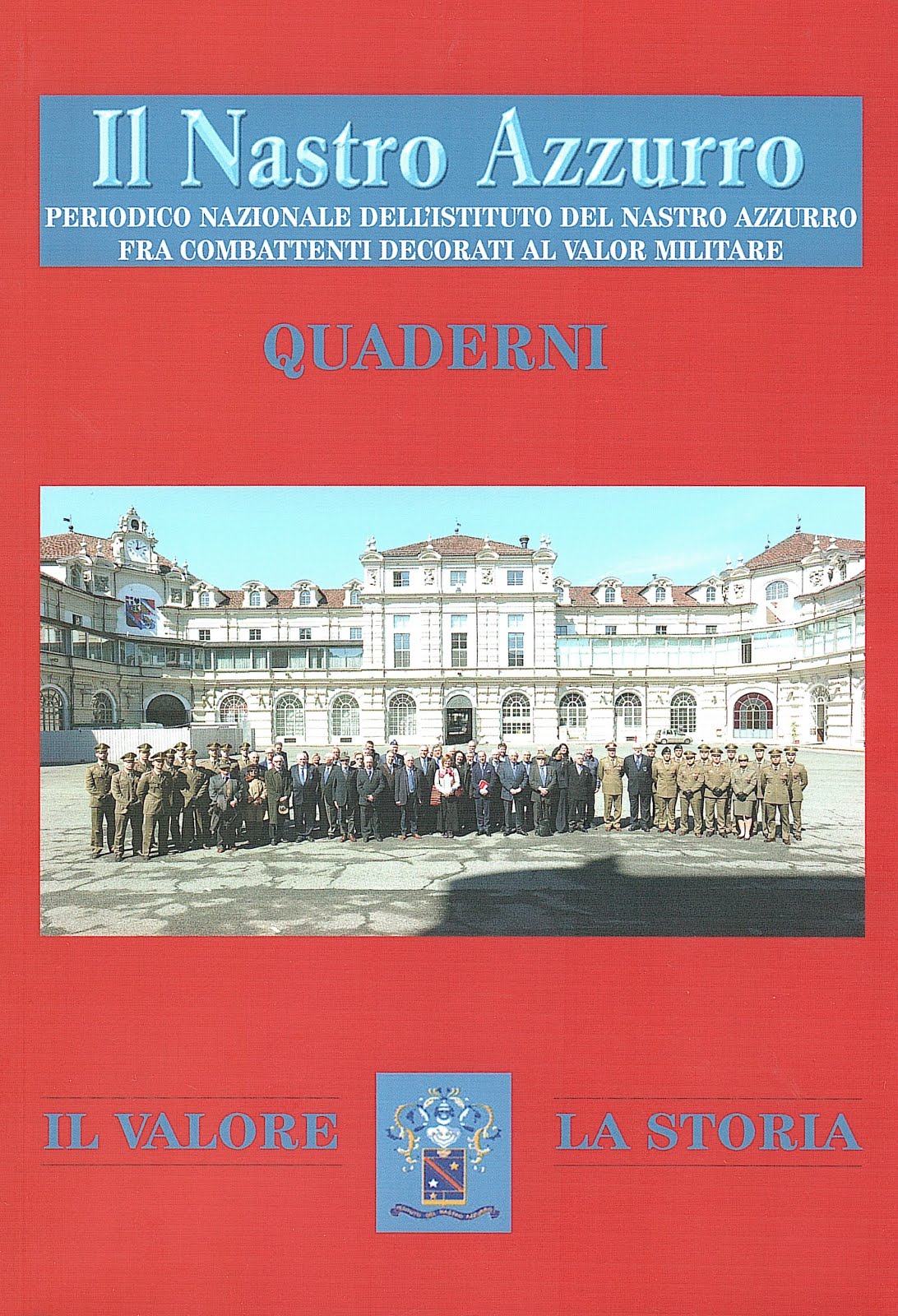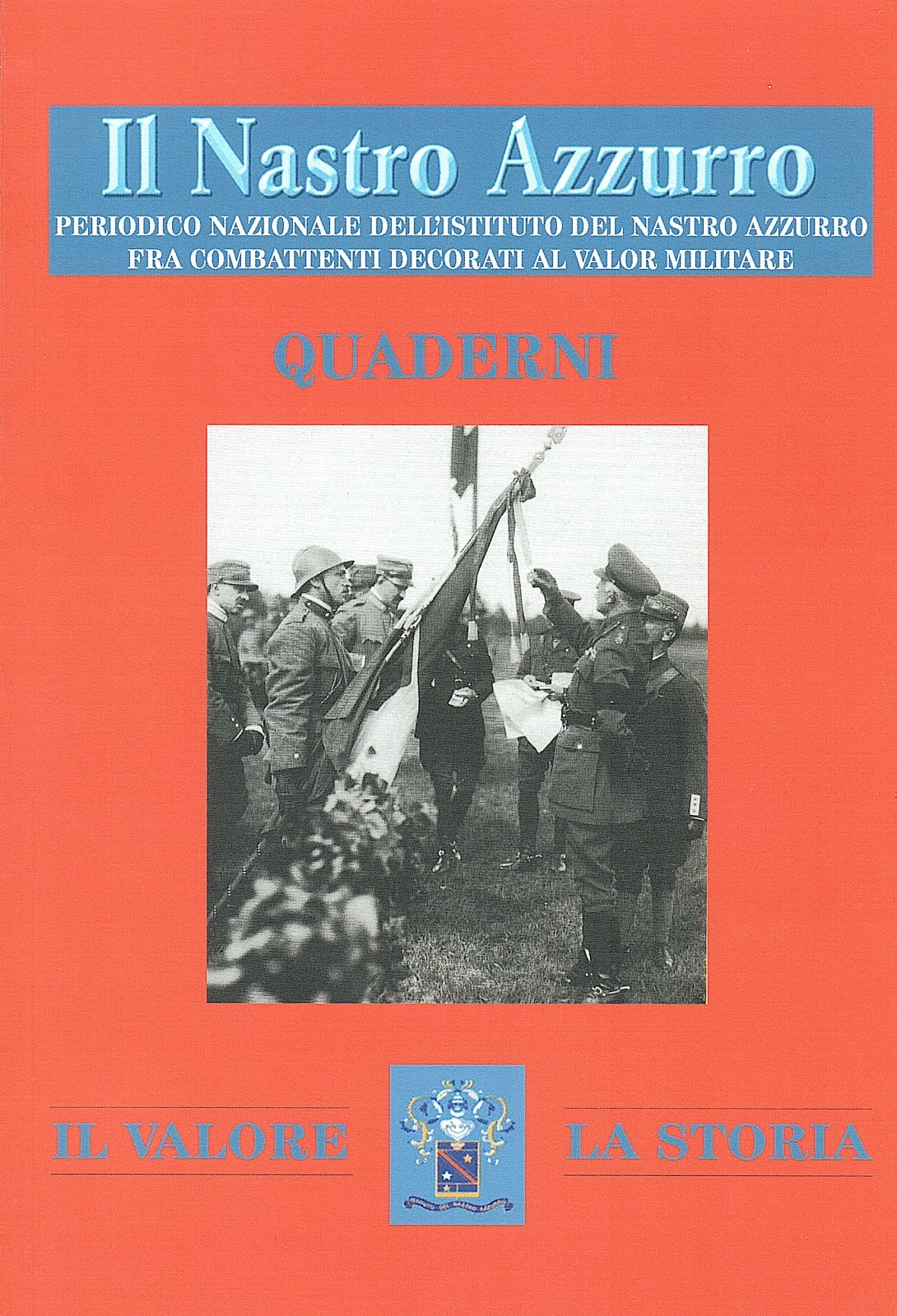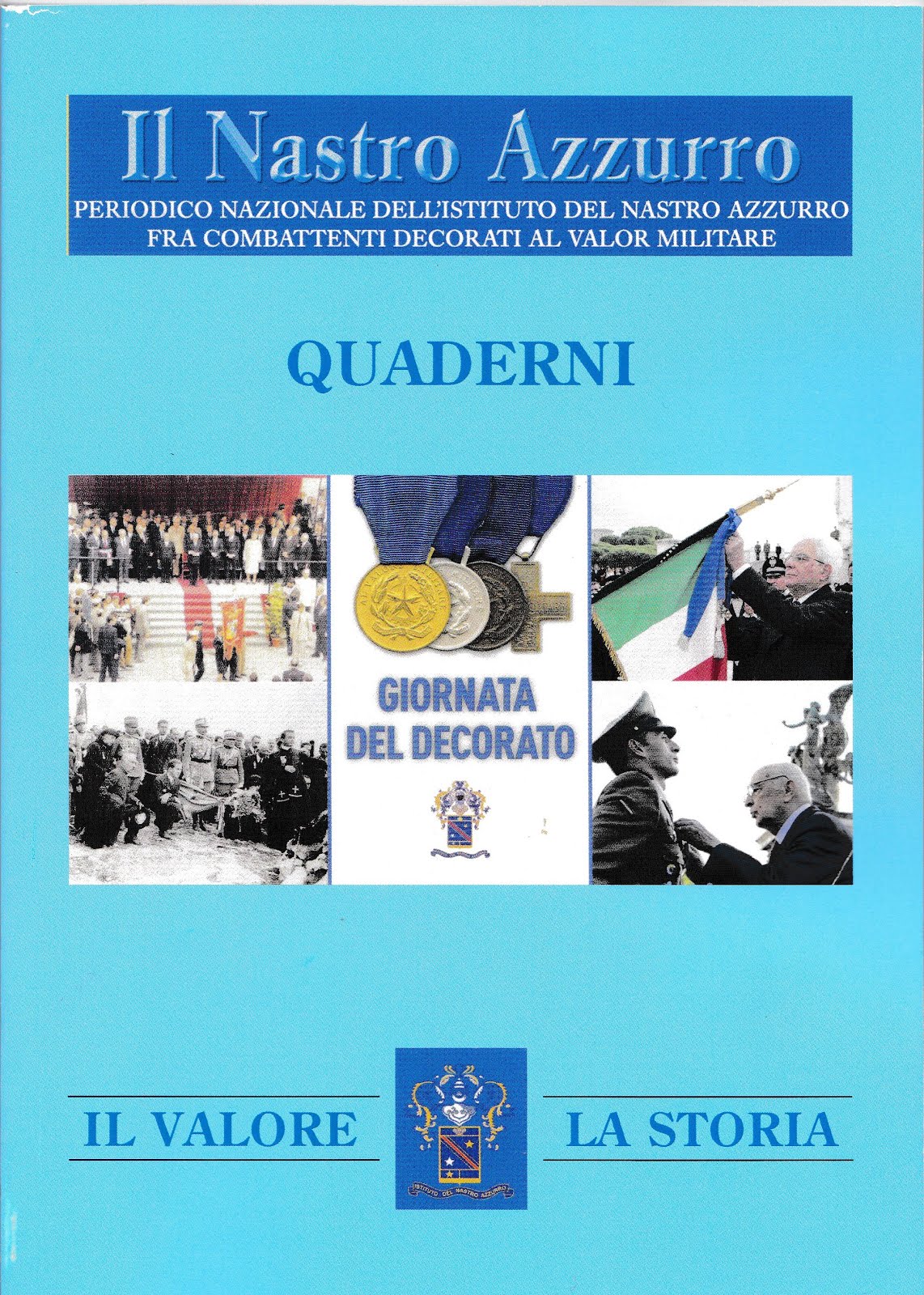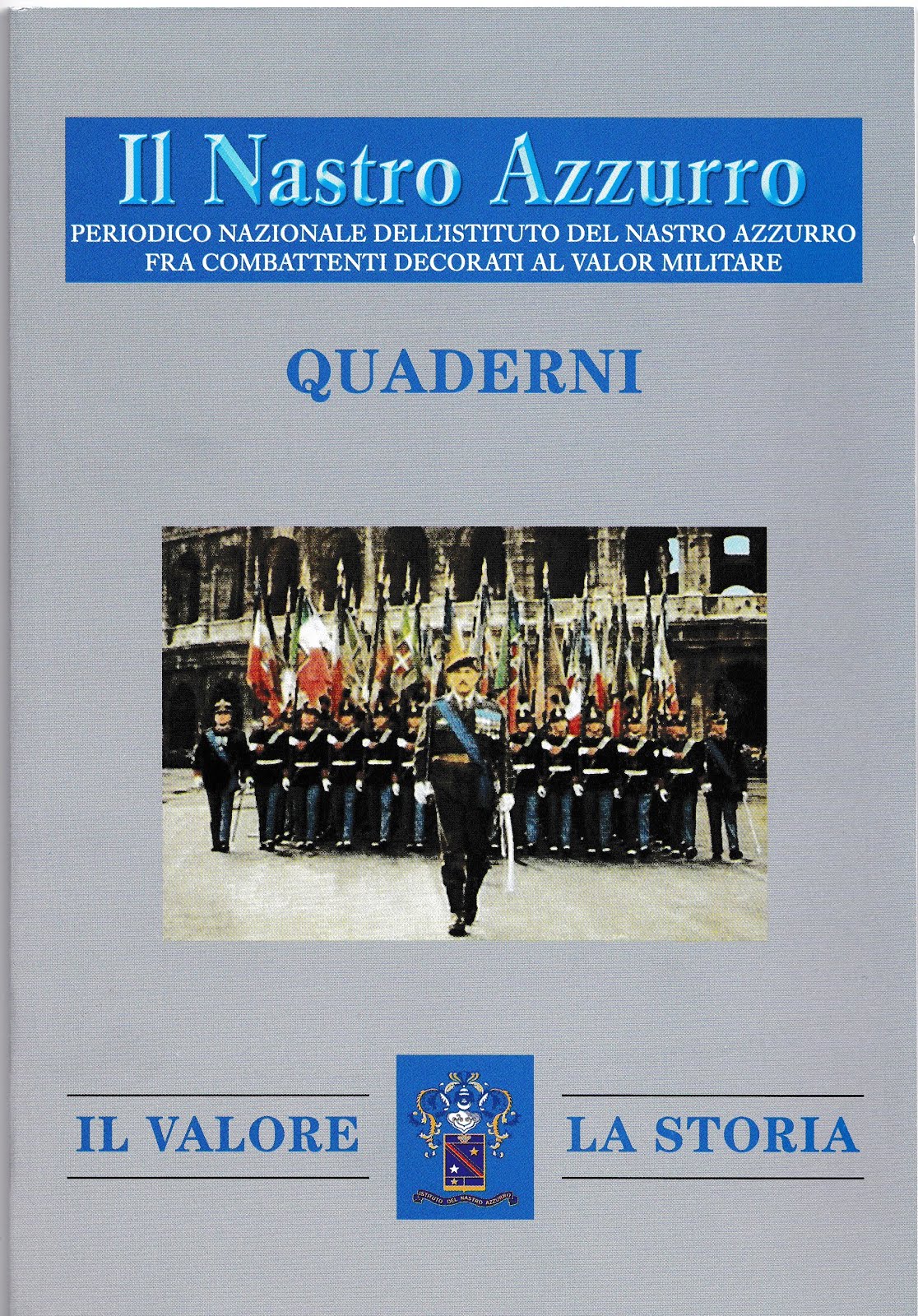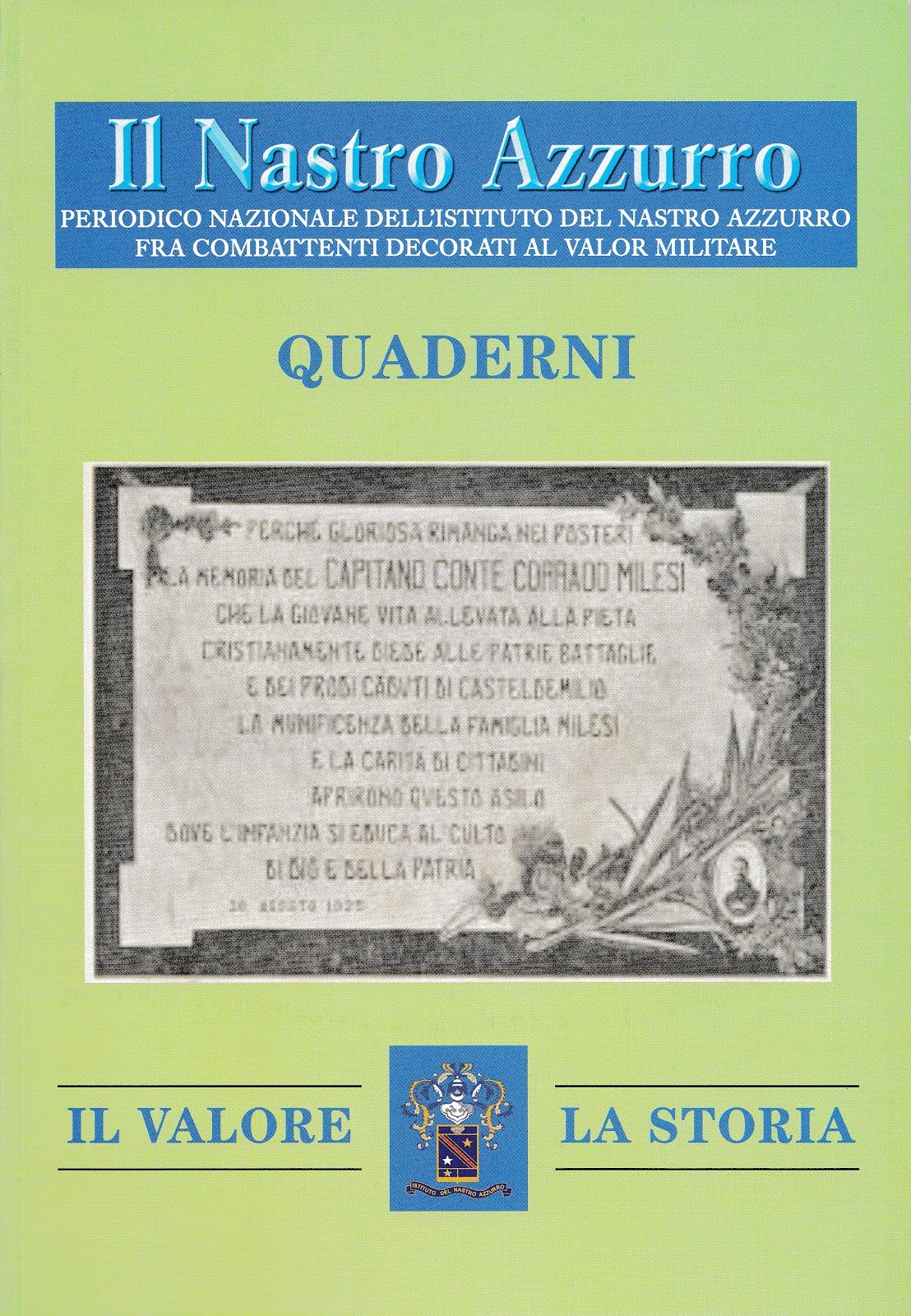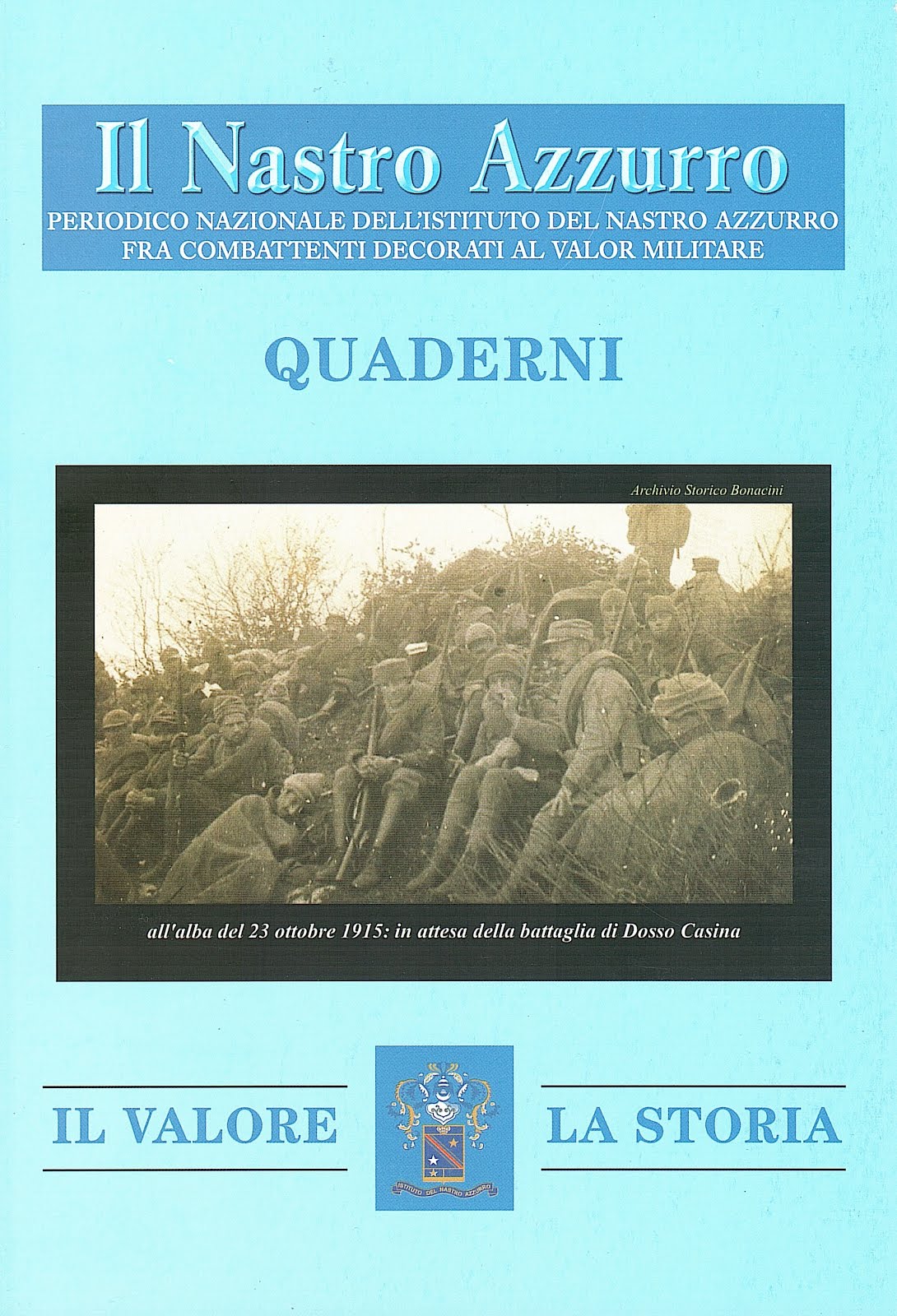“Resistere è vincere”. Potrebbe essere questo il motto di Mariano Rajoy. Il premier spagnolo fa di una tattica pazienza (secondo gli ammiratori) o di un deleterio immobilismo (secondo i detrattori) la caratteristica della sua azione politica. Un atteggiamento che stride, nella politica spagnola, tipicamente assertiva e aggressiva. “Resistere è vincere”. Potrebbe essere questo il motto di Mariano Rajoy. Il premier spagnolo fa di una tattica pazienza (secondo gli ammiratori) o di un deleterio immobilismo (secondo i detrattori) la caratteristica della sua azione politica. Un atteggiamento che stride, nella politica spagnola, tipicamente assertiva e aggressiva.
Ma a Rajoy è stato utile. Nel 2004 e nel 2008, da delfino di José Maria Aznar, perse due volte le elezioni contro il socialista Zapatero; ma la grossa fronda che voleva la sua testa finì per scomporsi prima che Rajoy cedesse.
Durante il suo mandato al governo (2011-2015), una serie di scandali devastarono il partito e colpirono la sua cerchia: l’opinione pubblica, la minoranza interna, perfino i giornali più vicini invocarono le sue dimissioni; finché infine si tornò a parlare d’altro.
E tra il 20 dicembre 2015 e il 26 giugno 2016, le ultime due elezioni politiche: chiuse le prime senza che nessuno avesse la maggioranza, Rajoy si tirò fuori dalle trattative di governo. Sembrò un errore grossolano: il Partido Popular, Pp, era pur sempre la prima forza, non voleva usare la sua posizione di potenza? Ma gli altri tre partiti, nonostante sei mesi di discussione, non riuscirono a trovare un accordo. Il 26 giugno, ripetizione elettorale, gli spagnoli diedero ragione a Rajoy, portando il suo Pp dal 28 al 33% con settecentomila voti in più.
Ma Rajoy, per il momento, è un premier in sospeso. Neanche così il Pp ha la maggioranza, e deve accordarsi con uno degli altri partiti: nessuno di questi, però, vuole apparire quello che consente la riconferma del vecchio primo ministro. Escludendo Pablo Iglesias - il leader della nuova sinistra di Podemos è estraneo a qualsiasi idea di coalizione con il Pp - Rajoy deve ora vedersela con due rivali.
Il meno pericoloso è Albert Rivera: il fondatore di Ciudadanos - nuovo centrodestra liberale - conta sul 13% dei voti. Da dicembre a giugno una parte dei suoi elettori è tornata al Pp: se Rivera ora appoggiasse Rajoy, sembrerebbe un po’ come una ruota di scorta; smentirebbe il suo messaggio di rinnovamento e, implicitamente, sancirebbe l’inutilità del suo partito.
Tuttavia - è questo che indebolisce Rivera - Rajoy può fare a meno del suo sostegno: i seggi di Ciudadanos non sono decisivi, perché per arrivare alla maggioranza servono quelli dei socialisti.
Podemos, nessun sorpasso
Ed è proprio Pedro Sánchez l’antagonista più insidioso. Il 44enne Sánchez è salito dal nulla alla segreteria del Psoe grazie a un accordo tra notabili e rappresentanti del Sud (la cassaforte elettorale socialista). Questi cercavano un giovane, a tempo determinato, che arginasse a sinistra Podemos: nessuno dei big voleva metterci la faccia di persona dato il momentaccio del partito, indebolito dalle conte interne e dall’eredità della gestione Zapatero - che coincise con lo scoppio della crisi economica.
“Il movimento è vita” potrebbe essere il motto di Sánchez. Dopo il brutto risultato di dicembre (Psoe al 22%, minimo storico, solo un paio di punti sopra Podemos) il “fronte del Sud”, guidato dalla presidenta dell’Andalusia Susana Díaz, sembrava sul punto di liberarsi di lui per procedere verso la grande coalizione con il Pp, soluzione preferita anche dal dominus Felipe González, premier dal 1982 al 1996.
Ma Sánchez, inaspettatamente, prese le redini delle trattative, sfornando proposte di alleanza con Podemos, con Ciudadanos, con entrambi: sfruttando al meglio la posizione dei socialisti (deboli, ma numericamente necessari a ogni combinazione di governo), costrinse all’angolo i suoi nemici interni. Sembrò dire: “se volete la grande coalizione con Rajoy - soluzione mai vista in Spagna, dove popolari e socialisti sono da sempre acerrimi opposti - dovrete prendere posizione apertamente”.
Il partito non osò disarcionarlo, forse sperando che ci avrebbero pensato gli elettori: i sondaggi, infatti, pronosticavano per giugno il sorpasso da parte di Podemos non riuscito a dicembre, col Psoe ridotto a terzo partito. Invece, sorpresa: niente sorpasso, nonostante Podemos avesse aggiunto alla sua scuderia eterogenea anche la sinistra radicale di Izquierda Unida.
Sánchez e Rajoy in attesa dello scontro
Ora, dunque, Sánchez e Rajoy, con le loro strategie e motivazioni differenti, si trovano uno di fronte all’altro, come in un torneo medievale, in attesa dello scontro. Sánchez - abbiamo elencato i motivi - si rifiuta di offrire a Rajoy i seggi che gli servono per formare un governo. Rajoy risponde con la minaccia fine-di-mondo: “niente accordo? Allora rivotiamo per la terza volta a novembre, e tu e il tuo partito sarete spazzati via: dopo un anno senza governo, gli elettori mi daranno la maggioranza assoluta”.
Molti, tra i socialisti, temono che Rajoy abbia ragione, e che non ci sarà un secondo miracolo elettorale come quello che ha scongiurato il sorpasso di Podemos: tenteranno di obbligare Sánchez a più miti propositi. Ma per il segretario del Psoe la corda deve restare tesa: elezioni in novembre significa rinvio del congresso del partito, cioè della possibilità di essere fatto fuori; significa anche tenere a bada Podemos proponendosi come punto di riferimento della sinistra, senza dubbio contro il Pp.
La pazienza invece potrebbe favorire ancora una volta Rajoy: se i tempi si allungano, fino a dopo le elezioni basche di ottobre, prima delle quali i partiti locali non si schierano, il capo del Pp potrebbe puntare sul Partito nazionalista basco: ha cinque soli seggi che però, con quelli di Ciudadanos, renderebbero superfluo l’accordo coi socialisti.
Chi la spunterà? Sánchez, per evitare la resa dei conti elettorale, può anche provare a formare una coalizione di sinistra con Podemos, nazionalisti baschi e catalani; opzione remota, ma non impossibile. “Quando fai una minaccia, sii sicuro di avere i mezzi per portarla a termine”: questa massima di Machiavelli è stata traslata dal commentatore Enric Juliana all’attuale situazione spagnola. Solo una cosa è certa: tra i due concorrenti del torneo, ora in corsa uno contro l’altro, uno finirà irrimediabilmente disarcionato.
Riccardo Pennisi è collaboratore di Limes, Ispi, Il Mattino e coordinatore delle tematiche europee presso Aspenia.
|