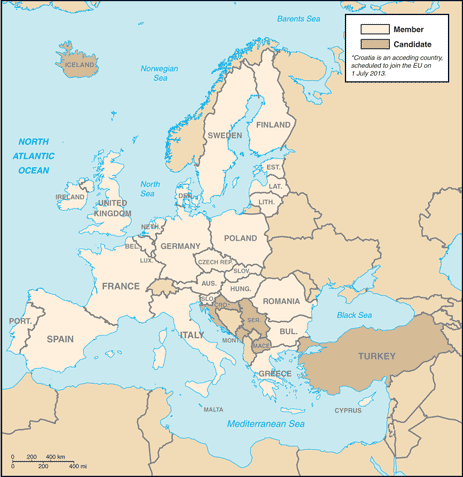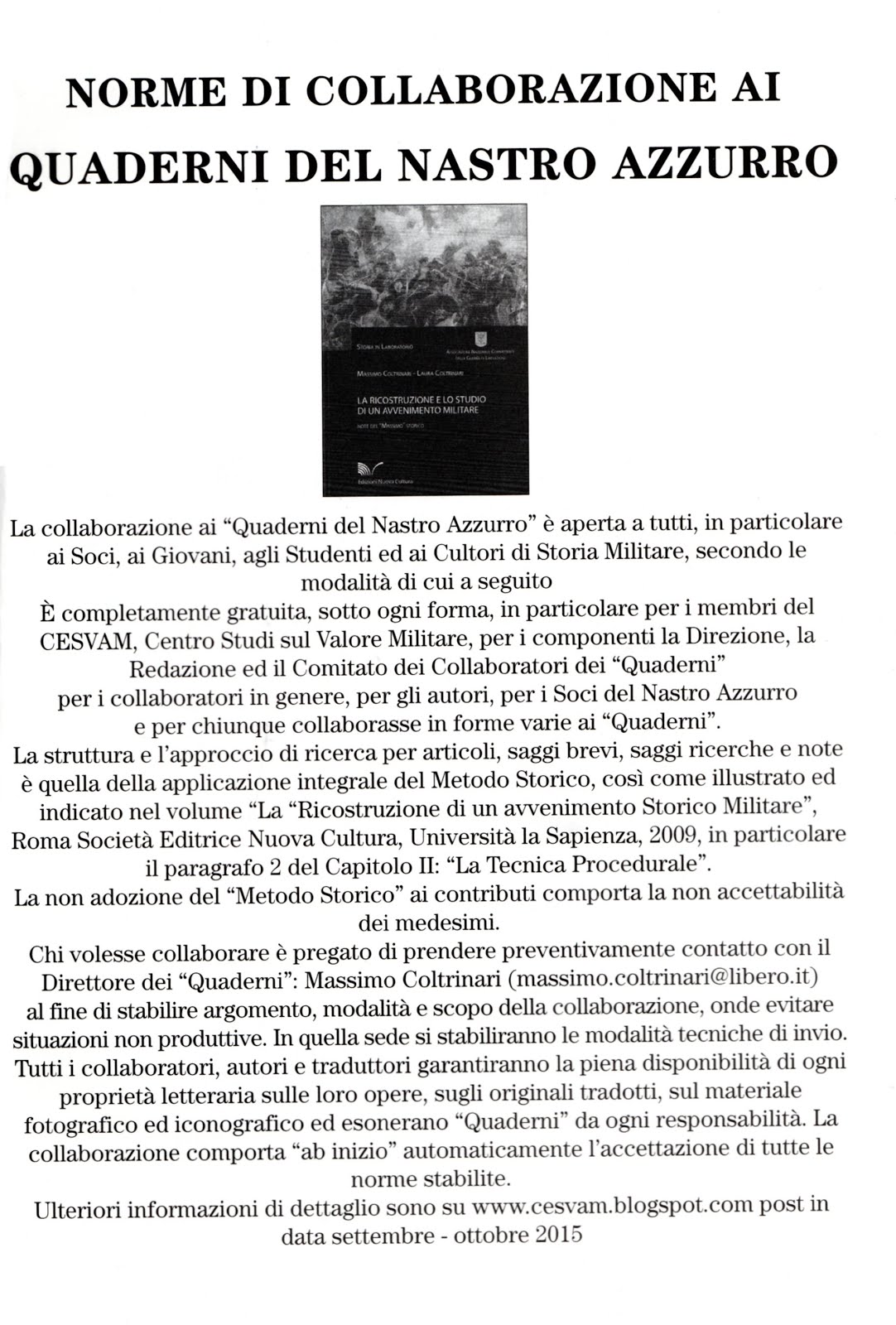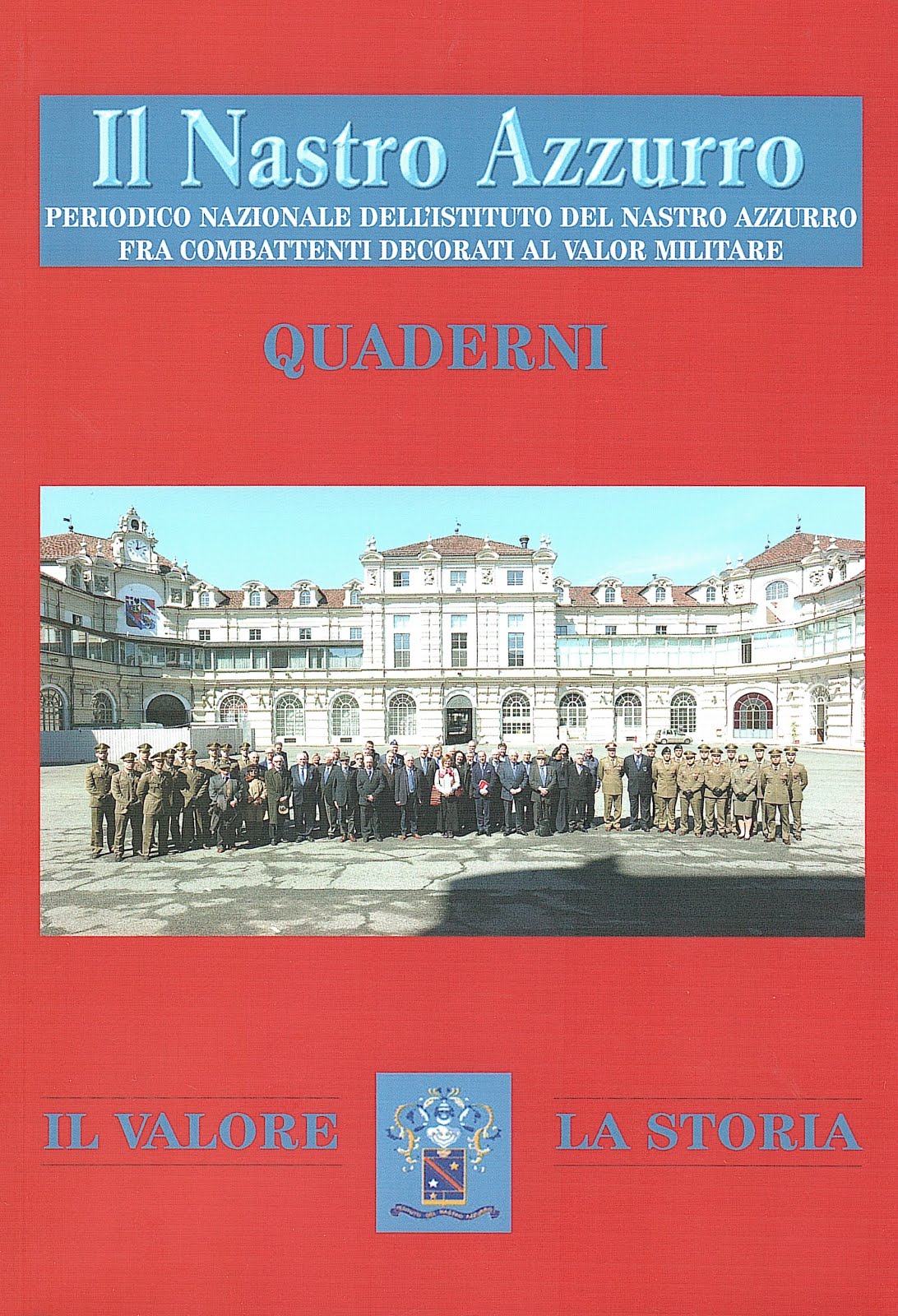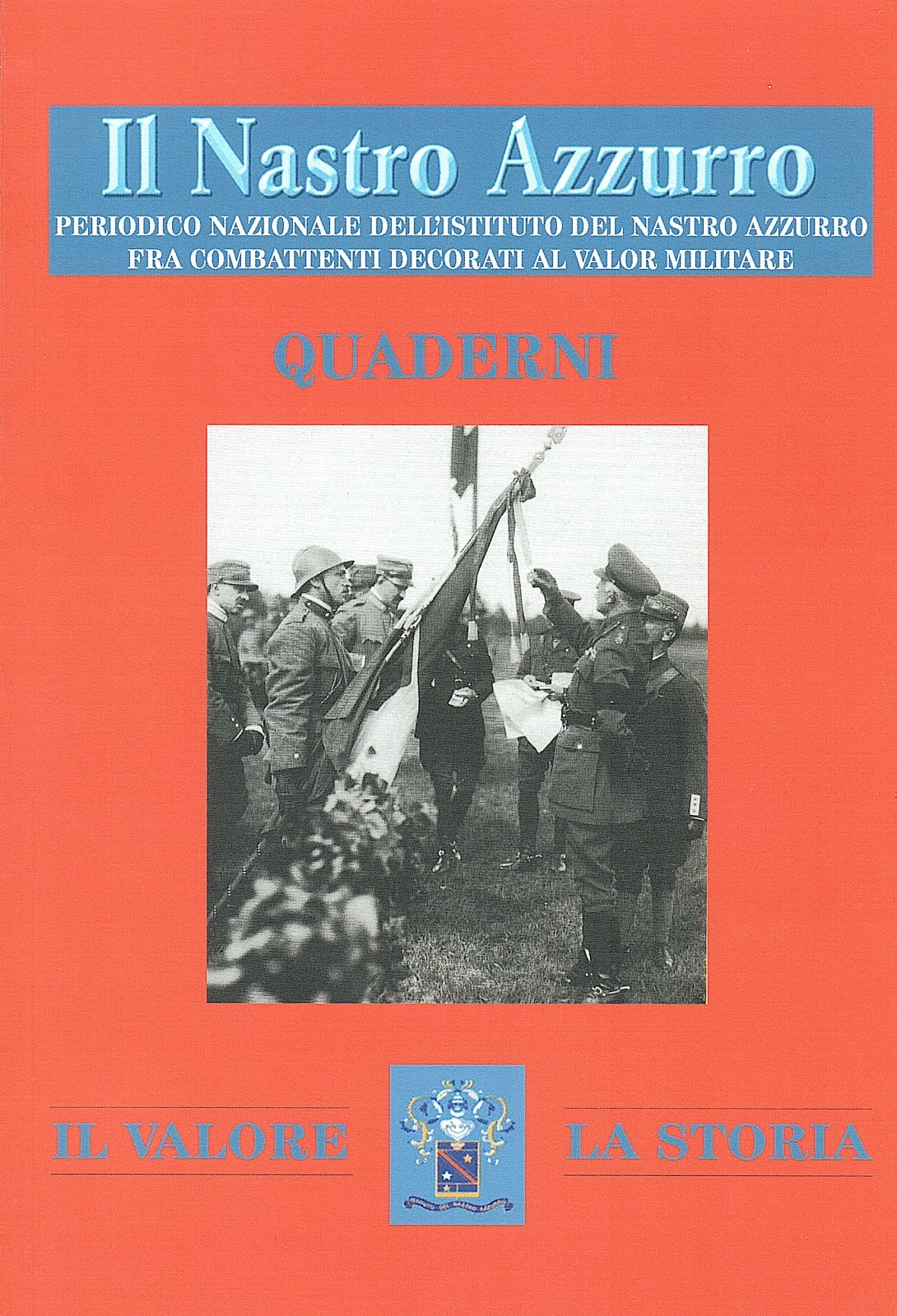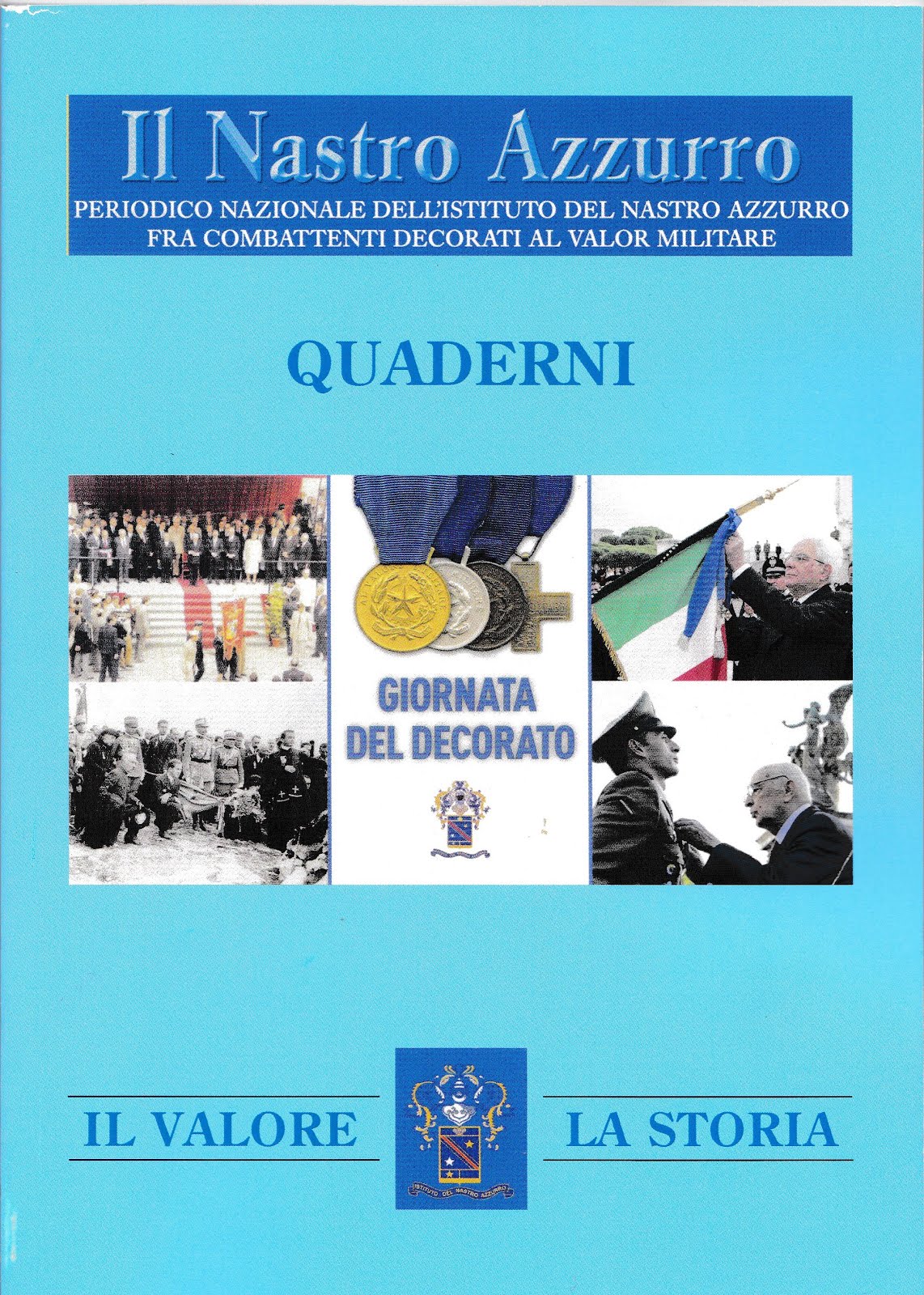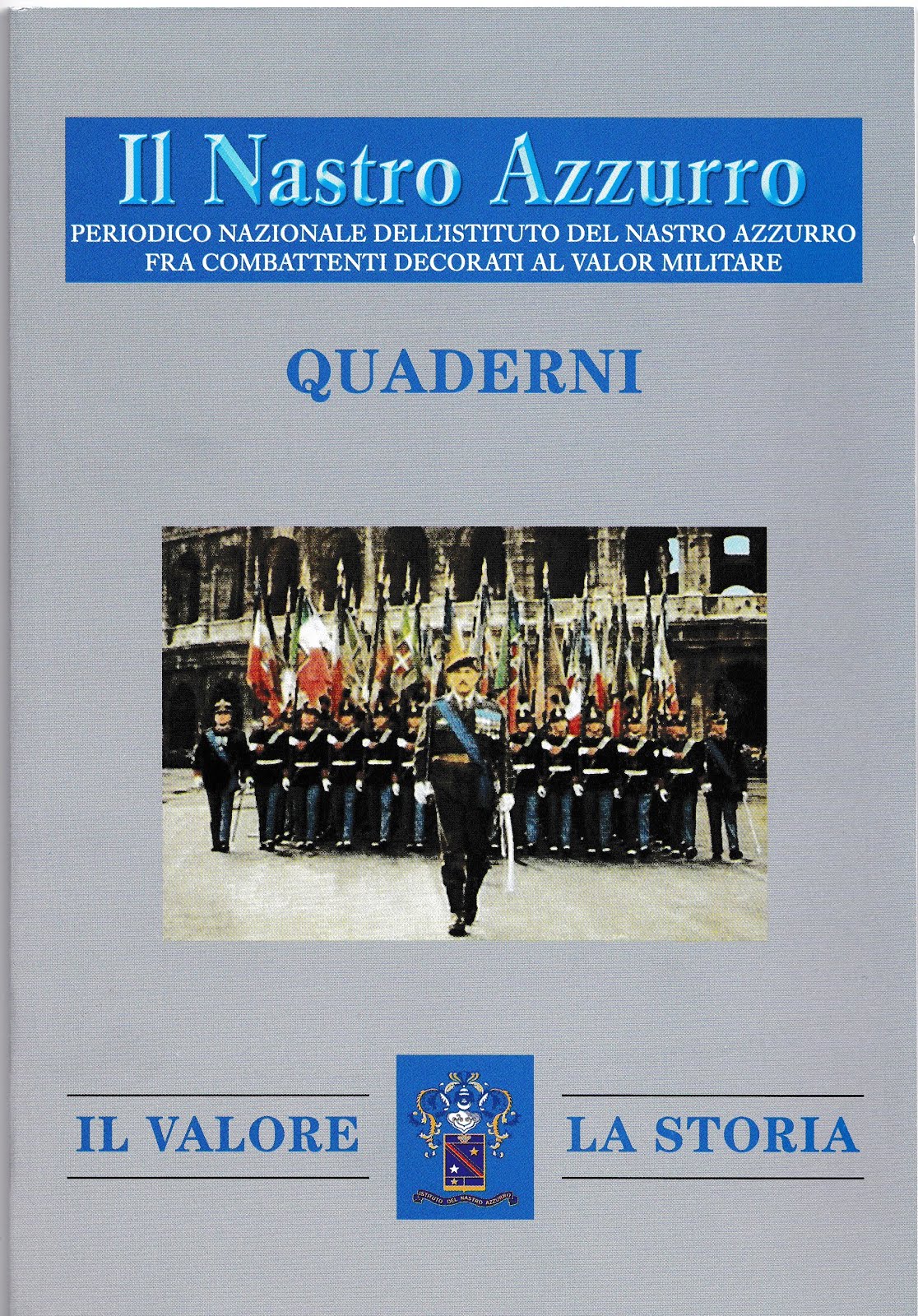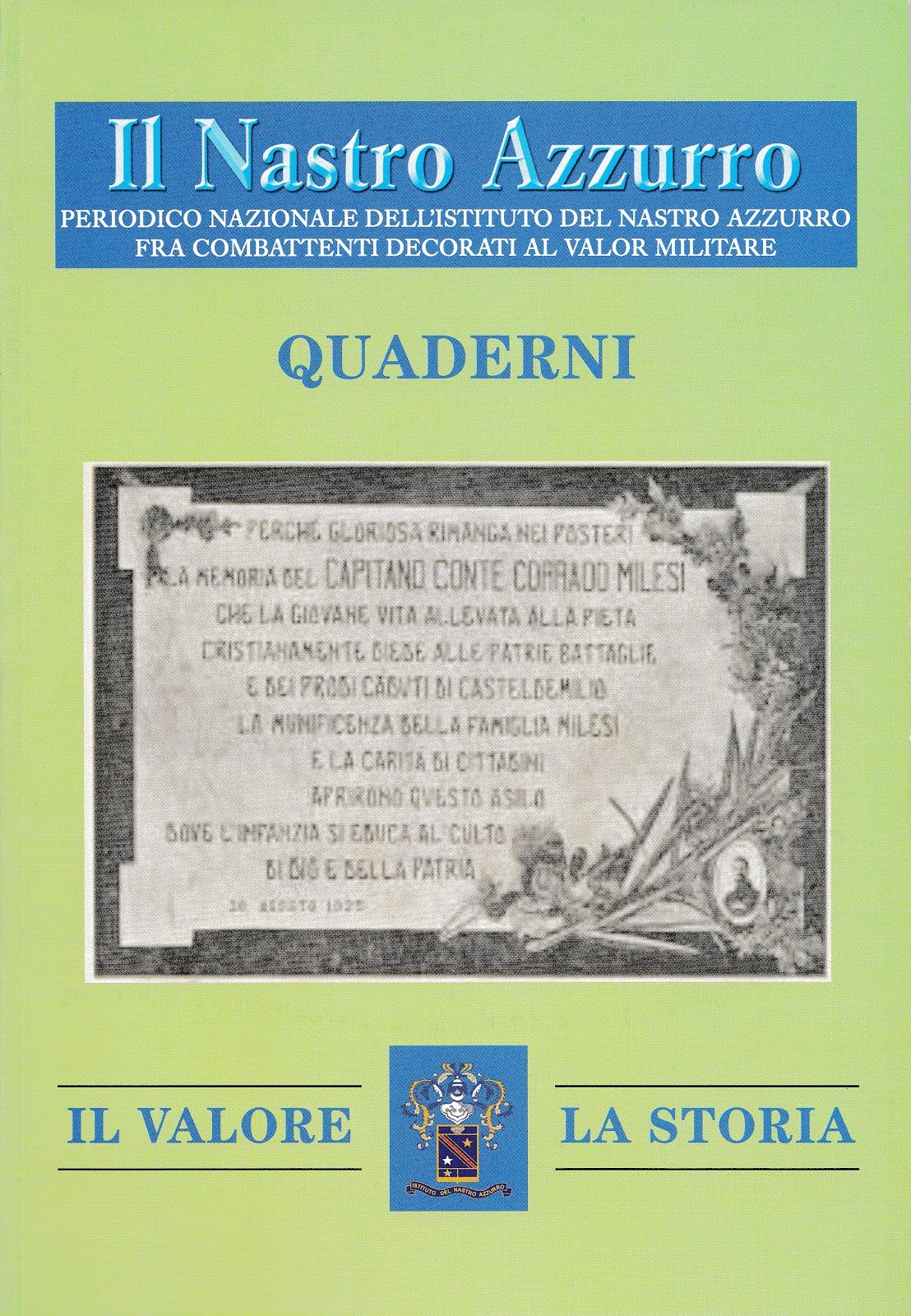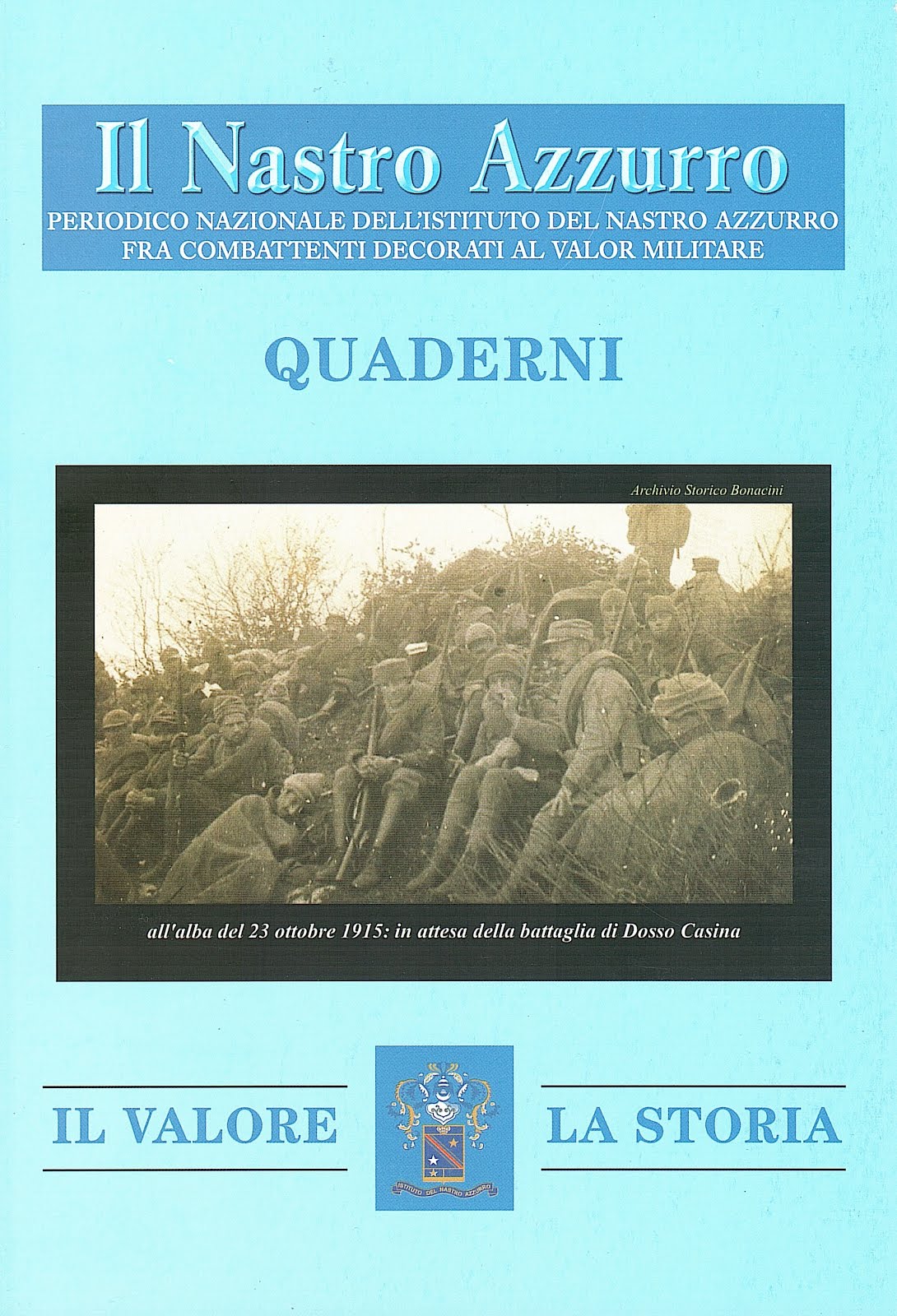| Roam-like-at-home Roaming: un risultato concreto per rilanciare l’Unione Federico Palmieri 25/06/2017 |
|
 Grazie alle nuove regole Ue, dal 15 giugno 2017 i cittadini europei non pagano più sovrapprezzi se utilizzano il proprio cellulare in un altro Stato membro. È finalmente andato a pieno regime il Regolamento “Roam-like-at-home”, varato nella sua ultima versione a fine 2015 da Parlamento europeo e Consiglio, che ha sancito l’abolizione dei costi di roaming nei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Grazie alle nuove regole Ue, dal 15 giugno 2017 i cittadini europei non pagano più sovrapprezzi se utilizzano il proprio cellulare in un altro Stato membro. È finalmente andato a pieno regime il Regolamento “Roam-like-at-home”, varato nella sua ultima versione a fine 2015 da Parlamento europeo e Consiglio, che ha sancito l’abolizione dei costi di roaming nei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.“Roam-like-at-home”
Dopo una progressiva riduzione dei costi di roaming iniziata nel 2015, con il 15 giugno si giunge alla totale parificazione delle tariffe per chiamate e messaggi: telefonare a Roma da Parigi costerà quanto farlo da Milano. Per il traffico dati, il periodo transitorio giungerà a termine solo nel 2018, ma già da oggi le tariffe sono praticamente parificate e le offerte nazionali che prevedono l’acquisto di un pacchetto di dati sonogià valide e utilizzabili.
Rimangono alcune eccezioni. Le nuove regole sul roaming si applicano agli utenti che utilizzano la propria Sim all’estero per brevi periodi, meno di quattro mesi all’anno: è il caso di brevi trasferte di lavoro o di viaggi perturismo. Per chi invece si trasferisce stabilmente in un altro Stato membro e continua a utilizzare la propria Simpermane un sovrapprezzo, la cui entità è però trascurabile. Inoltre, bisogna osservare che non rientrano nelle nuove regole le chiamate effettuate dal proprio Stato verso l’estero, che potranno ancoraessere soggette a maggiorazioni.
Roaming e Mercato unico digitale
L’abolizione dei costi di roaming si inserisce nella strategia per la realizzazione del Mercato unico digitale, una delle 12 priorità annunciate a inizio mandato dalla Commissione guidata da Jean-Claude Juncker. Le potenzialità legate all’instaurazione di un Mercato unico digitale nel territorio dell’Unione sono significative: si parla infatti di un contributo di 415 milioni di euro l’anno all’economia europea e di centinaia di migliaia di posti di lavoro.
Per questo, dall’inizio del suo mandato la Commissione Juncker ha firmato 35 fra proposte legislative e iniziative di carattere politico. In quest’ambito, si sono già registrati i primi successi, tra cui l’accordo sulla portabilità dei contenuti - che permetterà dal 2018 di fruire di abbonamenti a servizi come Netflix e Spotify in tutta l’Unione senza restrizioni - e l’accordo sulla liberalizzazione della banda dei 700 MHz, che permetterà lo sviluppo della tecnologia 5G e di nuovi servizi digitali.
“Roam-like-at-home” si inserisce in questa serie di iniziative. La misura, secondo la Commissione, avrà effetti positivi in numerose aree economiche all’interno dell’Unione. È il caso, primo fra tutti, proprio del mercato delle telecomunicazioni. I dati della Commissione parlano di 300 milioni di potenziali nuovi clienti: si tratta di quel 94% di utenti che, fino ad ora, hanno scelto di non utilizzare il cellulare all’estero per evitare i costi del roaming. Inoltre, la fine dei costi di roaming porterà grandi benefici nell’ambito della app economy e per tutti gli online business, specie quelli legati al settore del turismo. Da non trascurare, inoltre, il risparmio per le aziende con dipendenti che si spostano nel territorio dell’Unione per affari.
Un successo politico concreto
La fine dei costi di roaming è stata salutata dalle istituzioni di Bruxelles con grande entusiasmo. In una dichiarazione congiunta, i presidenti del Parlamento Europeo Tajani, della Commissione Juncker e quello di turno del Consiglio Muscat l’hanno definita “una vera success story europea”. Secondo i tre presidenti, i costi di roaming costituivano un vero e proprio “fallimento del mercato”: la parificazione delle tariffe nel territorio dell’Unione è un “successo concreto e positivo”.
L’entusiasmo pare motivato:“Roam-like-at-home” si prospetta come un traguardo tangibile che avrà un effetto concreto sulla vita di molti cittadini. Si tratta di un risultato che ben si inserisce nel nuovo modo di raccontarsi dell’Unione europea. Dopo un annus horribilis come il 2016, il 2017 potrebbe essere, a sorpresa, l’anno della rinascita. Il reboot iniziato con la Dichiarazione di Roma, firmata dai leader dei 27 in occasione del 60° anniversario dei Trattati, va concretizzandosi con nuovi passi verso una vera difesa comune e una timida ma promettente ripresa economica.
Rinvigorita dalla vittoria delle forze europeiste in Austria, in Olanda e in Francia, l’Unione si sta riscoprendo orgogliosa di sé stessa. Misure come “Roam-like-at-home” possono integrare il quadro, contribuendo grandemente al racconto positivo dell’Ue: dopo una stagione di grandi dibattiti, l’accento torna sugli effetti positivi che le politiche dell’Unione hanno sulla vita di tutti i giorni dei cittadini europei.
Federico Palmieri è tirocinante presso il Programma Sicurezza e Difesa dello IAI, twitter @fed_palmieri.